AIDA (“Interamerican Association for Environmental Defense”) a Durban: cambiamenti climatici e diritti umani in America Latina
SIMONETTA SANDRI*
L’Associazione Interamericana per la Difesa dei Diritti Ambientali (AIDA)1 ha presentato a Durban un interessante Rapporto di 47 pagine relativo ai principali impatti sui diritti umani derivanti dai cambiamenti climatici in America Latina2.
Partendo dalla richiesta del 2008 alla Commissione Interamericana sui Diritti Umani (IACHR), da parte dell’Assemblea Generale dell’Organizzazione degli Stati Americani (OAS), di approfondire il legame fra cambiamenti climatici e diritti umani, il Rapporto prova a delineare i principali impatti dei cambiamenti climatici sui diritti umani in America Latina, fornendo alcune raccomandazioni.
La conclusione generale è che i cambiamenti in questione comportano conseguenze severe sul diritto ad un ambiente sano (peraltro garantito dall’art. 11 del Protocollo di San Salvador), nel deterioramento che essi causano agli ecosistemi dai quali le comunità umane dipendono. Se si consideri, poi, che tale diritto è strettamente connesso ad altri diritti umani, i cambiamenti climatici avranno serie conseguenze anche sui diritti ad una vita dignitosa (garantito all’art. 4 della Convezione Americana sui Diritti Umani), alla salute, al cibo, all’acqua e ad un adeguato alloggio.
Gli Stati hanno un’obbligazione positiva di proteggere e di garantire i diritti umani delle persone sotto la propria giurisdizione e devono utilizzare tutti i mezzi a propria disposizione per evitare attività dannose all’ambiente, quali l’inquinamento.
Gli impatti dei cambiamenti climatici sono particolarmente severi per le popolazioni socialmente marginalizzate – quelle più povere, donne, bambini e gruppi etnici minori – perché maggiormente dipendenti dai sistemi naturali impattati, tanto a livello di sussistenza che culturale-religioso.
I principali impatti identificati ed analizzati riguardano pertanto:
• La perdita di risorse idriche potabili
Attualmente, oltre 71 milioni di persone in America Latina (circa il 14% della popolazione) non ha accesso ad acqua di qualità e oltre 22 milioni vivono in zone “a stress idrico”. Si stima che entro il 2025, ulteriori 77 milioni potrebbero soffrire di carenza idrica a causa dei cambiamenti climatici della regione, numero che potrebbe raddoppiare ancora nel 2055.
Tali impatti comporteranno serie conseguenze non solo sul diritto all’accesso all’acqua ma anche sui diritti al cibo, alla salute ed alla vita in generale.
I ghiacciai andini, ad esempio, si sono drammaticamente ridotti fin dagli anni Settanta, in un trend strettamente legato all’aumento delle temperature. Gli scienziati del clima ritengono che entro il 2050 oltre 50 milioni di persone nella regione andina saranno colpiti da tale perdita di acqua utilizzata a scopi potabili, di irrigazione, igienici e di approvvigionamento energetico. Va ricordato, inoltre, che oltre il 90% dell’agricoltura in America Latina non è irrigato e che è pertanto molto vulnerabile ai cambiamenti delle precipitazioni o all’aumento del fenomeno erosivo.
• Gli uragani e le alluvioni
Il Continente ha recentemente sofferto di alluvioni inusuali estreme. Ad esempio, nel 2008, oltre 300.000 persone sono rimaste senza tetto durante alcune alluvioni devastanti in Brasile, in Colombia il fenomeno ha colpito oltre 2 milioni di persone con l’uragano del 2010, il più devastante degli ultimi 40 anni, ed è costato oltre 300 milioni di dollari in aiuti di emergenza.
• L’aumento dei livelli del mare
Il riscaldamento delle temperature oceaniche ha comportato un importante declino nelle alghe marine che formano la base degli ecosistemi. La conseguenza è stata la distruzione di oltre l’80% delle barriere coralline caraibiche, base fondamentale della crescita ittica.
• L’aumento delle malattie di origine idrica
L’aumento del fenomeno alluvionale e delle temperature comporta un’importante diffusione di malattie di origine idrica. L’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) stima che nel 2000 gli eventi legati ai cambiamenti climatici abbiano ucciso circa 154.000 persone nel mondo a causa di malattie quali diarrea, malaria e malnutrizione.
Alcuni studi scientifici stimano che da qui al 2030 l’America Latina possa conoscere un aumento del rischio di malaria legato ai cambiamenti climatici fino al 28%.
In generale, le popolazioni maggiormente vulnerabili sono sicuramente quelle più povere, svantaggiate economicamente e culturalmente, quelle che dipendono maggiormente dalle risorse naturali per il loro sostentamento e che ad esse sono legate per cultura, religione e tradizione. Si pensi a popolazioni indigene o a comunità tradizionali che vivono del legame speciale fra il loro territorio e le risorse naturali, perché il loro sostentamento è basato su coltivazione, caccia, pesca.
Dopo tali analisi, il Rapporto si conclude con alcune raccomandazioni a Stati, organizzazioni intergovernative ed a istituzioni finanziarie internazionali.
Le raccomandazioni rivolte agli Stati riguardano pertanto la necessità di: cooperare per adottare impegni internazionali obbligatori, effettivi ed equi per prevenire ulteriori cambiamenti climatici; lavorare per ridurre al massimo il contributo umano a tali cambi; rivedere le attuali politiche energetiche al fine di includervi maggiori fonti di energia rinnovabile; condurre una completa analisi dei possibili impatti dei cambiamenti climatici sui diritti umani; assicurare un’effettiva partecipazione delle parti interessate ed un accesso all’informazione effettivo.
Alle organizzazioni inter-governative viene, invece, chiesto di riconoscere il legame cambiamenti climatici-diritti umani e di impegnarsi alla promozione di accordi internazionali vincolanti.
Alle istituzioni finanziarie internazionali, alle banche nazionali di sviluppo ed ai fondi sovrani, infine, viene richiesto di incorporare obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici nelle politiche di finanziamento – al fine di evitare di sovvenzionare progetti che contribuiscano ai cambiamenti climatici – e di adottare una prospettiva diritti umani nelle politiche di investimento.
* Environment manager presso Eni exploration & production – SEQ – AMTE.
1 Fondata nel 1998, AIDA è un’organizzazione di diritto ambientale che protegge gli ecosistemi minacciati e le comunità umane da esso dipendenti. Sito web: http://www.aida-americas.org/
2 Il Rapporto si trova in http://www.aida-americas.org/en/node/1761
3 Il Rapporto precisa che la lista dei potenziali effetti sui diritti umani non vuole essere esaustiva ma che trattasi di quelli maggiormente noti ed identificabili. Esso si concentra poi su quelli primari e non analizza i secondari come quelli potenziali di conflitti derivanti dalla diminuzione delle risorse.
Pubblicato su Osservatorio AD il 20/12/2011
L’Agenzia Internazionale per l’Energia ed il Worldwide Energy Outlook 2011.
SIMONETTA SANDRI*
L’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE) ha recentemente adottato il Worldwide Energy Outlook (WEO), che descrive i trend energetici e climatici mondiali in un momento di scenari preoccupanti tanto da un punto di vista economico-finanziario che, conseguentemente, ambientale.
Già l’esordio – “se non cambiamo presto direzione, finiremo esattamente dove siamo diretti” – dà un’idea delle problematiche che il sistema energetico mondiale si troverà ad affrontare da qui al 2035. Certamente vi saranno anche delle opportunità da cogliere, ma l’analisi si mantiene preoccupante. In particolare, va rilevato come nel 2010 la domanda di energia primaria sia tornata a crescere del 5%, spingendo le emissioni di CO2 a nuovi massimi storici. Nonostante ciò, il numero di persone ancora senza accesso all’energia elettrica rimane alto, 1,3 miliardi, ovvero circa il 20% dell’attuale popolazione mondiale. Situazioni come quella di Fukushima o delle rivoluzioni del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA) hanno poi risollevato dubbi sulla sicurezza ed affidabilità delle forniture energetiche.
Per ritornare al contenuto del rapporto, esso indica che si dovrebbe passare dallo scenario Politiche Attuali – scenario di riferimento con le misure che i vari governi hanno adottato fino a metà 2011 – a quello Nuove Politiche, in cui si considerano tutti gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra derivanti dalle misure di cui agli accordi di Cancun, G-20 e APEC da qui al 2020, per arrivare allo Scenario di Stabilizzazione entro il 2035, che porta ad un percorso energetico coerente con l’obiettivo di limitare l’aumento a lungo termine della temperatura media globale terrestre entro i 2 C°.
In un quadro internazionale complesso ed a più velocità va rilevato, infatti, che i Paesi che aderiscono al protocollo di Kyoto coprono solamente il 20% degli schemi di riduzione previsti e che restano ancora escluse le grandi economie consolidate, come quella statunitense, e quelle emergenti dei c.d. BRIC (Brasile, Russia, India e Cina). Emissioni di gas ad effetto serra e ciclo economico sono e restano strettamente correlate. La Cina, in particolare, che consolida la sua posizione di maggior consumatore mondiale di energia1, per quanto abbia volontariamente deciso di ridurre la propria intensità energetica, non vuole assoggettarsi a vincoli internazionali. Il ruolo critico dei governi nel delineare il futuro energetico resta la pietra miliare di ogni riflessione ed evoluzione sul tema.
Ora, per entrare un po’ di più nei dettagli del rapporto in questione, esso si articola in 4 sezioni.
Nella prima vengono descritti i trend energetici mondiali dal lato della domanda e dell’offerta e le implicazioni in termini di investimenti ed emissioni di CO2. I vari capitoli sono dedicati alle singole fonti energetiche: petrolio, gas, elettricità e rinnovabili. La fine del petrolio a buon mercato (si stima un costo al barile di oltre 210 dollari nominali al 2035) caratterizza uno degli elementi principali dei futuri scenari energetici mondiali, unitamente ad un’attesa età dell’oro del gas. Dall’area MENA deriverà il 90% dell’incremento di offerta2, mentre sul fronte gas, la fonte fossile più pulita, si ipotizza un aumento del consumo in tutti e tre gli scenari descritti.
La seconda sezione e’ incentrata sulla Russia e in particolare sulle criticità e prospettive del suo settore energetico, alla luce di vaste risorse ed enorme potenziale. Vengono analizzati i settori del petrolio, del gas e del non-convenzionale con i relativi trend.
La terza sezione viene invece dedicata al carbone, combustibile maggiormente abbondante al mondo con riserve equivalenti a 150 anni di produzione. Il suo utilizzo salirà al 65% nel 2035.
Conclude il rapporto la quarta sezione, dedicata a tre temi speciali: il c.d. “low nuclear case” (conseguenze di un rallentamento dell’utilizzo del nucleare), il tema degli investimenti necessari per l’accesso alle moderne forme di energia da parte delle popolazioni più povere ed un’analisi sui sussidi alle fonti fossili e gli incentivi alle energie rinnovabili, con conseguente impatto sulle dinamiche energetiche, economiche ed ambientali mondiali3.
In generale, la quota del rinnovabile, idroelettrico escluso, nella generazione elettrica mondiale cresce dal 3% nel 2009 al 15% nel 2035, sostenuta da sussidi annuali che aumentano a 180 miliardi di dollari, ossia di quasi 5 volte. Cina ed Unione Europea guidano l’espansione di tali fonti, contribuendo a circa il 59% della crescita totale.
In termini di accesso all’energia, infine, l’obiettivo finale dovrebbe essere quello di pervenire all’accesso universale entro il 2030, per cui sarà necessario investire circa 48 miliardi di dollari l’anno. In tale direzione, le Nazioni Unite hanno definito il 2012 come l’”Anno Internazionale dell’Energia Sostenibile per Tutti” e il vertice Rio + 20 rappresenterà un’importante opportunità per muoversi in tale direzione.
* Environment manager presso Eni exploration & production – SEQ – AMTE.
1 Da qui al 2035, essa consumerà energia per circa il 70% in più degli Stati Uniti.
2 In generale si stima un aumento della domanda di petrolio da 87 milioni di barili / giorno nel 2010 a 99 milioni di barili / giorno nel 2035, dovuto, per la maggior parte ad un aumento proveniente dal settore trasporti delle economie emergenti.
3 Una serie di allegati correda il rapporto, contenenti i dati relativi ai trend energetici globali (parte A), un panorama sui trend russi (parte B), uno sul mercato del carbone (parte C) ed uno sui temi speciali (parte D).
Pubblicato su Osservatorio AD il 20/12/2011
Edizione 2011 del Rapporto WWF-Ecofys “Climate Policy Tracker” (CPT): Europa bocciata in materia di clima ed energia.
SIMONETTA SANDRI*
Il 1° dicembre 2011, WWF ed Ecofys1 hanno pubblicato l’edizione 2011 del Rapporto “Climate Policy Tracker” (CPT)2 che, redatto utilizzando informazioni pubblicamente disponibili, analizza nel dettaglio le politiche adottate dagli Stati europei in materia di energia e cambiamento climatico.
Si tratta di 33 pagine dense di informazioni, che si propongono di misurare tutti i settori che influenzano le emissioni di gas a effetto serra all’interno dell’Unione europea, come la politica climatica generale, la fornitura di energia elettrica, l’industria, l’edilizia, i trasporti, l’agricoltura e la silvicoltura.
Il giudizio complessivo emerso è abbastanza negativo, bocciature per molti, Italia inclusa, per la mancanza di una strategia a lungo termine. Punto davvero critico se si considera che proprio ora è in corso il vertice ONU di Durban sui cambiamenti climatici, che, peraltro, stenta a mettere molti Paesi d’accordo (circa 200, per la precisione).
Se si considera poi che, affinché i cambiamenti climatici non diventino irreversibili, è necessario mantenere la temperatura della terra al di sotto dei 2 C° rispetto ai livelli pre-industriali 3 e si prende come obiettivo quello, più volte annunciato a livello europeo, della de-carbonizzazione entro il 2050, emerge come l’Unione Europea non stia facendo abbastanza in materia di clima e di energia. Né, in sede di negoziati di Durban, sembra che essa stia prendendo una vera posizione da leader sui temi delicati in questione. Posizione invocata da più parti.
Le valutazioni del Rapporto CPT vengono attribuite secondo una scala dalla lettera A alla G (dove G è il voto più basso): ne emerge che la media generale delle politiche climatiche europee corrisponde alla E: un dato deludente e sconfortante che coincide con la media italiana.
Il rapporto attribuisce un voto ad ogni Stato europeo per le proprie politiche climatiche ed energetiche, valutando ogni singolo settore dell’economia nazionale (dalla fornitura di elettricità, all’industria, fino agli edifici, ai trasporti, all’agricoltura ed alla silvicoltura), ciascuno analizzato secondo le due macroaree di energie rinnovabili ed efficienza energetica.
Secondo i dati raccolti, la situazione si presenta come stazionaria in molti Paesi che ancora hanno scarsa attenzione e visione di azioni a lungo termine. Tra i Paesi più “virtuosi” emergono Danimarca e Germania (con una D), tra i mediocri la Francia, con una E. In discesa invece, l’Irlanda che si allontana dalla sua D.
Per soffermarsi sui migliori, va rilevato che la Danimarca ha presentato una strategia energetica 2050 con l’obiettivo di diventare indipendente dai combustibili fossili entro quella data.
La Germania, invece, si è data l’obiettivo a lungo termine – pur non giuridicamente vincolante – per ridurre le emissioni dell’80-95% entro il 2050. Francia e Romania hanno fatto piccoli passi in avanti attraverso l’assegnazione di finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo nel campo delle energie rinnovabili. L’Irlanda ha invece accantonato il suo progetto di legge per il cambiamento climatico e l’Olanda ha ridotto i suoi obiettivi per il 2020 al minimo dei livelli UE. Tra i Paesi in fondo alla classifica, con una F, Bulgaria, Romania, Lussemburgo, Grecia, Polonia4.
L’Italia conferma il voto E dell’edizione precedente dello studio, mancando ancora una strategia globale e trasparente sul clima che rifletta l’ambizione di raggiungere un’economia a basse emissioni di carbonio. Il Piano d’azione nazionale per le energie rinnovabili, pubblicato nel mese di giugno 2010, e quello per l’efficienza energetica, pubblicato nel mese di luglio 2011, contengono iniziative che dovrebbero essere attuate entro la fine del 2011. Tuttavia, la difficile situazione economica e politica, ora all’ordine del giorno, potrebbe ritardare o ridurre sensibilmente gli incentivi a muoversi verso un’economia a basse emissioni di carbonio, a meno che il governo non inizi finalmente a considerare la green economy come una delle strategie di ripresa più promettenti. Per le fonti alternative il conto energia è stato ridotto ed è soggetto a continue modifiche mentre nel settore dell’industria, non risulta alcuna politica di sviluppo delle energie rinnovabili. Per gli edifici, viene citato come unico elemento positivo il decreto rinnovabili n. 28/20115 che contiene misure come l’obbligo della certificazione energetica, mentre per il settore trasporti, si fa riferimento alle proposte di legge per gli incentivi alle auto elettriche. Nessuna azione, invece, è prevista per favorire energie rinnovabili ed efficienza energetica nei settori di agricoltura e silvicoltura.
A livello europeo, le lacune nella politica dell’Unione sono identificate principalmente nell’Emission Trading System che deve essere reso di nuovo rilevante e nella direttiva sull’efficienza energetica6. Le raccomandazioni7 riguardano il miglioramento delle politiche esistenti (come ad es. l’introduzione di una tassa CO2 come parte della direttiva tassa sull’energia, il rafforzamento dei requisiti di efficienza per i passeggeri delle autovetture o degli standard della direttiva eco-design, l’adozione di una guida per gli Stati membri sull’incentivazione in materia di efficienza energetica e rinnovabile) e l’introduzione di nuove (accordi legali su target a lungo-termine o strategie oltre il 2020, una prospettiva climatica a lungo-termine sulla politica agricola europea).
Va, infine, sottolineato che se i temi sul tavolo dei negoziati a Durban sono più o meno gli stessi di Copenaghen di due anni fa, non sembra si stia avanzando molto e che, mentre si tergiversa, le emissioni di CO2 del pianeta sono arrivate a oltre 33 miliardi di tonnellate nel 2010 (con un aumento del 5,8% rispetto al 2009), con la Cina responsabile di un quarto del totale (25%) e gli Usa con il 19% che portano il peso totale del “G2” al 44%. L’UE con il 13% di CO2 si posiziona dopo gli Stati Uniti. Inoltre i Paesi del Bric fanno registrare tutti segni “+” rispetto alle emissioni dell’anno precedente: Brasile (+11,4%), Cina (+10,4%), India (+9,2%). Le responsabilità per gli elevati livelli di CO2 non ricadono solo sulle politiche attuate dagli Stati ma anche sui finanziatori di determinati progetti (oggi, le principali 93 banche del mondo hanno investito in progetti su centrali a carbone più di 232 miliardi di euro).
Ora, il Protocollo di Kyoto scade nel 2012 e la maggioranza dei partecipanti al Mef (Major Economy Forum, istituito dal presidente Obama nel 2009 e costituito dalle 17 maggiori economie mondiali, ma a cui sono ammessi a partecipare anche alcuni rappresentanti dei Paesi in via di sviluppo) hanno ritenuto opportuno che gli impegni si estendano fino al 2020. A Durban si dovrebbe indicare una «via di mezzo» che trovi il massimo consenso anche di quei Paesi che finora si sono opposti al proseguimento del protocollo di Kyoto. Aspettiamo i risultati.
* Environment manager presso Eni exploration & production – SEQ – AMTE.
1 Ecofys è una società di consulenza internazionale che opera nel settore delle energie rinnovabili, efficienza energetica, sistemi e politiche energetiche. Essa supporta organizzazioni pubbliche e private nell’adattare le proprie azioni e politiche oltre che identificare nuove opportunità.
2 Testo del Rapporto in climatepolicytracker.eu. Esso è costituito da 5 sezioni: 1) obiettivi ed approccio; 2) il pacchetto “low-carbon”; 3) la politica dell’UE in materia di energia e clima; 4) i trend delle politiche degli Stati membri dell’UE; 5) il futuro.
3 Il Rapporto indica che tale obietto dei 2°C era stato indicato come obiettivo dall’UE fin dal 1996, mentre le Nazioni Unite, nel dicembre 2010, avevano riconosciuto la necessità di considerare il livello di 1,5°C.
4 A pag. 23 del Rapporto vengono elencati i progressi maggiori di ogni Stato. L’Italia viene citata a pag. 30 per l’adozione della riduzione della tassazione del 55% per le misure di efficienza energetica negli edifici.
5 Il testo si trova sul supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 28.03.2011: D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.
6 In sintesi, l’Unione si ritrova F per le sue politiche in generale; per il settore dell’elettricità, registra B per il rinnovabile, F per l’efficienza energetica, D, in generale; per il settore industriale, C per il rinnovabile, E per l’efficienza energetica, E in generale; per il settore degli edifici, C per il rinnovabile, D per l’efficienza energetica, G in generale; per il settore trasporti, C per il rinnovabile, E per l’efficienza energetica, F in generale; per il settore agricoltura, e foreste registra le maggiori lacune e non viene attribuito punteggio.
7 Alle pagg. 31-32 del Rapporto.
Tutela antisindacale e requisiti per proporre l’azione ex art. 28 legge 300/1970
NICOLETTA BINDELLI*
La Corte di Cassazione, sulla base di un ricorso proposto dallo Slai/Cobas contro Videotime S.p.a. (società del gruppo Mediaset S.p.a.), ha risolto l’annosa questione in ordine ai requisiti per proporre il ricorso ex art. 28 per la repressione della condotta antisindacale.
Sulla base di una errata interpretazione di un’altra sentenza della stessa Corte (sentenza n. 212/2008), che aveva ritenuto di valorizzare la sottoscrizione di un contratto collettivo nazionale da parte del sindacato ricorrente (in quel caso carente del requisito organizzativo e strutturale di carattere nazionale), ai fini del riconoscimento del concetto di “organizzazione sindacale nazionale” richiesto per la proposizione del ricorso ex art. 28 Statuto dei Lavoratori, alcuni giudici di merito tra cui il Tribunale di Milano e la Corte di Appello di Milano, esclusivamente nella sentenza cassata, avevano ritenuto di considerare essenziale, per la proposizione dell’azione, la sottoscrizione di un contratto collettivo nazionale da parte dell’organizzazione sindacale ricorrente.
In pratica si riconosceva la possibilità di utilizzare tale strumento esclusivamente a quei sindacati che avessero soddisfatto detto requisito, “implicante il consenso della controparte datoriale”.
Tale soluzione era palesemente in contrasto con la ratio della norma, evidenziata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 54 del 1974 e introduceva un elemento di confusione tra i requisiti stabiliti dall’art. 19 legge 300/1970 e quelli previsti dall’art. 28 della stessa legge.
Con la decisione di cui in commento è stato quindi formulato il seguente principio di diritto: “ai fini della legittimazione attiva a promuovere l’azione prevista dall’art. 28 della legge 300/1970, per associazioni sindacali nazionali devono intendersi associazioni che abbiano una struttura organizzativa articolata a livello nazionale e che svolgano attività sindacale su tutto o su ampia parte del territorio nazionale, ma non è necessario che tale azione abbia anche comportato la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali”.
Tale soluzione, quindi, consente, correttamente, anche alle organizzazioni sindacali “dissenzienti” di utilizzare lo strumento processuale introdotto dall’art. 28 Statuto dei Lavoratori, auspicando implicitamente lo sviluppo del pluralismo sindacale, garantito anche dalla Carta Costituzionale (art. 39).
* Avvocato in Milano
***
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI – Presidente
Dott. SAVERIO TOFFOLI – Consigliere
Dott. PIETRO CURZIO – Rel. Consigliere
Dott. UMBERTO BERRINO – Consigliere
Dott. IRENE TRICOMI – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 22356-2009 proposto da;
S.L.A.I. COBAS (SINDACATO DEI LAVORATORI AUTORGANIZZATI INTERCATEGORIALE già S.L.A.) , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso lo studio dell’avvocato BEVILACQUA ANNA, rappresentato e difeso dall’avvocato RIZZOGLIO MIRCO GIOVANNI, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
VIDEOTIME S.P.A., (società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Mediaset S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONE IV 99 INT. 14, presso lo studio dell’avvocato FERZI CARLO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati STANCHI ANDREA NICOLO’, STANCHI VINCENZO, giusta delega in atti’,
– contro ricorrente –
avverso la sentenza n. 1311/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 10/12/2008 R.G.N. 474/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2’7/04/2011 dal, Consigliere Dott. PI 110 CURZIO;
udito l’Avvocato RI ZZOGLIO M1RCO GIOVANNI/
udito l’Avvocato FERZI CARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per
– il rigetto del ricorso.
Fatto e diritto
1. Lo SLAI Cobas (Sindacato dei lavoratori autorganizzati intercategoriale) propose un ricorso ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300 del 1970 nei confronti di Vídeotime spa. 11 ricorso fu rigettato e così l’opposizione dinanzi al Tribunale.
2. Il sindacato impugnò la decisione dinanzi alla Corte d’appello di Milano, che ha dichiarato inammissibile l’appello con sentenza pubblicata il 10 dicembre 2008, non ritenendo sussistente la legittimazione attiva dell’associazione sindacale ricorrente ai fini delta procedura disciplinata dall’art, 28 della legge 300 del 1970.
3. Con ricorso per cassazione il sindacato chiede l’annullamento di tale sentenza. Il ricorso è articolato in cinque motivi. La società intimata si è difesa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato una memoria per l’udienza.
4. Con il primo motivo si prospetta la tesi per cui i requisiti indicati dall’art. 28 ai fini della legittimazione attiva del sindacato varrebbero per la fase sommaria del procedimento, mentre, invece, qualora il decreto sia stato di rigetto del ricorso, qualsiasi soggetto sindacale, che ne abbia interesse ai sensi dell’art. 100 cpc, sarebbe legittimato alla opposizione.
5. Il motivo non è fondato. Quello costruito dall’art. 28 è uno speciale strumento processuale, assistito da una particolare dotazione sanzionatoria. Il legislatore, consapevole della sua incisività, ha avuto cura di prevedere meccanismi di selezione per individuare i soggetti legittimati ad utilizzarlo, allo scopo di evitare che uno strumento di garanzia potesse dare luogo ad abusi. A tal fine ha individuato i soggetti legittimati negli “organismi locali delle associazioni sindacati nazionali che vi abbiano interesse”. Ha così escluso, da un lato i singoli lavoratori, dall’altro, tutte le forme di organizzazione dell’autotutela dei lavoratori che non abbiano una rappresentatività nazionale (esclusione che la Corte costituzionale ha ritenuto conforme alla Costituzione perché l’azione ai sensi dell’art. 28 si aggiunge, ma non esclude un’azione giudiziaria ordinaria, mentre lo strumento previsto dallo Statuto del lavoratori, per la sua particolare incisività, potrebbe essere fonte di abusi se aperto ad associazioni sindacali di carattere non nazionale, espressione di realtà circoscritte sul piano territoriale o aziendale).
6. Il requisito del carattere nazionale deve sussistere tanto ai fini della proposizione dei ricorso, che ai fini dell’opposizione prevista dal terzo comma dello stesso art. 28. La procedura i; unitariamente disegnata. Nulla nel testo dell’art. 28 indica che in fase di opposizione cambi il regime della legittimazione processuale del sindacato e, del resto, non vi sono ragioni perché ciò sia ipotizzabile. Certo, comunque, una modifica in tal senso non può essere introdotta dall’interprete.
7. Con il secondo motivo il sindacato denunzia una violazione dell’art. 28 per il fatto che la Corte avrebbe inteso in maniera eccessivamente selettiva il criterio della nazionalità.
8. Come si è detto, l’art. 28 legittima all’azione solo “gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse”, La Corte d’appello di Milano, a fronte di tale previsione, ha ritenuto che il sindacato ricorrente non avesse legittimazione con le seguenti testuali parole; “la Corte di cassazione, dopo alcune incertezze, si è oramai attestata a ritenere che, elemento decisivo per valutare la capacità negoziale del sindacato ai fini della legittimazione a proporre azione ex art. 28, sia la sua effettiva capacità di negoziazione a livello nazionale, compresi i c.d, accordi gestionali (cfr. Cass. 212/2008). Seguendo quest’orientamento, nella fattispecie, SLAI Cobas, non firmataria di accordi collettivi a livello nazionale non facendo parte della piattaforma sindacale contrattuale con il gruppo Mediaset, non risulta legittimata a proporre lo specifico strumento di tutela di cui all’art. 28”. In conseguenza di ciò la Corte, ha sancito la ‘inammissibilità’ del ricorso.
9. La sentenza sul punto deve essere cassata.
10. Come risulta dalla breve motivazione su riportata, la Corte di Milano richiede, ai fini della sussistenza del carattere nazionale dell’associazione sindacale, che questa abbia firmato contratti collettivi di livello nazionale. Identifica cioè quella che definisce, alquanto impropriamente, ‘capacità negoziale’ con la legittimazione attiva ex art. 28. In questo modo introduce un criterio selettivo diverso e più forte di quello indicato dalla norma dello Statuto, perché un’associazione sindacale può avere carattere nazionale anche se non ha firmato contratti collettivi nazionali, ma comunque presenti una struttura di ampiezza nazionale e possa dimostrare di svolgere attività su tutto o ampia parte del territorio nazionale,
11. Tanto in dottrina che in giurisprudenza (Cass. n. 5209 del 2010; n. 13240 del 2009 e n. 29257 del 2008), si ò evidenziato che non deve confondersi la legittimazione ai fini dell’art. 28, con i requisiti richiesti dall’art. 19 della medesima legge per la costituzione di rappresentanze sindacali titolari dei diritti di cui al titolo terzo. L’art. 19, al suo specifico fine, richiede la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali (o anche provinciali o aziendali, purché applicati in azienda). L’art. 28 non prevede analogo requisito, implicante il consenso della controparte datoriale. Richiede che l’associazione sia nazionale.
12. Il carattere nazionale non può desumersi da dati meramente formali e non è sufficiente una dimensione nazionale statica, meramente strutturale, ma è necessaria anche un’azione diffusa a tale livello. Tuttavia azione a livello nazionale non significa necessariamente stipulazione di contratti collettivi di livello nazionale. Se contratti di questo livello sono stati sottoscritti, ciò sarà un indice importante del carattere nazionale dell’attività sindacale, ma è possibile che presentino questo requisito anche associazioni che abbiano svolto attività su tutto, o quanto meno ampia parte, dei territorio nazionale, anche se non abbiano sottoscritto contratti collettivi nazionali (Cass. n. 5209 del 2010, ha sottolineato che la stipulazione di contratti collettivi di livello nazionale è indice tipico del carattere nazionale di un sindacato, ma che tale carattere può desumersi “da ogni altro elemento indicativo in concreto di un’attività sindacale al suddetto livello”. Cass., n, 13240 del 2009 ha, a sua volta, sottolineato che la stipulazione di un contratto collettivo nazionale può costituire uno degli indici maggiormente rivelatori della sussistenza dei carattere nazionale dell’associazione, ma non certamente l’unico elemento rivelatore del requisito).
13.La valutazione in concreto spetta al giudice di merito, ma la Corte di Milano si è espressa, peraltro con motivazione apodittica e sicuramente insufficiente, fondando il suo giudizio su di un principio di diritto che non trova riscontro nella norma applicata.
14. La sentenza, pertanto, deve essere cassata, con rinvio ad altro giudice di merito, che dovrà decidere applicando il seguente principio di diritto: “Ai fini della legittimazione attiva a promuovere l’azione prevista dall’art. 28 della legge 300 del 1970, per ‘associazioni sindacali nazionali’ devono intendersi associazioni che abbiano una struttura organizzativa articolata a livello nazionale e che svolgano attività sindacale su tutto o su ampia parte del territorio nazionale, ma non è necessario che tale azione abbia anche comportato la sottoscrizione dì contratti collettivi nazionali”.
15. G1i altri motivi rimangono assorbiti. L’ultimo è inammissibile perché privo di quesito di diritto.
PQM
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, dichiara assorbiti gli altri ed inammissibile l’ultimo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in altra composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 aprile 2007.
Il consigliere estensore
Pietro Curzio
Il presidente
Fabrizio Miani Canevari
Il Cancelliere
Depositato in Cancelleria
oggi, 29 LUG 2011
Il cancelliere
Rivoluzione industriale
STEFANO NESPOR (*)
Fra il 1760 e il 1830 la Gran Bretagna fu teatro di cambiamenti che modificarono in profondità la sua economia e la struttura sociale: la rivoluzione industriale cambiò le famiglie, cambiò il modo di lavorare, cambiò la cultura e il pensiero. La società si trasformò, aumentò il divario sociale, molti si impoverirono e furono costretti a lavorare in condizioni spaventose. Tutti ricordano le descrizioni di Friedrich Engels delle condizioni di lavoro nelle fabbriche di Manchester. Ma vi fu anche una diffusione del benessere di enormi proporzioni la Gran Bretagna divenne un paese ricco e prospero.
Uno dei grandi e non ancora risolti interrogativi della storia economica e sociale è: perché tutto cominciò in Inghilterra e non altrove, in Francia o Germania?
Molte spiegazioni, è noto, sono state offerte. Per alcuni, in Gran Bretagna c’era molto carbone disponibile; per altri, c’era un sistema che proteggeva la proprietà intellettuale; per altri ancora, c’era la libertà di commercio e di impresa; per altri, infine, il costo del lavoro era elevato e questo incoraggiava la ricerca di innovazioni che ne riducessero i costi.
Secondo un recente saggio di un economista delle Federal Reserve, Ralf Meisenzahl e di uno storico dell’economia, Joel Mokyr, ciò che ha avuto un ruolo determinante è stato il capitale umano: l’Inghilterra si è trovata ad avere un gruppo di ingegneri, artigiani e imprenditori più preparati, più creativi, più intraprendenti che altri paesi. Ed è contato soprattutto quel gruppo di uomini che i due autori definiscono Tweakers: uomini che non inventano macchine e strumenti, ma li sanno mettere a punto, li perfezionano, li rendono produttivi ai massimi livelli possibili.
Così, nel 1779, Samuel Crompton fu l’inventore della spinning mule, la macchina per filare che rese possibile la meccanizzazione della manifattura del cotone. Ma non fu questa invenzione a favorire l’enorme sviluppo di questo settore produttivo nei decenni seguenti, ma una serie di artigiani creativi, per lo più ignoti, che seguirono: tra questi Henry Stones, che ebbe l’idea di aggiungere alla spinning mule delle rotelle di metallo; poi James Hargreaves, che inserì un meccanismo per evitare sbalzi nell’accelerazione e decelerazione della macchina; e poi William Kelly, John Kennedy e poi, soprattutto, Richard Roberts autore di due prototipi che poi sarebbero stati riprodotti su vasta scala: tutti aggiunsero piccoli ma decisivi perfezionamenti che aumentarono la velocità, l’efficienza e la precisione della filatrice. Furono queste microinvenzioni, introdotte dai tweakers, che resero produttive e remunerative la grande invenzione di Crompton.
È questo continuo perfezionamento che, secondo Meisenzahl e Mokyr, è fondamentale per il progresso tecnologico, ed è cio che ha permesso, in Gran Bretagna, la rivoluzione industriale. James Watt ha inventato, è vero, la macchina a vapore, raddoppiando l’efficienza delle macchine disponibile in precedenza. Ma quando sono sopraggiunti i perfezionatori, l’efficienza delle macchine a vapore è quadruplicata.
Insomma, ci sono i visionari creativi che partono da una pagina tutta bianca e ricreano un mondo. Poi, ci sono i tweakers che prendono ciò che è stato fatto, ne aumentano l’efficienza, la gradevolezza, la funzionalità e lo portano a perfezione.
In un recente articolo sul New Yorker, Malcolm Gladswell ha indicato il più grande tweaker del nostro tempo: Steve Jobs. Molti ne hanno lodato la creatività. Ma Jobs non ha creato nulla. La sua grande dote era di prendere idee di altri e di realizzarle o di prendere strumenti già esistenti e portarli a perfezione.
Le considerazioni di Meisenzahl e Mokyr offrono spunti di riflessione anche per le attuali condizioni del nostro Paese. Non c’è crescita, certo, e manca una politica che la promuova, non c’è dubbio. Ma la crescita non si crea da un momento all’altro né è un effetto automatico di riduzioni di spesa, come molti pensano.
Anche gli incentivi allo sviluppo, di cui molti parlano, servono a poco, se non c’è una comune fiducia sulla capacità del paese di rimettersi in moto e una classe politica che si impegna per raggiungere degli obiettivi.
Non bisogna dimenticare che l’Italia ha perso molti treni negli ultimi anni: mentre in altri paesi vi era crescita economica (magari modesta, come in molti paesi dell’UE), in Italia tra il 2001 e il 2010 l’economia è cresciuta meno che in ogni altro paese del mondo, salvo Haiti e Zimbabwe (il dato è riportato da The Economist 12\11\2011).
D’altro canto, la scelta costante dei nostri governi (portata alle sue massime vette dai Governi Berlusconi, ma non certo una sua invenzione) di vivere, o meglio di vivacchiare, con piccoli stratagemmi, furbizie e sotterfugi per far quadrare i conti e per simulare approssimativi adeguamenti alle regole comunitarie (sempre finalizzati a creare situazioni di vantaggio competitivo per imprenditori o investitori italiani, in attesa dell’immancabile intervento della Commissione o della Corte di Giustizia) è giunta al punto d’arrivo: ciò che poteva essere sopportabile in una economia florida diffusa non lo è allorché anche gli altri paesi debbono tirare la cinghia.
Tuttavia, alcuni strumenti immediati per creare la fiducia necessaria per favorire lo sviluppo ci sono.
Due esempi, entrambi tratti ancora da dati di The Economist del 12 novembre.
Il primo. Oggi l’Italia è all’87 posto nella graduatoria dei paesi dove è facile intraprendere o svolgere attività commerciali: tanto per intenderci, è dietro l’Albania. Secondo la Banca Mondiale, è più difficile ottenere una fornitura elettrica in tempi ragionevoli in Italia che in Sudan.
Il secondo. Nell’indice di corruzione elaborato periodicamente da Transparency International, l’Italia è al 67° posto, dietro molti paesi africani.
Eliminare le migliaia di barriere all’attività d’impresa e dare precisi segnali che ogni tentativo di corruzione sarà rigorosamente ostacolato e duramente punito non costa nulla e può rendere assai per favorire lo sviluppo. Come abbiamo imparato nelle scorse settimane, anche i segnali contano nell’economia globale.
Ma, soprattutto, la crescita, come insegna l’esempio della Rivoluzione industriale e il saggio di Meisenzahl e Mokyr, è il frutto di una politica fatta di piccoli passi. Parte dalla formazione di insegnanti delle scuole primarie e poi via via delle scuole tecniche e professionali e delle università; parte dalla formazione di atteggiamenti culturali favorevoli al cambiamento e all’innovazione tecnologica; parte da finanziamenti accuratamente mirati, amministrati da funzionari preparati, alle piccole e medie imprese che investono in settori che in tutta Europa sono indicati come quelli che saranno trainanti nel futuro, tecnologie mediche e biotecnologiche e informatica in primo luogo.
(*) Avvocato in Milano
Pubblicato su Osservatorio AD il 16/11/2011





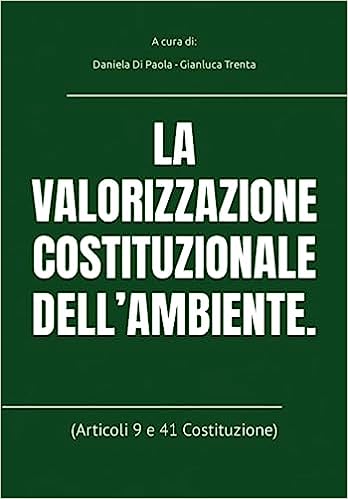
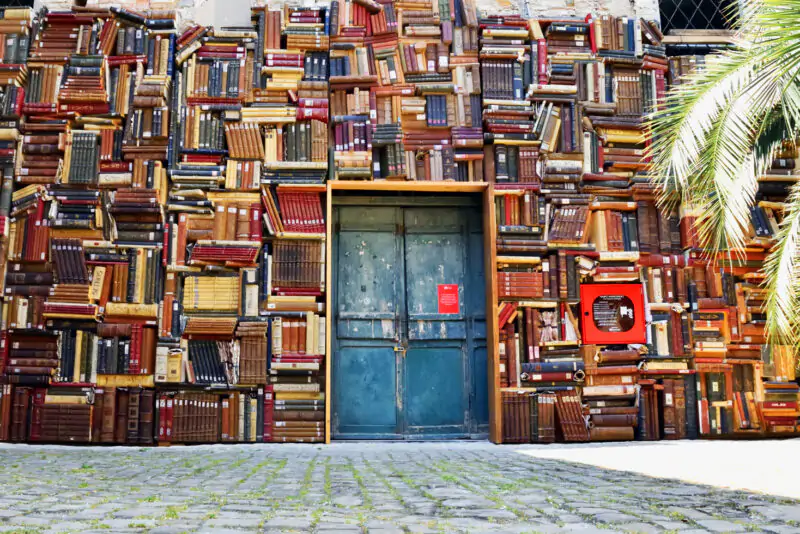 AMBIENTEDIRITTO.IT Casa Editrice
AMBIENTEDIRITTO.IT Casa Editrice