L’invalidità del titolo edilizio nel giudizio penale
L’esame delle problematiche relative alla rilevanza dell’atto amministrativo invalido nella fattispecie penale ha dato luogo ad un articolato dibattito dottrinale
1 e giurisprudenziale.
La maggior parte delle riflessioni giurisprudenziali sono sorte in materia edilizia ed il punto centrale del dibattito ha avuto ad oggetto la possibilità per il giudice penale di contestare un abuso edilizio in presenza di opere edilizie realizzate conformemente ad un titolo abilitativo (ritenuto) illegittimo.
A seguito di alcuni contrasti nella giurisprudenza, nel 1987 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione vennero investite della problematica giuridica relativa all’equiparazione tra “mancanza di concessione edilizia” e “concessione edilizia rilasciata illegittimamente”.
In quella occasione
2, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione esclusero che, con riferimento al reato di cui all’art. 17, lett. b), della legge n. 10 del 1977 (che sanzionava l’esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia), potesse essere accolta la tesi dell’equiparazione tra costruzione edilizia effettuata senza titolo e costruzione edilizia effettuata sulla base di un titolo illegittimo, che traeva fondamento dall’istituto della disapplicazione del provvedimento amministrativo illegittimo, disciplinato dagli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E.
Secondo la Suprema Corte, le norme della legge n. 2248 del 1865 non introducono un principio generalizzato di disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi da parte del giudice ordinario per esigenze di diritto oggettivo, ma, al contrario, sono rivolte a limitare il controllo (sempre in via incidentale) da parte del giudice ordinario sulla legittimità dell’atto amministrativo ai soli atti incidenti negativamente sui diritti soggettivi; conseguentemente, l’istituto della disapplicazione non può trovare applicazione nei confronti di quegli atti amministrativi che rimuovono, invece, un ostacolo al libero esercizio di un diritto soggettivo o addirittura costituiscono un diritto.
Ciò, per la Corte, non significa che al giudice penale sia impedito in assoluto di conoscere della legittimità dell’atto amministrativo: tale possibilità può trovare fondamento o in una previsione legislativa esplicita ovvero qualora l’illegittimità dell’atto amministrativo si presenti essa stessa come elemento essenziale della fattispecie criminosa.
Le Sezioni Unite intervennero nuovamente sulla questione nel 1993
3 e, con riferimento alla fattispecie di cui alla lettera a) dell’art. 20 della legge n. 47 del 1985, sostennero che al giudice penale non è affidato alcun sindacato sull’atto amministrativo, ma nell’esercizio della potestà penale è tenuto ad accertare la conformità tra ipotesi di fatto e fattispecie legale, in vista dell’interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela.
In nome, quindi, dell’interesse sostanziale tutelato, il reato di cui alla lettera a) della legge n. 47 del 1985 è, secondo la Corte, configurabile in caso di realizzazione di opere in contrasto con l’ordinamento urbanistico-edilizio anche in presenza di una concessione edilizia, la quale non è idonea a definire esaurientemente lo statuto urbanistico ed edilizio dell’opera realizzanda e che, pertanto, non necessita di disapplicazione.
Va subito messo in luce che il precetto di cui alla lettera a) dell’art. 20 della legge n. 47 del 1985 (oggi lettera a) dell’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001) ha per oggetto anche la violazione di disposizioni contenute in norme di legge in materia urbanistica-edilizia nonché nel regolamento edilizio e nello strumento urbanistico.
L’accertamento attribuito al giudice penale si estende, quindi, anche alla verifica della conformità della condotta posta in essere con la realizzazione dell’opera ai parametri di legalità fissati dall’ordinamento urbanistico-edilizio.
Si può, quindi, ragionevolmente ritenere che, con riferimento alle fattispecie di reato di inosservanza delle regole edilizie (descritta oggi nella lettera a) dell’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001), l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la conformità della costruzione e del titolo edilizio all’ordinamento giuridico di settore è elemento costitutivo dei reati urbanistici trovi sostegno nell’esegesi testuale della norma incriminatrice.
In questa ipotesi è la descrizione normativa del reato che impone al giudice un riscontro diretto di tutti gli elementi che concorrono a determinare la condotta criminosa che, nella fattispecie sopra riferita, è (anche) quella contrastante con le prescrizioni legislative e regolamentari ivi richiamate, pur in presenza di un titolo abilitativo e prescindendo da un giudizio su tale atto finalizzato alla sua disapplicazione.
A conclusioni difformi deve pervenirsi con riferimento alla fattispecie di reato di esecuzione di lavori in assenza del permesso di costruire, descritta nella lettera b) del cit. art. 44, rispetto alla quale il richiamo alla legalità urbanistica ed edilizia quale interesse protetto dalla norma incriminatrice si scontra con il dato letterale della disposizione legislativa.
In questa ipotesi, la descrizione legale della fattispecie di reato impone al giudice il mero riscontro della presenza o meno del titolo edilizio: la conformità della costruzione e del permesso di costruire all’ordinamento edilizio-urbanistico non è, in questo caso, elemento costitutivo del reato.
Al riguardo, non può, quindi, essere condiviso l’orientamento giurisprudenziale
4 che ha esteso all’ipotesi illustrata nella lettera b) del cit. art. 44 le riflessioni che avevano indotto nel 1993 le Sezioni Unite ad individuare nel parametro della legalità urbanistica ed edilizia un elemento costitutivo del diverso reato descritto nella lettera a) dell’art. 20 della legge n. 47 del 1985.
L’art. 44, lett. b), del TU in materia edilizia, nel sanzionare l’esecuzione di lavori in assenza del permesso di costruire, non appare neanche funzionale alla tutela dell’interesse all’osservanza delle norme dell’ordinamento urbanistico-edilizio.
La disposizione in esame risponde all’interesse pubblico, avvertito dal legislatore sin dall’emanazione della legge urbanistica del 1942, di sottoporre l’attività edilizia al controllo preventivo della P.A., con conseguente imposizione dell’obbligo di richiedere l’apposito provvedimento abilitativo all’edificazione.
Rispetto a tale esigenza di controllo preventivo della P.A. appare indifferente la circostanza che la costruzione corrisponda o meno al complesso delle norme che regolano l’attività edilizia
5.
Si aggiunga che il potere di sindacato a tutto campo del giudice penale discendente dall’art. 101 della Costituzione deve in ogni caso essere bilanciato con gli altri valori costituzionali coinvolti; nella valutazione comparativa tra i principi costituzionali il principio di legalità nella giurisdizione non può che recedere di fronte al principio di legalità-tassatività in materia penale, di cui all’art. 25 Cost. ed oggi codificato anche nell’art. 7 della CEDU
6, e della personalità della responsabilità penale sancito dall’art. 27 Cost..
Si può, quindi, ragionevolmente sostenere che per la configurazione del reato di esecuzione di lavori in assenza del permesso di costruire, di cui alla lettera b) dell’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, occorre che manchi il titolo edilizio.
L’assenza del permesso di costruire non va intesa, tuttavia, solo come inesistenza materiale, ma anche come inesistenza giuridica, con la conseguenza che il reato di costruzione in difetto di titolo edilizio dovrebbe ritenersi integrato anche quando: a) il vizio che inficia l’atto è tale da determinare la sua giuridica inesistenza, come nel caso dell’atto amministrativo nullo
7; b) l’atto amministrativo abilitativo non è riconducibile alla sfera del lecito giuridico e, quindi, appare frutto di un comportamento collusivo tra il soggetto che ha rilasciato il provvedimento abilitativo ed il beneficiario dello stesso oppure sia frutto di un’attività antigiuridica del soggetto richiedente il provvedimento abilitativo che abbia indotto in errore la pubblica amministrazione.
Sotto altro profilo, deve rammentarsi che in tutti i casi in cui appaia contestabile, in presenza di un titolo edilizio in ipotesi illegittimo, una delle fattispecie penali sopra esaminate, si pone il problema dell’effettiva riconoscibilità del dovere giuridico e quindi della consapevolezza dell’agente in ordine all’antigiuridicità del comportamento.
Al riguardo, si consideri che recentemente la Corte di Cassazione
8 ha affermato che: a) il rilascio di una concessione edilizia illegittima di poi annullata d’ufficio o su ricorso integra gli estremi di un atto illecito per violazione del principio del neminen laedere per avere tale atto con la sua apparente legittimità ingenerato nel suo destinatario l’incolpevole convincimento di poter legittimamente procedere all’edificazione del fondo; b) il titolare di un permesso di costruire ha il diritto di fare affidamento sulla legittimità dell’atto amministrativo e, quindi, sulla correttezza dell’azione amministrativa e può invocare la tutela risarcitoria avanti al giudice ordinario
9.
Ora, se il permesso di costruire con la sua “apparente legittimità” (leggasi: presunzione di legittimità) ingenera l’incolpevole convincimento di poter legittimamente procedere all’edificazione del fondo e se il titolare del permesso di costruire ha il diritto di fare affidamento sulla legittimità dell’atto amministrativo e sulla correttezza dell’azione amministrativa, può ragionevolmente ritenersi che la presenza di un titolo abilitativo debba di per sé escludere la sussistenza dell’elemento psicologico della contravvenzione edilizia, che pone a proprio fondamento l’illegittimità del titolo stesso, quantomeno quando la violazione della norma urbanistica non sia grossolana o macroscopica.
__________________
Note:
[1] Si confronti, anche per ulteriori riferimenti bibliografici: Cocco, L’atto amministrativo invalido elemento delle fattispecie penali, Cagliari, 1996; Durante, Il titolo edilizio al cospetto del giudice penale, in Rivista giuridica dell’edilizia, 2009, 4, 119; Gambardella, Il controllo del giudice penale sulla legalità amministrativa, Milano, 2002; Petrone, Attività amministrativa e controllo penale. Scritti, Milano, 2000; Pontis, I limiti del sindacato del giudice penale sulla autorizzazione amministrativa, in Responsabilità civile e previdenza, 2009, fasc. 2; Tanda, Attività amministrativa e sindacato del giudice civile e penale, Torino, 1999; Tripodi, La disapplicazione degli atti amministrativi da parte del giudice penale. Profili costituzionali, in Foro Amm., CdS, 2010, 2017.
[2] Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, 31 gennaio 1987, in Rivista giuridica dell’edilizia 1987, I, 328.
[3] Corte di Cassazione, Sezione Unite penali, 12 novembre 1993, in Rivista giuridica dell’edilizia, 1994, 405.
[4] Corte di Cassazione, III Sezione penale, 3 dicembre 2010, in Rivista giuridica dell’edilizia, 2011, I, 764.
[5] In questo senso si esprimeva la Corte Costituzionale nella sentenza n. 47 del 1979 in sede di scrutinio dell’art. 41, lett. b), della legge n. 1150 del 1942, con riferimento alla contravvenzione di inizio dei lavori senza licenza edilizia.
[6] A partire dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 la giurisprudenza costituzionale è costante nel ritenere che le norme della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) – nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo – integrano, quali norme interposte, il parametro costituzionale espresso dall’art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (cfr., da ultimo, la sentenza n. 236 del 19 luglio 2011).
[7] Vedi ora l’art. 21 septies della legge n. 241 del 1990, che ha codificato le ipotesi di nullità dell’atto amministrativo.
[8] Corte di Cassazione, Sezioni Uniti civili, 23 marzo 2011.
[9] La decisione appena esaminata della Corte di Cassazione ci riporta alla memoria le fondamentali argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 364 del 1988 sull’art. 5 c.p. e, segnatamente, quelle sull’errore inevitabile che può essere determinato, fra l’altro, da particolari, positive, circostanze di fatto in cui s’è formata la deliberazione criminosa, come, ad esempio, le “assicurazioni erronee” di persone istituzionalmente destinate a giudicare sui fatti da realizzare.
Pubblicato su Osservatorio AD il 16/11/2011
E’ legittima la coincidenza tra l’autorità che approva il piano e l’autorità designata ad esprimere il parere in materia di VAS?
Una recente sentenza della Corte di Giustizia impone di riaprire il dibattito nazionale.
MATTEO CERUTI*
Con la recentissima sentenza 20 ottobre 2011 emessa nel procedimento C 474/10, la Corte di Giustizia, chiamata ad esprimersi sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’appello dell’Irlanda del Nord (Regno Unito), afferma principi importanti sull’interpretazione dell’art. 6 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.
La questione interpretativa affrontata e risolta dalla Corte tocca un tema che va un po’ al cuore dell’istituto della VAS: quello del rapporto tra le autorità che elaborano ed approvano i piani o programmi (le “autorità procedenti” secondo l’art. 5, comma 1, lett. q), del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.) e le autorità che debbono essere consultate in sede di VAS (le “autorità competenti” secondo l’art. 5, comma 1, lett. p), del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.).
Il problema ha impegnato e diviso la giurisprudenza e la dottrina italiana, e di tale discussione si è già dato conto su questo Osservatorio1.
I Giudici europei sembrano ora interpretare l’art. 6, paragrafo 3, della direttiva 2001/42 (a mente del quale “Gli Stati membri designano le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione dei piani e dei programmi”) in controtendenza rispetto agli approdi cui era sinora pervenuto il dibattito nazionale2.
La decisione trae origine dalle seguenti vicende. Il Ministero dell’ambiente dell’Irlanda del Nord aveva provveduto all’elaborazione di piani di sviluppo regionali tramite una propria agenzia (Planning service) ed aveva quindi consultato – ai fini della valutazione ambientale delle proposte di tali piani – un’altra sua agenzia (Environment and Heritage Service). In alcune controversie davanti ai Giudici nazionali si era dunque posto il problema se la direttiva 2001/42 debba essere interpretata nel senso che, allorché l’autorità che elabora un piano – rientrante nel campo di applicazione della direttiva medesima – sia essa stessa l’autorità con competenza generale in materia di ambiente nello Stato membro, incomba o meno a quest’ultimo l’obbligo di designare un organo consultivo diverso da tale autorità. Giunte le controversie dinanzi alla Corte d’appello dell’Irlanda del Nord, quest’ultima decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte UE questione pregiudiziale.
Al predetto quesito i Giudici europei rispondono affermando che, in circostanze come quelle della causa principale, l’art. 6, n. 3, della direttiva 2001/42 non impone che sia creata o designata un’altra autorità consultiva .
Tuttavia, aggiunge la Corte, poiché la ratio della consultazione delle autorità con specifiche competenze in materia ambientale prevista dall’art. 6, n. 3, della direttiva va individuata nella “completezza ed affidabilità” delle informazioni (alla luce del 15° considerando)3, le disposizioni della direttiva 2001/42 sarebbero private di ogni “effetto utile” se – nell’ipotesi in cui l’autorità che elabora o adotta un piano o un programma sia essa stessa l’autorità designata per la consultazione – non esistesse nella struttura amministrativa dello Stato membro di cui trattasi nessun altro organo legittimato ad esercitare tale funzione consultiva.
E’ per questo che – conclude la Corte – in tali circostanze in seno alla medesima autorità (incaricata di elaborare il piano e designata per la consultazione in materia ambientale) deve essere necessariamente prevista una separazione funzionale, tale per cui un’entità amministrativa, interna a tale autorità, disponga di un’autonomia reale, la quale implica che essa abbia a disposizione mezzi amministrativi e risorse umane propri, e sia in tal modo in grado di fornire in modo oggettivo il proprio parere sul piano o programma previsto dall’autorità dalla quale essa promana. Tutti requisiti che debbono essere necessariamente verificati dal Giudice nazionale.
Vale peraltro la pena di sottolineare l’incipit da cui muove la Corte nel risolvere la suddetta questione pregiudiziale nei termini sopra ricordati: “in circostanze come quelle della causa principale”.
Per cui ci si pongono le seguenti domande: quid juris laddove non si ricada nell’ipotesi in cui ad elaborare ed approvare il piano sottoposto a VAS sia un’autorità specificamente preposta alla tutela ambientale? Anche in queste differenti ipotesi si può pervenire alla conclusione che l’art. 6, n. 3, della direttiva 2001/42 non impone che sia designata una differente autorità consultiva?
Non è agevole fornire una risposta a questi interrogativi. Quel che può dirsi sin d’ora è che la sentenza impone di riaprire il dibattito nazionale.
*Avvocato in Rovigo
1 Cfr. l’articolo di E. TANZARELLA, La VAS italiana: storia in itinere di un istituto maltrattato (con auspicio di lieto fine).
2 V. in particolare la conclusione cui era recentemente pervenuto il Consiglio di Stato (nella sentenza della Sez. V n. 133 del 12 gennaio 2011) secondo cui, alla luce delle previsioni del Codice dell’ambiente, “quasi fisiologica è l’evenienza che l’autorità competente alla VAS sia identificata in un organo o ufficio interno alla stessa autorità procedente” e che la questione sarebbe indifferente per la disciplina comunitaria.
3 Secondo il quale “Allo scopo di contribuire ad una maggiore trasparenza dell’iter decisionale nonché allo scopo di garantire la completezza e l’affidabilità delle informazioni su cui poggia la valutazione, occorre stabilire che le autorità responsabili per l’ambiente ed il pubblico siano consultate durante la valutazione dei piani e dei programmi e che vengano fissate scadenze adeguate per consentire un lasso di tempo sufficiente per le consultazioni, compresa la formulazione di pareri”.
La disciplina della VAS tra competenze statali e regionali alla luce della recente giurisprudenza costituzionale.
ANGELO MAESTRONI*
Come noto il quadro costituzionale in tema di tutela dell’ambiente è offerto dalla lettura degli artt. 9, 32, 117, 118 della Carta1, altrettanto noto è il forte contrasto in materia di legislazione ambientale tra Stato e Regioni dopo la riforma costituzionale del 2001 venutosi a creare da un lato a causa della mancata sintonia di fronte agli obblighi comunitari2, dall’altro a causa della difficoltà interpretativa del nuovo assetto del riparto di competenze legislative esclusive e concorrenti, stante l’assegnazione della materia ambiente al centro per quanto ne riguarda la tutela e alla periferia per quanto ne riguarda la valorizzazione3.
Arbitro di questo non semplice contesto la Corte costituzionale che, in maniera tutt’altro che univoca, ha cercato di mettere a fuoco la linea di demarcazione tra l’azione statale e quella regionale in campo ambientale. In materia di legislazione a tutela dell’ambiente, infatti, la Consulta ha faticato non poco prima di giungere a sancire l’esclusività statale sul punto. Dalle prime sentenze della seconda metà degli anni ’80 del secolo scorso, in cui la Corte delineava i concetti di ambiente quale interesse insuscettibile di bilanciamenti in grado di azzerarne le prospettive conservazionistiche4, quale bene di valore assoluto e primario5 e quale interesse fondamentale6 si è passati a pronunce in cui, a seguito dell’intervenuta legge costituzionale 3/01, la Corte, preoccupata più del riparto delle competenze che della tutela in sé e per sé considerata, si è impegnata a delineare i nuovi confini delle materie. La tutela ambientale è così stata definita quale materia non materia7 trasversale avente ad oggetto un bene non unitario8 ciò forse per far digerire tanto allo Stato quanto alle Regioni la nuova suddivisione competenziale impostata sui famigerati elenchi di materie dell’art. 117 Cost. secondo e terzo comma.
Grazie ad un’originale interpretazione del testo costituzionale la compentenza concorrente in non poche occasioni si è così trasformata in competenza alternativa per ammettere l’innalzamento dei livelli minimi di protezione fissati dallo Stato nelle materie di interesse regionale connesse alla tutela ambientale quali per esempio governo del territorio, tutela della salute, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, ovvero in quelle aventi ad oggetto la cura di interessi funzionalmente collegati alla tutela ambientale.
La Corte però dopo circa un quinquennio di rodaggio, verso la fine del primo decennio degli anni 2000 ha mutato rotta inaugurando, con le sentenze n. 367 e n. 378 del 2007, una nuova stagione giurisprudenziale volta a riconoscere l’ambiente come bene unitario e materiale, il cui oggetto di tutela coincide tanto con la biosfera quale insieme quanto con le singole componenti in essa incluse, quali aria, acqua, suolo e sottosuolo. Così la Corte arriva ad affermare che spetta alla legislazione statale il compito di disciplinare in via preventiva e necessaria questioni attinenti la conservazione, protezione e tutela ambientale anche al fine di limitare il corrisopndente potere regionale che deve invece definire, in via successiva, le modalità con cui rendere possibile la fruizione dell’ambiente. Sono le sentenze a cavallo tra il 2008 e il 2009 che confermano e ampliano questi principi riconoscendo allo Stato il delicato compito di determinare non già limiti inderogabili bensì elevati livelli di protezione ambientale9, ed è proprio grazie a questa evoluzione giurisprudenziale, culminata con la sentenza 225/09 che il D.lgs. 152/06 ha potuto resistere all’attacco delle Regioni10 scatenatosi allorchè con l’entrata in vigore del testo unico queste si sono viste sminuite nelle loro rispettive aspettative circa le competenze legislative in materia ambientale.
Ed è proprio questa pronuncia che tratta, tra l’altro, di valutazione ambientale strategica a segnare un punto di non ritorno in tema di riparto di competenze: la Corte ha ritenuto infatti che la VAS in quanto esprime la compatibilità ambientale dei piani o programmi volti allo sfruttamento di risorse ambientali attiene alla conservazione del bene e dunque proprio per questo motivo ha statuito che la disciplina della questione sul piano normativo appartenga alla competenza esclusiva dello Stato.
Da quel momento, forte di questa nuova chiave interpretativa dell’art. 117, secondo comma lett. s) offerta dalla Corte, il Governo ha sistematicamente impugnato le leggi regionali che mettevano a rischio il terreno conquistato nell’ambito competenziale della materia tutela dell’ambiente.
Le sentenze del 2010 e del 2011 segnano così la sconfitta di quelle Regioni che nel regolare la VAS locale avevano cercato di occupare anche ambiti coperti ormai definitivamente ed esclusivamente dallo Stato. In particolare nella sentenza 192/11 la Consulta espunge dall’ordinamento la legge con cui la Regione Piemonte aveva escluso dal regime di verifica di assoggettabilità a VAS il piano comunale di alienazione del patrimonio immobiliare non prevedendo altresì l’attivazione della procedura di VAS nel momento in cui le previsioni di detto piano comportassero modifiche sostanziali al piano urbanistico comunale; con la sentenza n. 209 del 2011 la Corte segna analoga sorte per la legge della Regione Toscana 10/10 che aveva escluso dalle procedure di valutazione i piani regolatori dei porti. L’esame del contenzioso costituzionale in tema di VAS è utile per mettere in luce che la tensione tra Stato e Regioni sul tema si sia ricomposta solo <a conflitto instaurato> con l’abbandono da parte degli Enti territoriali interessati delle proprie rivendicazioni autonomiste.11
Quanto sopra evidenzia anche che in ogni caso le Regioni sebbene consapevoli di questa giurisprudenza siano comunque tentate di allargare per via legislativa le maglie del controllo statale in quanto, non va sottovalutato, si potrebbe sempre verificare il caso in cui il Governo per qualche ragione non intervenga affatto contro la legge regionale, non rilevandone per esempio l’incostituzionalità o non agendo per <interessi altri>, meno trasparenti, rispetto a quelli che dovrebbe garantire12.
Quanto sin qui esposto può offrire un approccio nella lettura del contenzioso costituzionale all’entrata in vigore del D.lgs. 128/10; in base al correttivo le Regioni devono infatti disciplinare (art. 7) la VAS in sede regionale per piani e programmi la cui approvazione compete alle Regioni o Enti locali, mentre lo Stato quella più ampia secondo il Codice. E’ stato sintetizzato che la disciplina della VAS viene attribuita al livello di governo a cui compete l’approvazione del piano cui la valutazione stessa si riferisce, per cui in caso di approvazione di un piano attinente a materie regionali, la competenza è della legge regionale, viceversa in caso di approvazione di un piano in materie rientranti nella competenza esclusiva statale, la legge regolatrice dovrebbe essere appunto quella dell’Ente supremo. Ciò però si è detto non risolve né attenua i problemi di cui si è discusso attinenti all’inquadramento dei rapporti Stato/Regioni in materia di legislazione di protezione ambientale e di VAS in quanto né il T.U. né i correttivi menzionano l’art. 117, c. 2, lett. s) come base costituzionale di cui la disciplina sulla VAS costituisce attuazione.
Il D.lgs. 128/10 ha invero introdotto la previsione espressa della facoltà delle leggi regionali e delle Province autonome di disciplinare ulteriori modalità per l’individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre a VIA, VAS e AIA per lo svolgimento delle relative consultazioni ponendo come limiti la legislazione comunitaria e la compatibilità con il testo unico, nonché il rispetto della L. 241/90, ma ciò mal si concilia con l’art. 3 quinquies del T.U. nella parte in cui stabilisce che “i principi nel presente d.lgs. costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell’ambiente sul territorio nazionale” e che “le Regioni e le Province autonome, possono adottare forme più restrittive senza aggravio del procedimento e senza discriminazione”13.
Se infatti da un lato le nuove norme sembra siano state dettate per dare maggiore spazio alle Regioni permettendo a queste di stabilire i casi in cui la VAS è obbligatoria, dalla lettura della normativa in materia nel suo complesso emerge tutt’altro; così con ogni probabilità, salvo ulteriori correttivi, sarà la Corte a farsi carico di ristabilire i giusti confini.
* Prof. Agg. di diritto ambientale nell’Università di Bergamo
1 Si veda per tutti la voce Diritto costituzionale dell’ambiente, di S. NESPOR e B. CARAVITA DI TORITTO, in Codice dell’ambiente, pp. 99 ss., Giuffrè, 2009 nonché i commenti agli artt. 9, 42, 117 e 118 Cost., di G. F. FERRARI, in Commentario breve alle leggi di urbanistica ed edilizia, pp. 8 ss., Cedam, 2010.
2 Sullo specifico tema oggetto della presente trattazione si vedano ad es. le senteze C.te Cost. 398/06 e 309/06.
3 Si vedano ad es. le sentenze C.te Cost. 407/02, 246/06, 182/06, 62/08 ed in particolare il commento di F. DI DIO, Giustizia costituzionale e concorrenza di competenze legislative in materia di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”: dalla trasversalità alla “prevalenza” della competenza statale, in RGA, 2009, 6, pp. 953 ss.
4 Cfr. C.te Cost. 151/86.
5 Cfr. C.te Cost. 641/84.
6 Cfr. C.te Cost. 210/87.
7 Cfr. C.te Cost. 407/02.
8 Cfr. C.te Cost. 246/06, 182/06, 62/08, 390/06.
9 In proposito si veda A. CIOFFI, in RGA, Giuffrè, 2009, 6, pp. 70 ss.; nonchè Cfr. C.te Cost. 180/08, 214/08, 220/08, 61/09, 30/09.
10 Si veda in proposito la sentenza 225/09.
11 Entrambe le questioni da un punto di vista processuale si sono risolte con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere in quanto le Regioni hanno modificato nel senso indicato dal Governo le proprie leggi.
12 Si veda in proposito C.te Cost. sentenza 187/11 relativa alla legge della Regione Marche sul servizio idrico integrato in cui la Corte, pur abrogando la legge impugnata, rileva l’esistenza di altra legge analoga in altra Regione non impuganta dal Governo.
13 Voce VAS, G.F. FERRARI, in Codice dell’Ambiente, Giuffrè, 2011, pp. 344 e ss.
I sistemi di gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori dopo il D. Lgs 20 novembre 2008, n. 188
CARLO LUCA COPPINI*
L’interpretazione da fornire alle disposizioni entrate in vigore dal 18 dicembre 2008 lascia senza dubbio spazio ad alcuni significativi interrogativi circa le modalità organizzative che gli operatori (rectius: produttori) sono stati autorizzati ad attuare per prestare ottemperanza agli adempimenti introdotti con il D.Lgs. 188/2008.
Potendone comparare il contenuto con i basilari principi del D.Lgs. 152/2006, può essere rilevato che, nell’organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti costituiti dalle pile ed accumulatori esausti, le modalità cui il produttore può fare ricorso sono costituite da due sistemi: a) individuale e b) collettivo nel rispetto dei criteri direttivi prescritti dall’articolo 237 del T.U.A., secondo cui: “I sistemi di gestione adottati devono, in ogni caso, essere aperti alla partecipazione di tutti gli operatori e concepiti in modo da assicurare il principio di trasparenza, di non discriminazione, di non distorsione della concorrenza, di libera circolazione nonché il massimo rendimento possibile”.
Pertanto la modalità operativa di gestione potrà svilupparsi attraverso l’esercizio di attività imprenditoriale in forma individuale o in forma collettiva, quest’ultima modalità presuppone la costituzione di un apposito consorzio. Oltre a tali possibilità, il produttore potrà affidare l’attività della gestione a terzi soggetti cui, infatti, mediante la stipula di apposito accordo contrattuale, può essere affidata la gestione di ogni servizio che consegue dalla produzione/immissione dei rifiuti.
E così, tornando alla lettura del D.Lgs. 188/2008, si parla di gestione in forma individuale o collettiva (in forma associata consortile) e tale richiamo viene effettuato dal legislatore proprio ogni qual volta si parla di esercizio di attività di gestione (art. 6, 1° e 3° comma; art. 10, comma 1; art. 14 in riferimento al Registro Nazionale in cui è riservata una sezione speciale; art. 15, 2° comma; art. 16, 1° comma .
Tipico richiamo alla gestione collettiva dell’attività derivante dall’immissione di pile ed accumulatori, peraltro, è fornito espressamente anche dall’art. 20 del D.Lgs. 188/2008 in cui, infatti, viene operato anche il collegamento al precedente Consorzio (o Consorzi) creato (i) a seguito dell’entrata in vigore della L. 475/1988 e delle successive modifiche.
Indipendentemente dall’ininfluente esame dell’organizzazione del sistema di gestione collettiva che il produttore (i produttori) intende (intendono) poter riservare alla struttura interna della propria compagine, deve essere evidenziato che tale forma di gestione risulta e resta comunque assoggettata a particolari ed autonome prescrizioni visto che, laddove costituita, tale la struttura dovrà procedere al regolare finanziamento del centro di coordinamento e ciò ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 13, 2° comma e 14, 1° comma del D.Lgs. 188/2008. Come noto, il suddetto Centro di Coordinamento dei sistemi collettivi nazionali è stato costituito nello scorso mese di giugno in analogia a quello prescritto dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (RAEE). Ricordiamo i principali compiti assegnati dal decreto al Centro di Coordinamento: a) ottimizzare le attività dei sistemi collettivi ed individuali a garanzia di omogenee ed uniformi condizioni operative; b) effettuare sull’intero territorio nazionale le campagne di informazione; c) organizzare per tutti i consorziati un sistema capillare di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori (portatili, industriali, veicoli); d) assicurare il monitoraggio e la rendicontazione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclo dei rifiuti di pile e accumulatori, nonché la loro trasmissione all’ISPRA; e) garantire il necessario raccordo tra l’amministrazione pubblica , i sistemi collettivi o individuali e gli altri operatori economici.
Il sito web del nuovo Centro di Coordinamento è raggiungibile all’indirizzo www.cdcnpa.it dallo stesso è possibile scaricarne anche lo Statuto.
Fatto questo breve excursus circa il richiamo che il legislatore ambientale del 2008 ha operato ai diversi sistemi collettivi ed individuali cui il “produttore” potrà ricorrere per l’esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti e per il relativo finanziamento, deve essere osservato che tale alternatività riveste il carattere tassativo con la conseguente esclusione di modalità diverse da quelle espressamente previste all’interno del testo legislativo.
* Avvocato in Milano
Giurisprudenza in materia di inquinamento elettromagnetico
ELENA TANZARELLA*
Le tematiche che i giudici di legittimità e di merito si trovano ad affrontare in materia di inquinamento elettromagnetico sono ricorrenti.
Nella giurisprudenza di legittimità sono costanti e tra loro coerenti le decisioni aventi ad oggetto il riparto di competenze, la natura delle prescrizioni in materia di inquinamento elettromagnetico, la definizione della ampiezza della potestà regolamentare dei Comuni, la legittimazione processuale.
La giurisprudenza di merito pare invece sovente chiamata a dirimere la questione della vincolatività, per il giudice ordinario, dei limiti di esposizione normativamente individuati.
I profili sopra delineati quali propri della indagine del Giudice di legittimità possono essere trattati congiuntamente poiché costituiscono sfumature della medesima questione.
Il riparto di competenze in materia di inquinamento elettromagnetico è delineato dalla legge quadro di settore (l. 22 febbraio 2001, n. 36) che attribuisce allo Stato il compito di determinare gli standards di protezione dell’inquinamento elettromagnetico, alla competenza concorrente Stato-Regioni la funzione normativa in tema di trasporto dell’energia e ordinamento delle comunicazioni e, infine, agli Enti territoriali minori l’attività di collocazione degli impianti (Cons. Stato, 13 aprile 2010, n. 2055).
Le norme statali che fissano gli standard di protezione dall’inquinamento elettromagnetico sono immediatamente operative sull’intero territorio nazionale ed hanno carattere prevalente sulla eventuale normativa regionale previgente, ancorchè dispositiva di criteri di tutela maggiormente restrittivi (Cons. Stato, Sez. IV, 18 marzo 2008, n. 1159).
L’interesse tutelato dalla l. 36/01 e dal relativo regolamento di attuazione, DPCM 8 luglio 2003, è di natura igienico sanitaria, essendo volto ad evitare gli effetti negativi dei campi elettrici su coloro che stazionano in prossimità degli impianti.
Allo scopo la normativa nazionale assume quali indici di riferimento parametri tecnici quali i valori di campo elettromagnetico generato dagli impianti e la potenza delle onde piane irradiate dai medesimi.
Ne è conseguita la dichiarazione di illegittimità costituzionale di norme regionali che hanno adottato quale criterio di prevenzione quello urbanistico della distanza degli impianti dagli edifici (Corte Cost. 7 ottobre 2003, n. 307, sulle leggi regionali di Campania, Marche e Puglia e 7 novembre 2003, n. 331, sulla LR Lombardia, n. 12/10).
Analoga sorte è toccata a quei regolamenti comunali che hanno introdotto prescrizioni di carattere urbanistico (distanze e fasce di rispetto) quali mezzi di tutela dall’inquinamento elettromagnetico. Il giudice amministrativo ha infatti affermato che si tratta di un uso improprio di strumenti di regolamentazione urbanistica nell’esercizio di attività amministrativa preordinata alla tutela della salute (Cons. Stato, Sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4557; TAR Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 21 giugno 2006, n. 294; Cons. Stato, Sez. IV. 14 febbraio 2005, n. 450; TAR Lombardia, Sez. II, 27 maggio 2005, n. 1113).
Né è dato ai Comuni di interdire la collocazione di impianti elettromagnetici in determinate zone del territorio (ove la installazione sarebbe altrimenti consentita in ragione della rispondenza ai criteri determinati dalla normativa statale): le infrastrutture elettroniche hanno carattere di pubblica utilità (così come stabilito dall’art. 90 del d.lgs. 259/03) e sono pertanto compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche (Cons. Stato, Sez. VI, 4 settembre 2006, n. 5059).
Il giudice di legittimità è invero sovente chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dei regolamenti comunali, circostanza che dipende dal fatto che tale tipologia di impianto, che peraltro lo stesso legislatore classifica quale opera di urbanizzazione primaria (pur permanendo nella proprietà del privato: art. 86 d.lgs. 259/03), richiede per la sua autorizzazione un procedimento unico che non investe solo profili di carattere urbanistico edilizio, bensì anche ambientali ed igienico sanitari (Corte Cost. 28 marzo 2006, n. 129 e 6 luglio 2006, n. 265) e determina, pertanto, quel costante allarme sociale che accompagna tutte le infrastrutture di questo genere e che induce gli Enti territoriali per definizione vicini alla popolazione a cercare di limitare quanto più possibile la collocazione delle infrastrutture nei loro territori, facendo ricorso agli strumenti regolamentari di cui dispongono.
La tendenza ad abusare di tali mezzi sino ad interdire sostanzialmente l’installazione degli impianti sul territorio è però oggetto di costante censura in sede giudiziale (da ultimo TAR Palermo, Sez. II, 9 marzo 2011, n. 419 e 8 luglio 2009, n. 1213; Cons. Giustizia Amministrativa 2 dicembre 2010, n. 1448).
Quanto invece alla legittimazione ad agire, la circostanza che le norme, anche regolamentari, dettate a tutela dell’inquinamento elettromagnetico abbiano finalità di tutela del bene salute e siano prive di natura edilizio – urbanistica determina che l’interesse ad agire sia in capo ai soli soggetti effettivamente lesi dalle irradiazioni elettromagnetiche e non da chi voglia fare valere un interesse di natura edilizia (TAR Toscana, Sez. III, 11 giugno 2006, n. 1590; TAR Campania, Sez. VII, 3 agosto 2006, n. 7797).
* * *
La questione dell’effettiva lesione del bene salute è oggetto di disamina da parte dei giudici ordinari.
Per il giudice di merito <i parametri massimi di esposizione a campi elettromagnetici generati da linee elettriche previsti dalla normativa vigente di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e al DPCM attuativo 8 luglio 2003 non sono vincolanti per il giudice ordinario nel momento in cui vengano in considerazione anche altri interessi costituzionalmente protetti, quali il diritto alla salute della popolazione esposta>: Corte Appello Milano, Sez. II civ., 31 agosto 2009, n. 2168, in Riv. Giur. Amb., 2010, 351, con nota di M. Ceruti, La tutela della salute dai campi elettromagnetici generati va garantita al di là dei parametri imposti dal DPCM 8 luglio 2003, ad oggi non aggiornati (in termini sulla irrilevanza del mancato superamento dei limiti tabellari laddove sia provata la compromissione della salute Trib. Foggia, ord., 27 febbraio 2007, in Foro It., 2007, 7-8, 1, 2124, con nota di F. Mattassoglio).
La sentenza del Tribunale di Milano si distingue anche per l’affermazione della rilevanza probatoria degli studi statistici, ancorché non confermati da studi sperimentali, ai fini della valutazione della tollerabilità delle immissioni elettromagnetiche nell’ambito di un’azione svolta ai sensi dell’art. 844 c.c.
L’effettività della lesione, al di là del mero superamento del dato formale costituito dal parametro tabellare, è poi criterio utilizzato dal giudice penale nell’accertamento della fattispecie di reato di getto pericoloso di cose: “In tema di inquinamento elettromagnetico, il reato di getto pericoloso di cose è integrato non dal mero superamento, da provare in modo certo ed oggettivo, dei limiti di esposizione dei valori di attenzione posti dalle norme speciali, ma dalla idoneità delle onde elettromagnetiche ad offendere o molestare persone, da provarsi in modo certo ed obiettivo e in concreto” (Cass. Pen., Sez. III, 13 maggio 2008, n. 36845).
* Avvocato in Milano





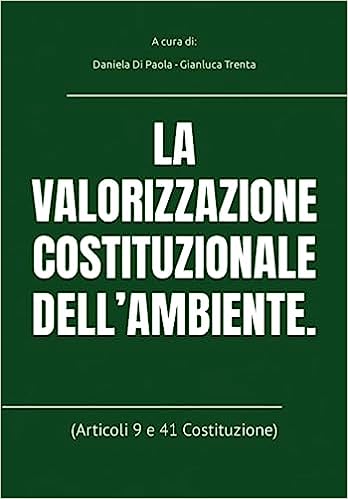
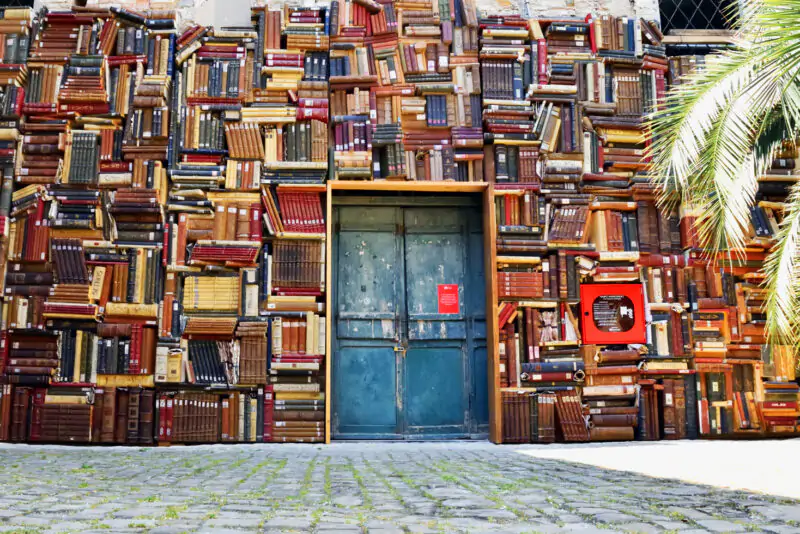 AMBIENTEDIRITTO.IT Casa Editrice
AMBIENTEDIRITTO.IT Casa Editrice