Mai dire mai: dopo la Conferenza di Durban nuove prospettive per un accordo globale per il contenimento del cambiamento climatico
STEFANO NESPOR*
Numerose sono le critiche rivolte ai convegni internazionali organizzati dalle Nazioni Unite per predisporre accordi in materia ambientale e, specificatamente, in materia di cambiamento climatico.
La tesi sempre più diffusa è che troppo diverse siano le esigenze e i problemi economici e sociali dei vari Paesi per individuare punti comuni di interesse intorno ai quali formare una uniformità di vedute che permetta di giungere a accordi vincolanti. Di conseguenza, tutti gli sforzi sono diretti al limitato obiettivo di trovare punti di convergenza tra molteplici e spesso contrapposte esigenze, essendo inutili i tentativi di risolvere i problemi sul tappeto.
A ciò deve aggiungersi che la maggior parte degli accordi in materia ambientale, e soprattutto gli accordi per contenere il cambiamento climatico, incidono in modo rilevante sulle prospettive di crescita economica e, per i Paesi meno sviluppati, sul diritto allo sviluppo, riconosciuto dalle stesse Nazioni Unite come diritto umano fondamentale. Questa è la ragione per la quale i Paesi emergenti si sono finora categoricamente rifiutati di assumere impegni per la riduzione delle emissioni di gas serra, visti non come semplici obiettivi rivolti alla tutela dell’ambiente, ma come un ingiusto consolidamento dello status quo esistente e una limitazione del loro diritto alla crescita economica.
Il fallimento della COP-15 di Copenhagen del dicembre 2009 sul cambiamento climatico, conclusasi con la semplice “presa d’atto” di un accordo non vincolante dopo due anni di negoziazioni rivolte a porre le basi di un nuovo regime globale per il contenimento del cambiamento climatico, sostitutivo del Protocollo di Kyoto destinato a scadere nel 2012, è stato considerato da molti la dimostrazione di questo assunto. Il nulla di fatto nella COP-16 dell’anno seguente di Cancun è parsa una ulteriore, definitiva conferma: con le conferenze globali non si va da nessuna parte: vanno quindi accantonate una volta per tutte per intraprendere la diversa strada di accordi su specifici punti tra pochi Paesi che condividono interessi, bisogni e prospettive e possono quindi elaborare strategie comuni anche in campo ambientale. Questi accordi dovrebbero costituire poi il punto di aggregazione per altri Paesi che intendono condividerne gli obiettivi e, eventualmente, i vantaggi.
Ma ecco che la COP-17 di Durban del dicembre dello scorso anno sembra aver buttato all’aria tutte queste convinzioni.
Non più all’ultimo minuto, come di consueto, ma addirittura due giorni dopo la data prevista di chiusura della Conferenza (tutti occupati da interminabili diatribe linguistiche tra rappresentanti di Unione europea e India sulle singole parole utilizzate), è stata approvata una “piattaforma” (Durban Platform for Enhanced Action) che impone ai 194 Stati che hanno ratificato la Convenzione Quadro di sviluppare entro il 2015 un protocollo o comunque uno strumento vincolante per tutti che imponga la riduzione delle emissioni di gas serra e nello stesso tempo offra i mezzi ai Paesi in via di sviluppo per passare verso sistemi più puliti di produzione dell’energia. L’attuazione del protocollo è prevista a partire dal 2020.
Ha affermato la costaricana Christiana Figueres, segretario esecutivo della Convenzione quadro, che gli accordi raggiunti a Durban si dimostreranno tra i più importanti e decisivi per il controllo del clima. Analoga valutazione è stata manifestata anche dal Commissario dell’Unione europea per le azioni in materia di cambiamento climatico Connie Hedegaard, e, sia pure con modalità più contenute, anche dagli esponenti delle principali organizzazioni ambientaliste: questi, pur criticando il rinvio al 2020 delle iniziative concrete per il contenimento delle emissioni, hanno ritenuto un fatto assai positivo che finalmente sia stata concordata con la partecipazioni di tutti i maggiori responsabili del cambiamento climatico una road-map per giungere a una normativa internazionale vincolante per tutti. Perché questa è la grande novità: per la prima volta viene accantonata la distinzione tra Paesi ricchi e Paesi poveri e non si fa parola del principio della responsabilità storica dei Paesi già sviluppati nella produzione del cambiamento climatico, principio che sinora aveva permesso ai Paesi emergenti (Cina, India, Brasile, Sudafrica) di essere esentati da qualsiasi impegno vincolante e aveva indotto gli Stati Uniti a non aderire proprio per la ritenuta assurdità di questa esenzione. In base a quanto stabilito nella piattaforma tutti i Paesi sono tenuti a contribuire, secondo le loro capacità, al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione del cambiamento climatico.
* Avvocato in Milano
Energy Roadmap 2050.
SIMONETTA SANDRI*
L’Energy Roadmap 2050, pubblicata il 15 dicembre 2011 dalla Commissione europea (COM 2011, 885/2)1, rappresenta un passo importante verso un sistema energetico a emissioni zero.
La strategia dell’Unione europea verso un’economia “low carbon” – peraltro intrapresa fin dalla definizione dei target 20-20-20 (riduzione del 20% delle emissioni che provocano alterazioni climatiche, 20% di energia verde, incremento del 20% dell’efficienza energetica) – mira ad una riduzione dei gas serra dell’80%-95%, rispetto ai livelli del 1990, entro il 2050.
Il documento riconosce che le rinnovabili e l’efficienza energetica devono avere un ruolo maggiore nelle forniture energetiche europee, tanto nell’immediato che nel futuro.
In generale, per raggiungere il suddetto obiettivo di riduzione dei gas serra, è necessaria una presenza in crescendo delle fonti di energia rinnovabili, con un nuovo modello energetico che renda il sistema sicuro, competitivo e sostenibile sul lungo termine.
L’Energy Roadmap 2050 costituisce un quadro normativo europeo di riferimento.
La strategia si basa su una serie di scenari futuri, tracciati ipotizzando l’adozione di diverse politiche in materia di efficienza energetica, rinnovabili e cattura e stoccaggio della CO2.
L’individuazione delle diverse prospettive servirà agli Stati membri per identificare con maggiore semplicità e chiarezza le misure da adottare in materia di politiche energetiche.
La Roadmap, ad esempio, dimostra che decise politiche di incentivazione delle fonti energetiche “low carbon” permetterebbero di arrivare a un contributo delle rinnovabili del 75% rispetto al consumo energetico lordo al 2050 e del 97% del consumo elettrico. Il che, tuttavia, potrebbe tradursi in realtà solo se venissero adottate anche misure efficaci nella direzione del taglio dei consumi, attraverso l’efficienza energetica che potrebbe abbattere la domanda energetica del 41% entro il 2050 rispetto ai picchi registrati nel 2005-2006. Il risparmio energetico rimane una responsabilità di tutti, unitamente ad una corretta gestione della domanda.
La tabella di marcia presentata dalla Commissione europea, infine, contiene un esplicito riferimento alla necessità di interventi mirati sul piano delle infrastrutture. La realizzazione di reti “intelligenti” e di sistemi di stoccaggio dell’energia (tipo CCS), in particolare, si rivelerebbe fondamentale nella creazione di un sistema energetico europeo più sostenibile ed efficiente.
Il testo coinvolge anche il settore dei trasporti, nel quale la discussione è orientata sia a una riduzione dell’utilizzo dei combustibili fossili, sia a un impiego crescente dei biocarburanti.
Un ruolo fondamentale è riconosciuto, poi, al gas, come elemento critico e rilevante nella trasformazione del sistema energetico, tanto nel suo ruolo sostitutivo rispetto al carbone, che nella sua rilevanza nella produzione di energia elettrica.
La dimensione sociale della Roadmap è inserita, infine, come aspetto di particolare rilievo. La transizione richiederà, infatti, forza-lavoro che sia educata e formata adeguatamente, oltre ad un rigoroso e maggiore dialogo sociale.
La conclusione sintetizza le parole chiave che saranno, dunque, priorità alla piena implementazione della strategia europea 2020, efficienza energetica, rinnovabile, ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, prezzi dell’energia che ne riflettano meglio i costi (con attenzione ai gruppi più vulnerabili), nuove infrastrutture energetiche e di stoccaggio, sicurezza negli approvvigionamenti, efficienti relazioni energetiche internazionali.
* Environment manager presso Eni exploration & production – SEQ – AMTE.
1 Il documento è costituito da 4 capitoli: 1. Introduzione; 2. Un sistema energetico sicuro, competitivo e de-carbonizzato possibile nel 2050; 3. Sfide ed opportunità dal 2020 al 2050; 4. Il “way forward”.
Pubblicato su Osservatorio AD il 10 gennaio 2012
La natura dei pareri dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ex INFS, in materia venatoria.
PAOLA BRAMBILLA*
La giurisprudenza non ha tuttora trovato un orientamento uniforme sulla vincolatività del parere espresso dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ex Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, INFS); ad oggi infatti, nonostante gli accresciuti poteri riconosciuti all’ente sia dalle recenti modifiche alla L. 157/92, sia dagli organismi comunitari si registrano discorsi pronunciamenti; talora l’acquisizione del parere viene vista come mero onere procedimentale, talora invece come strumento in grado di condizionare la politica delle pubbliche amministrazioni, Province e Regioni in primis, deputate alla protezione ed alla gestione della fauna selvatica.
Pure gli ultimi arresti di ogni ordine e grado generati dall’ultima tornata di piani e calendari venatori non contribuiscono a diradare la nebbia giurisprudenziale che persiste sul tema.
Vediamo allora, per cercare di ricomporre un quadro di riferimento quanto meno sotto il profilo normativo, in quali casi la legge n. 157/1992 (legge quadro sull’attività venatoria) prevede che si debba richiedere un parere all’istituto.
Un primo caso è previsto dall’art. 4, secondo il quale è facoltà delle Regioni “su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica”, autorizzare la cattura degli uccelli per fini di richiamo (art. 4), mentre una seconda ipotesi è dettata dall’art. 18, per cui, ai fini dell’approvazione del calendario venatorio è necessario aver previamente “sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica”.
E ancora, il legislatore ha attribuito alle Regioni la facoltà di autorizzare il prelievo venatorio in deroga ai sensi dell’art. 9 della direttiva 2009/147/CE (art. 19-bis), solo una volta “sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS),o gli istituti riconosciuti a livello regionale”.
Ciò premesso, partendo dunque dalla cattura degli uccelli da richiamo, in una prima fase i giudici amministrativi di primo grado hanno condiviso il principio per cui le singole Province, anche in assenza del prescritto parere dell’INFS, potessero comunque approvare un piano di cattura, sia pure solo a seguito di una particolareggiata e prudenziale istruttoria (cfr. ex multis TAR Milano, sent. n. 5784/2008); istruttoria che nel merito è però sempre stata ritenuta carente, con il conseguenziale annullamento, in pressoché tutte le ipotesi, dei i provvedimenti gravati per carenza di motivazione, nonché per l’inosservanza delle disposizioni regionali alle tassative prescrizioni della direttiva 2009/147/CE (già 79/40/CEE), interpretate in senso sempre più restrittivo dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria. Se infatti la Corte di Giustizia ha spesso (cfr. causa C-79/03), ritenute non selettive e non adeguate ai criteri comunitari modalità di cattura con reti o parany, di recente anche la Corte Costituzionale ha fatto proprio l’orientamento comunitario affermando, da ultimo, nella pronuncia 190 del 17 giugno 2011, con cui ha annullato le leggi regionali toscana e lombarda, affermando che le stesse non chiarivano perché una campagna di allevamento in cattività, tempestivamente promossa e realizzata, non fosse idonea a fornire il fabbisogno necessario di richiami vivi, in tal modo costituendo, secondo le prescrizioni rese in sede consultiva dall’ISPRA, «una valida alternativa alla cattura», non selettiva, dei medesimi.
Proprio in subiecta materia, dunque, la Corte Costituzionale, anche con la precedente pronuncia n. 266/2010 ha riconosciuto ai pareri dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, una diretta cogenza nei confronti delle Amministrazioni regionali richiedenti.
Il giudice delle leggi, in particolare, ha fatto propria l’interpretazione secondo la quale il parere dell’ISPRA risponde ad un’esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, correlata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato al riguardo, ponendo così un drastico limite a interventi regionali forieri di recare pregiudizio agli equilibri ambientali, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.
Passando poi al versante dei calendari venatori regionali, la giurisprudenza pareva ormai essersi attestata sull’opinione per cui il parere reso dall’ente avrebbe natura obbligatoria ma non vincolante. Da ciò la conseguenza che l’organo di amministrazione attiva, per potersi legittimamente discostare dal parere dell’ISPRA, dovesse motivare analiticamente in merito alle ragioni per cui riteneva di non doversi attenere alle indicazioni, spesso penetranti, ivi espresse (cfr. ex multis, TAR Umbria, sent. n. 459/1997).
In linea con la giurisprudenza maggioritaria di cui sopra, si inseriscono le recentissime pronunce cautelari rese nel rinnovato quadro normativo della L. 157/92, così come modificata dalla c.d. legge comunitaria 2009; la legge n. 96/2010, infatti, con l’articolo 42, ha apportato significative modifiche alla normativa nazionale, per nulla conforme alla direttiva uccelli, introducendo nuovi divieti di caccia nel periodo di migrazione e postnuziale.
La maggior parte di tali ordinanze hanno sospeso i calendari venatori regionali contenenti tempi di caccia estesi oltre le finestre comunitarie, rilevando come le osservazioni provenienti dall’organo scientifico e tecnico di consulenza di cui all’art. 7 della L. 157/1992 possano essere disattese dall’amministrazione a condizione che vengano esplicitate le valutazioni che hanno condotto a disattendere il parere (TAR Abruzzo, ord. n. 357/2011, TAR Calabria, ord. n. 774/2010), generalmente del tutto assenti
In senso opposto si sono però mossi altri collegi che, chiamati a decidere sulla legittimità di alcuni calendari venatori provinciali del tutto irrispettosi delle indicazioni fornite dall’ISPRA, non hanno concesso la misura cautelare sospensiva (cfr. TAR Brescia, ord n. 856/2011, TAR Firenze, ord. n. 981/2010), ritenendo sufficiente la presenza di motivazioni generiche, di mero stile, e financo la tutela degli interessi ricreativi sottesi all’esercizio venatorio.
Emerge, in questo quadro, per originalità giurisprudenziale, la recentissima ordinanza del TAR Lazio n. 4392 del 25.11.2011, che ha sospeso gli effetti del calendario venatorio regionale proprio in quanto la Regione, nell’approvarlo, non ha tenuto in particolare considerazione le osservazioni di ISPRA contenute nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. 157/92, così come modificata dalla Legge comunitaria 2009, art. 42”, indicazioni elaborate dall’istituto e indirizzate a tutte le Regioni proprio per la corretta applicazione, nell’elaborazione dei calendari venatori, degli standard minimi uniformi di tutela della fauna selvatica.
In sede di merito si dovrebbe però registrare un riallineamento delle pronunce, in quanto nel frattempo la stessa Commissione europea ha diramato un documento, in risposta a un quesito di un’associazione venatoria, in cui riconosce espressamente all’ISPRA quelle funzioni di indirizzo uniforme a livello nazionale, di alto profilo scientifico, che garantiscono la corretta e omogenea applicazione delle norme di derivazione comunitaria anche a livello nazionale.
Maggiormente intricata si configura la problematica dell’effettiva cogenza del parere formulato dall’ISPRA, nei confronti dell’ultima fattispecie qui trattata, quella del prelievo venatorio in deroga, anche quest’anno disposto con leggi regionali (è il caso della Lombardia) o con provvedimenti amministrativi (è il caso del Veneto) in violazione del dettato comunitario, come accertato dalle numerose condanne subite dall’Italia nell’ambito di reiterate procedure di infrazione, culminate da ultimo nelle sentenze della Corte di Giustizia del 15 luglio 2010 (C-573/08), dell’11/11/2010, nella causa C-164/09, e infine del 3 marzo 2011, nella causa C-508/09.Ora, la giurisprudenza nazionale in questo quadro si è occupata degli aspetti della mancata conformità dei provvedimenti autorizzatori della caccia in deroga ai sensi dell’art. 19-bis della L. 157/1992, rispetto all’art. 9 della dir. 2009/147/CE, criticità – per dirla con le parole del Consiglio di Stato – accentuata dal fatto che lo stesso dettato statale non detta nessuna modalità per garantire che non si superi il limite nazionale indicato, a livello scientifico, dall’INFS in un certo quantitativo, né tanto meno assicura un tempestivo controllo (cfr. Cons. Stato, sent. n. 1054/2009). In quell’occasione, i giudici di Palazzo Spada non hanno potuto far altro che constatare come la limitata cogenza del parere dell’INFS costituirebbe uno degli aspetti del difforme recepimento a livello nazionale della normativa comunitaria; a tal punto che la sentenza giungeva a disapplicare la normativa interna per dare riespansione al divieto generale di caccia della direttiva, escludendo la legittimità di ogni deroga.
Nel quadro normativo attuale sulla caccia in deroga, riformato rispetto ai tempi della vertenza di cui sopra, l’orientamento sulla natura del parere ISPRA è stato ripreso da talune recenti ordinanze di alcuni Tribunali amministrativi regionali che, nel respingere la sospensione dei provvedimenti regionali di deroga gravati, hanno definito come obbligatorio, ma non vincolante, il parere negativo proferito dall’ISPRA alle Regioni richiedenti; sicchè le Regioni si potrebbero discostare dal parere negativo di ISPRA in ordine alla sussistenza delle condizioni per l’autorizzazione delle deroghe mediante l’approvazione di un provvedimento adeguatamente motivato sotto il profilo scientifico giuridico; così l’ordinanza del TAR Veneto n. 876/2011 e quella del TAR Liguria n. 510/2011, passate indenni anche dall’appello cautelare. Successivamente alle pronunce cautelari è però giunta all’Italia, e alla Regioni responsabili delle plurime violazioni della direttiva uccelli, il 24 novembre 2011, una comunicazione della Commissione europea, relativa all’avvio di una procedura di infrazione nei confronti del Governo italiano per la comminatoria dell’irrogazione di una sanzione pecuniaria per il mancato rispetto delle sentenze di condanna; l’effetto è stato il ritiro, da parte della Regione Liguria e della Regione Lombardia, dei provvedimenti di deroga, timorose della rivalsa da parte dello Stato.
Pare allora, dalla disamina delle pronunce formatesi sui pareri di ISPRA resi sulla disciplina regionale e provinciale dell’attività venatoria, e sul carattere vincolante o meno degli stessi, che la questione possa trovare un’adeguata risposta se analizzata alla luce di una diversa prospettiva, quella della doverosa riforma della normativa nazionale, che è a tutt’oggi non conforme al dettato comunitario.
Solo una più analitica disciplina di dettaglio delle deroghe, che escluda la possibilità di una normazione con legge regionale (difficilmente caducabile in tempi sufficienti ad evitare abusi, visto anche il veloce passaggio dei migratori spesso oggetto della caccia in deroga) da un lato, e dall’altro che indichi le modalità dei censimenti e delle rilevazioni scientifiche atte a determinare il concetto di piccole quantità, da stabilirsi non su scala regionale, ma per lo meno nazionale, se non comunitaria o internazionale. Ciò in quanto le specie, in particolare migratrici, sono certo patrimonio indisponibile dello Stato, come recita l’art. 1 L. 157/92, ma tale loro qualifica non sta a significare tanto un concetto dominicale, ma l’attribuzione di un compito di tutela “nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale”, come recita la seconda parte dell’art. 1, più negletta. Ed è lo stesso concetto che echeggia nel preambolo dell’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa-Eurasia concluso all’Aia il 15 agosto 1996, ed entrato in vigore nel 1999: “gli uccelli acquatici migratori costituiscono una parte importante della diversità biologica mondiale e, conformemente allo spirito della Convenzione sulla diversità biologica, e dovrebbero essere conservati a beneficio delle generazioni presenti e future”.
Questo maggior dettaglio della disciplina del potere di deroga però non basta. Un certo margine di discrezionalità deve residuare, per garantire un’applicazione della disciplina efficace e modulata sul caso concreto; certo, fermo restando che una deroga, per essere tale, deve essere eccezionale nella sua applicazione e quindi, per usare le parole della Corte di Giustizia nelle pronunce di condanna dell’Italia, non dar vita ad un sistema permanente di caccia, sempre in vigore, stagione venatoria dopo stagione venatoria.
Ecco allora che una volta reso conforme il quadro nazionale a quello comunitario, il ruolo di ISPRA sarebbe meno caricato di quella funzione nomofilattica che di fatto oggi svolge in via vicaria rispetto a molte delle istituzioni italiane, regionali e statuali: basta ricordare che il Consiglio dei ministri, tenutosi all’indomani dell’emanazione dell’ultima edizione della legge regionale lombarda sulla caccia in deroga n. 13/2011, aveva deciso di non impugnarla avanti alla Corte Costituzionale, salvo poi subire gli strali della Commissione che alla fine hanno determinato Regione Lombardia ad abrogare le proprie disposizioni con L.r. 24/2011, un giorno prima della chiusura del prelievo in deroga.
Il parere di ISPRA diverrebbe allora lo strumento deputato all’espressione della valutazione scientifica, operata a livello nazionale, della coerenza della gestione faunistica decisa ai successivi livelli regionale e provinciale, nell’ambito di quella discrezionalità tecnica che ora, quale sua misura, ha il canone della sostenibilità. Del resto ricordiamo che l’art. 7 della L. 157/92, vent’anni fa, affidava all’Istituto il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l’evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l’attività di inanellamento a scopo scientifico sull’intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle Regioni e dalle Province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome; in altre parole, di monitorare e perseguire quegli standard minimi uniformi di tutela ambientale di cui all’art. 117, c. 2, lett. s), Cost., anche nella materia faunistica.
In tale quadro la natura meramente obbligatoria, ovvero anche vincolante dei pareri dell’ente, di fatto perderebbe di rilevanza, stante la sostanziale impossibilità, per le Regioni, di derogare siffatti standard.
* Avvocato in Bergamo
Pubblicato su Osservatorio AD il 4 gennaio 2012
I risultati della settimana europea per la riduzione dei rifiuti.
CARLO LUCA COPPINI*
Con il sostegno dei principi comunitari in materia di prevenzione dei rifiuti, intendendo per prevenzione ogni misura presa prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, si è conclusa anche la terza edizione della settimana europea per la riduzione dei rifiuti (SERR). A partire dal 2009 anche l’Italia ha dimostrato il proprio intento di aderire al programma di riduzione delle quantità eccessive di rifiuti nella consapevolezza dei propri obblighi derivanti dalla direttiva 2008/98/CE.
Come osservato nel precedente contributo riguardante l’argomento in parola, l’urgenza di dover approntare gli strumenti “preventivi” deriva dalle prescrizioni comunitarie che, attraverso il coordinamento dei 34 organizzatori dislocati nei 20 Paesi europei (la lista degli organizzatori è reperibile sul sito ufficiale della SERR) pongono l’obbligo di adottare i programmi di prevenzione posti dall’art. 29 della suddetta direttiva, a partire dalla fine del 2013.
Ai sensi della suddetta disposizione, infatti: “1. Gli Stati membri adottano, a norma degli articoli 1 e 4, programmi di prevenzione dei rifiuti entro il 12 dicembre 2013. Tali programmi sono integrati nei piani di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 28 o, se opportuno, in altri programmi di politica ambientale oppure costituiscono programmi a sé stanti. In caso di integrazione nel piano di gestione o in altri programmi, vengono chiaramente identificate le misure di prevenzione dei rifiuti. 2. I programmi di cui al paragrafo 1 fissano gli obiettivi di prevenzione. Gli Stati membri descrivono le misure di prevenzione esistenti e valutano l’utilità degli esempi di misure di cui all’allegato IV o di altre misure adeguate. Lo scopo di tali obiettivi e misure è di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. 3. Gli Stati membri stabiliscono gli appropriati specifici parametri qualitativi o quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti, adottate per monitorare e valutare i progressi realizzati nell’attuazione delle misure e possono stabilire specifici traguardi e indicatori qualitativi o quantitativi, diversi da quelli menzionati nel paragrafo 4, per lo stesso scopo. 4. Gli indicatori per le misure di prevenzione dei rifiuti possono essere adottati secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 39, paragrafo 3. 5. La Commissione crea un sistema per lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti ed elabora orientamenti per assistere gli Stati membri nella preparazione dei programmi”.
Il denominatore comune che ha distinto la settimana trascorsa in Italia, Belgio, Francia, Portogallo, Spagna, Malta e Regno Unito è rappresentato dalle cinque categorie con le quali sono stati configurati altrettanti temi simbolici da utilizzare per fornire concrete risposte alla razionalizzazione dello sfruttamento dei rifiuti e/o alla riduzione della relativa produzione e ciò mediante: a) riduzione dei rifiuti cartacei, b) riduzione dei rifiuti da cibo, c) ripara e riutilizza, d) riduzione degli imballaggi in eccesso ed e) giornate della pulizia. A titolo puramente esemplificativo, si pensi che in Piemonte è stata promossa un’azione, “Cucinare con gli avanzi”, che ha visto protagonista un laboratorio di cucina organizzato per offrire un pasto cucinato con soli avanzi. Ed ancora, in Emilia Romagna, i detenuti delle Case Circondariali di Bologna, Ferrara, Forlì e Cesena si sono industriati per recuperare i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Progetto RAEE).
A tale riguardo, devo evidenziare che, in un recente passato ma per altri e diversi motivi, ho dovuto esaminare l’archivio della Manifattura Tabacchi di Modena (1851- 2002) presso l’Archivio di Stato di Modena, segnatamente nella parte dedicata all’inventario sommario a cura della Cooperativa C.S.R. Centro Studi e Ricerche di Modena (Luglio 2009), in cui ho potuto rintracciare un’importante affinità con le diverse attività previste per la riduzione della produzione dei rifiuti che contraddistingue l’attuale programma comunitario. In particolare, il suddetto inventario prevedeva espressamente una voce, riportata al punto, 1.5.4, intitolato: “Avanzi/Rifiuti”, in cui veniva descritta la funzione del magazzino rifiuti che aveva il compito: “omissis… del ricevimento, della custodia, della perizia dei tabacchi avariati o comunque ritirati dalla vendita (per bagnamento, schiacciamento, ecc.) per determinare l’ammontare del danno (da imputare ai responsabili) e la loro riutilizzazione o la loro distruzione.” Dalla soluzione sopra esposta, è possibile comprendere: a) che la previsione della prevenzione dei rifiuti fosse già in atto, in alcune imprese italiane, in un tempo anteriore all’avvento della categoria del “sottoprodotto” di cui parla l’art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006 nonché della programmazione europea volta a ridurre la produzione dei rifiuti e b) che, nella consapevolezza della scarsità di materie prime che distingue l’Europa, in generale come l’Italia, in particolare, produrre meno rifiuti è un essenziale sintomo rivelatore dell’efficienza e del razionale sfruttamento delle risorse disponibili.
Le previsioni europee, quindi, costituiscono senza ombra di dubbio un importante strumento per sollecitare l’attenzione di ogni operatore, sia pubblico (Pubbliche Amministrazioni, Scuole, Università) sia privato (imprese ed amministrazioni condominiali) ad improntare precisi programmi di educazione volti ad accrescere la consapevolezza di tutti i cittadini europei in merito alle possibili e percorribili strategie di riduzione e/o di conveniente riutilizzo dei rifiuti sull’indefettibile presupposto che, come anche recentemente ribadito dalla Corte Costituzionale: “…omissis…anche la specie del rifiuto non è estranea al più ampio genere di bene commercialmente rilevante in grado di formare oggetto dello svolgimento di attività imprenditoriale, tanto da farlo ritenere un prodotto” (Corte Cost., 25 luglio 2011, n. 244).
La sussistenza di una buona correlazione tra la suddetta programmazione e lo spirito del legislatore italiano, sotto il comune denominatore della scarsità delle risorse, emerge persino dalla lettura della prima legge che, poco tempo dopo l’insorgere del secondo conflitto mondiale, veniva emanata per disciplinare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Ed invero, ai sensi dell’art. 4 della L. 20 marzo 1941, n. 366, il Ministero dell’Interno competente in materia di rifiuti provvedeva a: “…omissis… b) promuovere presso Enti o privati, studi ed esperienze che tendano a conseguire il migliore attrezzamento dei servizi e la più conveniente utilizzazione dei rifiuti solidi urbani” nonché, ai sensi del successivo art. 5, primo comma, lo stesso Ministero aveva la facoltà di: “.. omissis … disporre, presso ogni Comune del Regno, l’esecuzione di particolari esperimenti, anche a carattere tecnico-industriale, per lo studio e la risoluzione dei problemi attinenti in genere al perfezionamento dei servizi ed alla migliore e più economica utilizzazione dei rifiuti.”
A distanza di oltre sessant’anni, quindi, le suddette previsioni risultano rispecchiare pienamente gli obiettivi che la direttiva 2008/98/CE precisa nei propri “consideranda” in cui, infatti, è stato destinato un preciso spazio alla necessità di fissare una gerarchia dei rifiuti fissata nel successivo art. 4, comma 1 (cfr. C. L. Coppini, La settimana europea di riduzione dei rifiuti dal 19 al 27 novembre 2011, in questo Osservatorio, 2011) e disciplinata nel successivo comma 2, secondo cui: “Nell’applicare la gerarchia dei rifiuti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. A tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall’impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti.
I tempi previsti per garantire il raggiungimento fissato nella gerarchia dei rifiuti sono sanciti dal successivo art. 9, intitolato: “Prevenzione dei rifiuti” in cui vengono scandite a chiare lettere le diverse tappe che i paesi membri dovranno rispettare per allinearsi ai programmi. In particolare, si prevede che: “omissis … Previa consultazione dei soggetti interessati, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le seguenti relazioni corredate, se del caso, di proposte concernenti le misure necessarie a sostegno delle attività di prevenzione e dell’attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui all’articolo 29 comprendenti:
a) entro la fine del 2011, una relazione intermedia sull’evoluzione della produzione dei rifiuti e l’ambito di applicazione della prevenzione dei rifiuti, che comprende la definizione di una politica di progettazione ecologica dei prodotti che riduca al contempo la produzione di rifiuti e la presenza di sostanze nocive in essi, favorendo tecnologie incentrate su prodotti sostenibili, riutilizzabili e riciclabili;
b) entro la fine del 2011, la formulazione di un piano d’azione per ulteriori misure di sostegno a livello europeo volte, in particolare, a modificare gli attuali modelli di consumo;
c) entro la fine del 2014 la definizione di obiettivi in materia di prevenzione dei rifiuti e di dissociazione per il 2020, basati sulle migliori prassi disponibili, incluso, se del caso, un riesame degli indicatori di cui all’articolo 29, paragrafo 4.
* Avvocato in Milano
Pubblicato su Osservatorio AD il 2 gennaio 2012
Corte di Giustizia e valutazioni ambientali: la considerazione degli “effetti cumulativi” nella valutazione di impatto ambientale di un progetto non è un optional e la valutazione di incidenza deve sempre assicurare l’assenza di pregiudizio al sito protetto oltre ogni “ragionevole dubbio” (anche laddove l’intervento sia giustificato da un motivo di rilevante interesse pubblico).
MATTEO CERUTI*
La sentenza della Quarta Sezione della Corte di Giustizia 24 novembre 2011, procedimento C 404/09, emessa nel ricorso per inadempimento della Commissione europea contro il Regno di Spagna, reca importanti precisazioni in materia di valutazioni ambientali, con riferimento alle autorizzazioni rilasciate dalle autorità di quel Paese per alcune miniere di carbone a cielo aperto.
Il primo significativo chiarimento riguarda la questione della considerazione degli “effetti cumulativi” nella valutazione di impatto ambientale (la questione è affrontata ai §§ 76 e ss. della sentenza).
Si tratta di tematica molto sviluppata in sede tecnica, ma sinora poco esplorata sul piano giuridico .
Il fondamento normativo di questo contenuto della VIA è rinvenibile in una nota apposta in calce al punto 4, dell’allegato IV della direttiva 85/337/CEE nella versione modificata dalla direttiva 97/11, ove si precisa che la “descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull’ambiente” – che costituisce l’oggetto fondamentale delle informazioni che il committente è tenuto a fornire (ossia quello che per noi è il “cuore” dello studio di impatto ambientale) – “dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto”.
Viene respinta l’interpretazione riduttiva della previsione, sostenuta dal Regno di Spagna, fondata sul dato letterale dell’impiego del verbo al condizionale (per cui questa descrizione “dovrebbe riguardare …”) da cui si evincerebbe che tale analisi degli effetti cumulativi dei progetti sull’ambiente sarebbe non obbligatoria ma soltanto “auspicabile”, ed invece valorizzata dalla Corte un’interpretazione teleologica della direttiva, tenendo conto dell’ambito di applicazione “esteso” e dell’obiettivo “molto ampio” della direttiva 85/337 modificata (quali emergono dagli artt. 1 e 3 di quest’ultima).
Di qui la conclusione del Giudice europeo secondo cui la suddetta disposizione dev’essere intesa nel senso che la valutazione degli effetti di un progetto in sede di VIA deve obbligatoriamente “anche includere un’analisi degli effetti cumulativi sull’ambiente che tale progetto può produrre se viene considerato congiuntamente ad altri progetti” giacché una tale analisi “è necessaria per garantire che la valutazione comprenda l’esame di tutti gli effetti notevoli sull’ambiente”.
Nel caso concreto si conclude che la valutazione dell’impatto ambientale di due progetti minerari autorizzati era risultata carente dell’analisi degli effetti cumulativi da ritenersi indispensabile in quanto le miniere interessate (denominate «Nueva Julia» e «Ladrones») sono situate in prossimità tra loro e le relative procedure di autorizzazione si erano svolte parallelamente.
Infine la Corte respinge anche l’ultimo argomento difensivo dello Stato membro secondo cui un’analisi cumulativa degli impatti delle due miniere era stata comunque condotta, ancorché dopo il rilascio delle autorizzazioni: sul punto la decisione precisa che non è possibile “rimediare” alla mancanza di tale analisi nell’ambito della valutazione iniziale, poiché la VIA dev’essere necessariamente “preliminare” all’autorizzazione del progetto (ex art. 2, n. 1, della direttiva 85/337 modificata).
Il medesimo principio della necessaria anteriorità della valutazione rispetto all’autorizzazione di un progetto (e della conseguente irrilevanza di studi eseguiti ex post nel tentativo di pervenire ad improbabili sanatorie) viene quindi espresso dalla sentenza anche in materia di valutazione degli effetti sui siti protetti dalla direttiva habitat 92/43/CEE (vds. i §§ 97 ss.).
Nella pronuncia si perviene dunque alla conclusione che le valutazioni di incidenza ambientale dei progetti relativi a due degli impianti minerari a cielo aperto considerati non potevano essere ritenute appropriate poiché risultavano caratterizzate dall’assenza di rilievi e di conclusioni “completi, precisi e definitivi” sugli effetti delle attività sulle zone protette, tali perciò da dissipare “qualsiasi ragionevole dubbio scientifico” in ordine agli effetti di detti progetti, in particolare, sulla popolazione del gallo cedrone cantabrico, la cui conservazione costituisce uno degli obiettivi della tutela (§ 105).
Inoltre a fronte dell’obiezione del Regno di Spagna circa l’importanza delle attività minerarie per l’economia locale, la Corte ricorda che tale considerazione può effettivamente costituire un “motivo imperativo di rilevante interesse pubblico” da considerare ai fini dell’eventuale autorizzazione in deroga sensi dell’art. 6, n. 4, della direttiva habitat, ma da valutare soltanto dopo che gli effetti di un piano o di un progetto siano stati analizzati in quanto la conoscenza degli stessi costituisce un “presupposto imprescindibile” ai fini della stessa applicazione della predetta disposizione derogatoria. E ciò per due ordini di ragioni: sia in quanto l’esame di eventuali motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (e della connessa questione se sussistano alternative meno dannose) richiede comunque una ponderazione del pregiudizio che deriverebbe al sito dal piano o dal progetto; sia perché il pregiudizio del sito dev’essere identificato con precisione allo scopo di stabilire la tipologia delle eventuali misure compensative (§ 109).
Trattasi di affermazioni di principio per la verità già contenute in diversi precedenti della giurisprudenza europea sulla direttiva 92/43/CEE, ma che vale comunque la pena di rammentare. Anche perché, francamente, negli ultimi tempi non pare che la Commissione UE risulti sempre averli perfettamente presenti allorché decide di archiviare procedure di infrazione aventi ad oggetto interventi in zone tutelate dalla direttiva habitat solo perché il Paese membro ha esaltato le ragioni di rilevanza per l’economia – locale o nazionale – di un progetto (sovente una “grande opera”), ovvero poiché le autorità nazionali hanno comunque avviato ex post procedure per sanare carenze nell’analisi degli effetti dell’intervento già autorizzato.
* Avvocato in Rovigo
Pubblicato su Osservatorio AD il 2 gennaio 2012





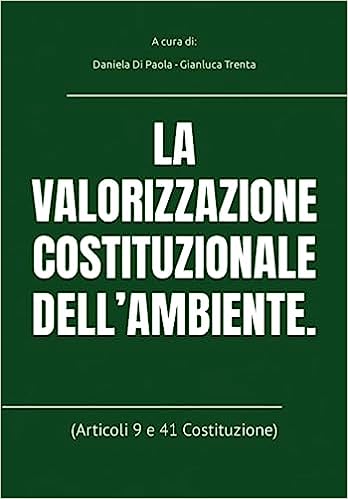
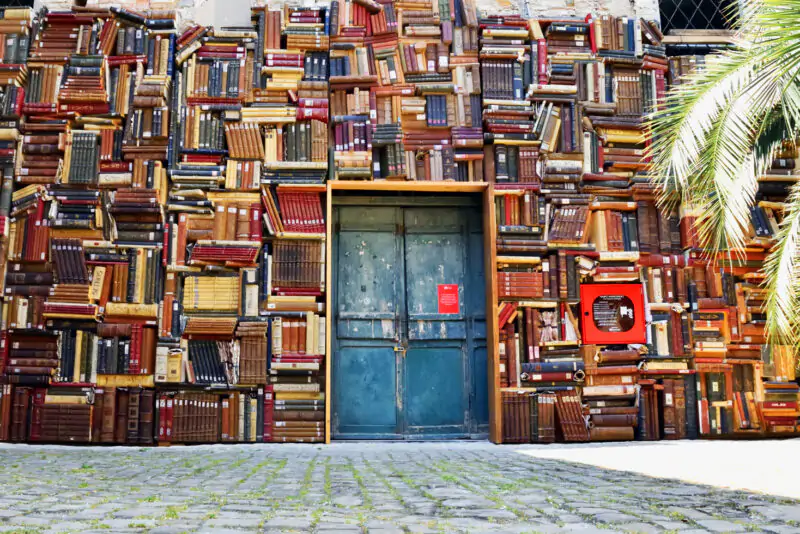 AMBIENTEDIRITTO.IT Casa Editrice
AMBIENTEDIRITTO.IT Casa Editrice