Il caso Adamu.
GIULIA GAVAGNIN*
Il Tas di Losanna ha pubblicato la decisione finale1 del procedimento arbitrale tra Amos Adamu, un ex membro nigeriano del Fifa Executive Committee2, e la FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Il Tas ha confermato la decisione del Fifa Appeal Committee3 del 3 febbraio 2011 che aveva interdetto Adamu dalla partecipazione ad ogni attività legata al mondo del calcio, sia a livello nazionale che internazionale, per un periodo di 3 anni a partire dal 20 ottobre 2010, oltre ad una sanzione pecuniaria di 10.000 franchi svizzeri.
Il caso ha fatto molto discutere, soprattutto in Inghilterra, dove il caso è stato provocato.
Il 17 ottobre 2010, infatti, il quotidiano inglese Sunday Times ha pubblicato un articolo che riferiva di forti sospetti circa fenomeni di corruzione interni alla FIFA legati alla selezione del Paese ospitante la Coppa del Mondo. Alcuni giornalisti del Sunday Times si sono finti lobbisti di una fantomatica società privata statunitense che intendeva fare pressioni affinchè gli Stati Uniti ottenessero l’assegnazione della Coppa del Mondo del 2018 o del 2022 ed hanno avvicinato alcuni membri dell’Executive Committee con la promessa di una dazione di denaro. Adamu, in particolare, si è dichiarato disposto ad accettare 800.000 dollari da una giornalista del menzionato giornale a fronte di una sua collaborazione al progetto di assegnazione, asserendo che il denaro sarebbe stato impiegato per costruire quattro campi da calcio in fondo sintetico in Nigeria. A seguito della pubblicazione dell’articolo sul ‘Sunday Times’ il Comitato Etico della FIFA (FIFA Ethics Committee)4 ha aperto un procedimento disciplinare contro Adamu al termine del quale lo ha dichiarato colpevole di aver violato il Codice Etico della FIFA (FIFA Code of Ethics)5 e, conseguentemente, lo ha sospeso per tre anni dall’esercizio di qualsiasi attività legata al mondo del calcio6,e lo ha condannato al pagamento di una sanzione di 10.000 franchi svizzeri7.
Con la medesima decisione è stato sospeso (soltanto per un anno) anche un altro membro dell’Executive Committee, il neozelandese Reynold Temarii, al quale, con le medesime modalità, è stata offerta una somma di denaro per finanziare una scuola di calcio nel suo Paese.
Ad entrambi gli ufficiali è stata contestata la violazione degli artt. 3 (norme generali), 9 (lealtà e segretezza), 10 (accettazione e dazione di doni ed altri benefits) e 11 (corruzione) del Codice Etico.
L’art. 11, comma 1, in particolare, statuisce che gli ufficiali devono rifiutare regali od altre utilità che siano loro offerte, promesse o inviate per indurli a non svolgere il loro ufficio o ad agire disonestamente per il vantaggio di terzi8.
A poco vale osservare che la corruttela sia stata accettata a scopo benefico, poiché l’art. 10 del medesimo Codice statuisce che gli ufficiali non possono accettare doni od altri benefits che eccedano il valore di ciò che mediamente è considerato un piccolo donativo: qualora sussista un dubbio sul valore dell’oggetto, il dono deve essere rifiutato9.
Anche qualora i due ufficiali fossero stati in grado di dimostrare di non essere stati corrotti in senso tecnico, la loro condotta sarebbe stata comunque contraria ai principi generali del Codice Etico. L’art. 3 sottolinea che gli ufficiali devono essere consapevoli dell’importanza delle loro funzioni, dei loro obblighi e responsabilità e dell’importante ruolo che ricoprono per promuovere gli obiettivi della FIFA e dei suoi affiliati. In particolare, il comma 3 afferma che gli ufficiali non debbono abusare della loro posizione in alcun modo e, in particolare, non devono approfittare della loro funzione per scopi ed obiettivi privati10.
La decisione è stata confermata dal Comitato per l’Appello della FIFA (FIFA Appeals Committee) il 3 febbraio 2011.
Il 3 maggio 2011 Adamu ha presentato appello al Tas con la richiesta di annullare la decisione della FIFA.
Il Collegio arbitrale ha confermato la decisione della FIFA dichiarando Adamu responsabile per la violazione degli artt. 3, 9 e 11 (corruzione) del Codice Etico della FIFA. Il Tas ha rigettato le argomentazioni difensive, fondate sull’inutilizzabilità delle prove a suo carico perché illecitamente acquisite e tali da ledere i diritti di personalità di Adamu: secondo i suoi legali, la giornalista del Sunday Times avrebbe violato il codice penale svizzero e le prove sarebbero perciò state ottenute in conseguenza di un reato. Adamu ha anche lamentato la violazione dei diritti di personalità.
Il Tas ha rilevato preliminarmente che una prova acquisita non conformemente alle norme del codice penale non inficia il giudizio emesso da un tribunale arbitrale, che non è vincolato al rispetto di quelle norme (questo principio era già stato affermato nel caso WADA/UCI v. Alejandro Valverde/RFEC)11.
In ogni caso, il Tas ha osservato che nessun giudice ordinario ha dichiarato l’illegittimità dell’acquisizione della prova né ne ha vietato l’utilizzo12: perciò non si può affermare che la giornalista del Sunday Times abbia agito illegalmente.
Il Tas ha sottolineato che è di massima importanza che un ufficiale della FIFA non solo sia onesto, ma che sia ritenuto onesto. Il collegio non ha avuto alcun dubbio che Adamu fosse pronto ad accettare la (finta) offerta di denaro, perciò, ha ritenuto la sanzione imposta dalla FIFA legittima e proporzionata al fatto.
La FIFA ha accolto con soddisfazione la decisione del Tas, ribadendo la propria politica di “tolleranza zero” contro fenomeni di questo genere13.
* Avvocato in Venezia
1 Notizia pubblicata su www.tas-cas.org.
2 Il Fifa Executive Committee (ExCo) è il principale organo decisionale per le competizioni Fifa e, principalmente, per la Coppa del Mondo di calcio (FIFA World Cup). Si compone di un presidente, eletto dal congresso l’anno successivo alla Coppa del Mondo, otto vice presidenti e quindici membri, nominati dalle confederazioni e dalle associazioni. Si riunisce almeno due volte l’anno, ogni membro ha un mandato di quattro anni, e il suo scopo principale è quello di stabilire le date, il luogo e le modalità della competizione.
3 Il Comitato d’Appello (FIFA Appeal Committee) ha un numero di componenti variabile ma deve rendere le proprie decisioni in presenza di almeno tre componenti. Ai sensi dell’art. 60 dello Statuto FIFA il suo funzionamento deve essere normato dal Codice Disciplinare (artt. 118-127) ed è competente a decidere sulle decisioni rese dal Comitato Disciplinare (Disciplinary Committee) ed Etico (Ethics Committee).
4 Il FIFA Ethics Committee si compone di un presidente, un vice-presidente e 12 membri, ed ha il compito di vigilare sull’osservanza del Codice Etico.
5 Il Codice Etico (FIFA Code of Ethics) è stato approvato il 6 ottobre 2004 dal Comitato Esecutivo della FIFA (FIFA Executive Committee), per soddisfare il dettato dell’art. 7 dello Statuto FIFA, che impone agli organi sportivi e agli ufficiali di osservare, nelle proprie attività, “lo Statuto, le regole, le decisioni e il Codice Etico”. L’ultima revisione è del 2009.
6 L’art. 17 del Codice Etico dichiara direttamente applicabili le sanzioni previste dallo Statuto e dal Codice Disciplinare FIFA. Nel caso di specie è stata applicata la sanzione di cui all’art. 22 del Codice Disciplinare (FIFA Disciplinary Code): “a person may be banned from taking part in any kind of football-related activity (administrative, sports, or any other)”.
7 Art. 15 Codice Disciplinare.
8 Officials may not accept bribes; in other words, any gifts or other advantages that are offered, promised or sent to them to incite breach of duty or dishonest conduct for the benefit of a third party shall be refused.
9 Officials are not permitted to accept gifts or other benefits that exceed the average relative value of local cultural customs from any third parties. If in doubt, gift shall be declined. Accepting gifts of cash in any amount or form is prohibited.
10 Officials may not abuse their position as part of their function in any way, especially to take advantage of their function for private aims or gains.
11 Con decisione del 31 maggio 2010 (http://www.tas-cas.org/recent-decision) il Tas ha condannato il ciclista Alejandro Valverde alla squalifica per due anni dalle competizioni per accertata positività all’EPO. L’atleta era stato sottoposto al test sangue – urine dal Coni durante una tappa del Tour de France 2008 svoltasi in territorio italiano. Quel test rivelò che il DNA del corridore era lo stesso rintracciato nelle sacche di EPO sequestrate durante la tristemente famosa ‘Operazione Puerto’ del dr. Fuentes. La difesa dell’atleta ha argomentato davanti al Tas che tutte quelle prove erano state acquisite in contrasto con il codice penale italiano. Il Tas ha ritenuto quelle prove valide ai fini dell’accertamento della violazione della normativa anti-doping e questa decisione è stata confermata dal Tribunale Federale Svizzero, che delibera sui fatti presentati dal Tas e non può rettificare d’ufficio le decisioni arbitrali, anche se i fatti sono stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto.
12 Non si è mai aperto un procedimento penale nei confronti di Adamu (né nei confronti dei giornalisti del ST), perché secondo il diritto svizzero la FIFA è un ente sportivo non-profit e, pertanto, i suoi ufficiali non possono essere considerati “pubblici ufficiali” in senso stretto.
13 http://www.bbc.co.uk/sport/0/football/17154126.
L’ordinanza del Consiglio di Stato sulla tessera del tifoso.
GIULIA GAVAGNIN*
Come già annunciato dalla maggior parte degli organi di stampa nazionali e locali, con la stringata ordinanza n. 5364 del 7 dicembre 2011 il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittima la ‘tessera del tifoso’ così come emessa da molte società calcistiche di serie A, B e Lega Pro.
Il Consiglio di Stato, in particolare, ha dichiarato contraria ai principi del Codice del Consumo la pratica di abbinare in maniera inscindibile al rilascio della tessera del tifoso anche una carta di credito prepagata (‘revolving‘) appoggiata ad un istituto bancario predeterminato. Questa pratica è ritenuta illegittima laddove la sottoscrizione del contratto con l’istituto bancario non sia direttamente funzionale agli scopi per i quali la tessera del tifoso é stata istituita.
Il ragionamento dei giudici di Palazzo Spada é senz’altro condivisibile.
La ‘tessera del tifoso’ é un documento identificativo di tipo nominativo che permette al titolare di seguire la propria squadra in trasferta, negli spazi riservati alla tifoseria ospite, istituito con l’entrata in vigore di due documenti ministeriali pressoché contestuali, adottati al fine di arginare il dilagante fenomeno della violenza negli stadi: la Direttiva del Ministero dell’Interno del 14 agosto 2009 e il Decreto del Ministero dell’Interno 15 agosto 2009, entrambi firmati dall’allora ministro, on. Maroni.
Il primo determina i requisiti della card che, in pratica, é stata concepita come l’unico titolo che legittima non solo l’accesso alle partite di calcio in trasferta, ma anche – a far data dal 1 gennaio 2010 – la sottoscrizione di nuovi abbonamenti per la propria squadra; il secondo, invece, impone alle società emittenti l’obbligo di inviare i dati del richiedente alla questura per la verifica dell’esistenza di motivi ostativi al rilascio.
Con determinazione n. 27/2009 l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha chiarito che: 1) sono temporaneamente escluse dal programma persone condannate per reati da stadio anche con sentenza non definitiva fino al completamento di 5 anni successivi alla condanna medesima; 2) la tessera del tifoso non può altresì essere rilasciata a coloro che sono attualmente sottoposti a DASPO1 per tutta la durata del provvedimento stesso.
La procedura di rilascio della tessera del tifoso aveva inizialmente fatto sorgere molti interrogativi circa la misura in cui i dati personali sarebbero dovuti essere trattati dalle questure preposte al controllo delle emissioni e, successivamente, dalle società sportive.
L’Autorità per la protezione dei dati personali, infatti, interrogata su eventuali difformità della procedura di rilascio della ‘card’ con le norme contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003) ha affermato2 che i dati personali devono essere utilizzati solo per le finalità scritte nel decreto: le questure, cioè, non possono utilizzare o diffondere i dati sensibili degli utenti per finalità diverse dalla verifica dei requisiti di incensuratezza sportiva richiesti dal decreto, né le società sportive sono legittimate al trattamento dati secondo modalità che possano comportare rischi di perdita delle informazioni e trattamenti non autorizzati o illeciti.
Tuttavia, a seguito della prima attuazione del decreto, proprio in materia di trattamento dei dati personali, la stessa Autorità ha rilevato talune incongruenze relative alla circoscrizione dei suddetti dati agli scopi indicati.
In particolare, veniva rilevata una parziale difformità rispetto alle indicazioni precedentemente fornite, giacché i dati personali venivano – di fatto – trattati per scopi ulteriori, soprattutto commerciali e di marketing e il modulo unico da compilare per l’ottenimento della tessera dava accesso a servizi non espressamente richiesti.
L’iter di rilascio della tessera del tifoso, pertanto, non é mai stato limpido.
Tuttavia, il punto manifestamente più oscuro della vicenda é proprio la dichiarata incongruenza con i principi contenuti nel Codice del Consumo.
L’art. 2 del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) riconosce, inter alia, al consumatore il diritto “ad un’adeguata informazione e corretta pubblicità”, “il diritto all’ esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza, equità“, “il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti commerciali“.
L’art. 18 lett. e) definisce rilevanti ai fini dell’applicazione delle norme del Codice le pratiche idonee a falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori, intese come “l’impiego di una pratica idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo a prendere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso“. Sempre l’art. 18, lett. i) definisce l’indebito condizionamento come “lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole“. Queste definizioni preludono alla trattazione delle pratiche commerciali scorrette cui l’ordinanza del Consiglio di Stato fa direttamente riferimento. Ai sensi dell’art. 20, una pratica è commercialmente scorretta se è “contraria alla diligenza professionale” e questa può essere:
a) ingannevole (artt. 21-23);
b) aggressiva (artt. 24-26).
Una pratica ingannevole può sostanziarsi in un’azione (art. 21) od un’omissione (art. 22).
La motivazione del Consiglio di Stato, seppur stringata ed in attesa di essere maggiormente esplicata nel giudizio di merito, sembra ravvisare molteplici profili di contrarietà tra l’abbinamento inscindibile tra la tessera del tifoso e la carta di credito, ed il Codice del Consumo. Senz’altro, infatti, la pratica commerciale in oggetto “induce o è idonea ad indurlo (il consumatore n.d.r.) ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso” (art. 21, comma 1): senza la prospettiva di accedere ai settori dello stadio dedicati alla squadra ospite, il consumatore non sottoscriverebbe, probabilmente, il contratto con l’istituto bancario.
Si può affermare, altresì, la violazione dell’art. 22: “è considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso“.
Il consumatore, infatti, è privato del diritto di sottoscrivere separatamente i due contratti, anche a causa di una omissione di informazioni rilevanti che lo possano indurre ad assumere una decisione “consapevole”.
Le ragioni giuridiche poste alla base dell’ordinanza del Consiglio di Stato appaiono ineccepibili: la pronuncia ragionevolmente tutela le ragioni del tifoso, che non dovrebbe essere obbligato a sottoscrivere un contratto con un istituto bancario per godere dei benefici della tessera del tifoso, di tutt’altra natura.
Tuttavia, è nota la poca affezione del pubblico per questa pratica, ritenuta di ‘indebita schedatura’. La tessera del tifoso sembra essere un rimedio provvisorio al problema della violenza negli stadi che necessiterebbe di ben altro polso da parte dell’esecutivo.
* Avvocato in Venezia
1 Acronimo che sta per Divieto di Accesso alle manifestazioni Sportive, introdotto per la prima volta con la L. n. 401/1989.
2 Parere pubblicato in G.U. 174 del 29 luglio 2009, poi recepito nel Decreto Ministeriale del 15 agosto 2009.
Contador e il caso della bistecca contaminata.
GIULIA GAVAGNIN*
E’ stata pubblicata lo scorso 7 febbraio la sentenza con la quale il Tas di Losanna ha comminato al ciclista Alberto Contador la squalifica per due anni dall’attività sportiva a seguito di accertata positività al clenbuterolo, una sostanza dopante1 inclusa nell’elenco Wada2. La sentenza è giunta 565 giorni dopo il prelievo del campione fisiologico: la lentezza del procedimento sta già facendo discutere esperti e non di tutto il mondo per la farraginosità di una procedura che dovrebbe essere quanto più rapida possibile, vista la brevità di una carriera sportiva professionistica ad alto livello (Contador compirà trent’anni nel dicembre di quest’anno).
Questi sono i fatti.
Il 21 luglio 2010, durante il Tour de France, Alberto Contador è stato sottoposto all’esame delle urine, risultando positivo per un’infinitesima percentuale (50 pg/ml) di clenbuterolo, una sostanza proibita inclusa nell’elenco Wada quale agente anabolico3.
Il successivo 26 agosto, a seguito di esito positivo delle analisi, al ciclista è stata notificata la provvisoria sospensione dall’attività sportiva con contestuale richiesta di chiarimenti.
L’esame del controcampione di liquido prelevato ha confermato i risultati delle prime analisi; anche ulteriori analisi ripetute su campioni precedentemente prelevati hanno rivelato la presenza di clenbuterolo in percentuali ancor più irrisorie (tra il 16 e i 7 pg/mL).
La positività, seppur infinitesima, ad una sostanza inclusa nell’elenco Wada ha avviato il procedimento avanti l’organo competente, il Comitè Nacional de Competicion y Disciplina Deportiva della Real Federacion Espanola de Ciclismo .
Il 14 febbraio 2011 il Comitato ha assolto Contador, ritenendo credibile la sua affermazione secondo cui, tra il 20 ed il 21 luglio 2010, aveva incolpevolmente ingerito una bistecca contaminata dalla predetta sostanza.
Il Comitato ha argomentato la propria decisione osservando che la carne di manzo legittimamente rientra nell’alimentazione di uno sportivo e che l’atleta non poteva sospettare – nemmeno adoperando la massima prudenza – che quella bistecca potesse contenere sostanze proibite. Ha inoltre rilevato che la quantità di clenbuterolo rinvenuta era talmente irrisoria da non potere in alcun modo migliorare la performance sportiva.
L’UCI e il Wada hanno proposto appello avanti il Tas. Il Wada, in particolare, ha compiuto meticolosissime indagini per dimostrare l’infondatezza delle affermazioni di Contador.
Il Tas ha preliminarmente ritenuto applicabili le norme contenute nel codice Wada, in quanto direttamente richiamate4 dalle norme in materia antidoping della UCI5.
Ricordiamo i principi fondamentali applicati dal Collegio:
a) è fatto obbligo ad ogni atleta di assicurarsi che nessuna sostanza proibita – rectius, contenuta nell’elenco delle sostanze proibite – faccia ingresso nel proprio corpo (‘enters his body‘): gli atleti sono ritenuti responsabili per ogni sostanza proibita, metabolita o marker, che vengano trovati nel loro corpo6;
b) ogni atleta deve astenersi dall’ingerire ogni sostanza, cibo, integratore o bevanda, di cui non conosce la composizione7;
c) eventuali terapie mediche non scusano l’ingestione di sostanze proibite o l’utilizzo di metodi proibiti, fatti salvi i casi espressamente indicati e previa comunicazione espressa agli organi competenti (‘Therapeuticals use exemption’)8.
Un atleta, qualora risulti positivo ad un test anti doping e non si sia sottoposto ad una terapia medica previamente concordata, commette una violazione formale alla normativa anti doping.
Se si tratta della prima infrazione9, come nel caso di Contador, l’atleta viene sanzionato con la squalifica per due anni dall’attività sportiva e con la revoca dei titoli vinti e dei premi in denaro ricevuti relativi alla competizione sportiva ‘falsata’ dalla pratica antisportiva.
Per evitare questa sanzione l’atleta deve dimostrare di aver assunto la sostanza o di avere adottato il metodo proibito senza colpa o negligenza (‘no fault or negligence‘)10.
Qualora, invece, il Tas ritenga che l’atleta abbia tenuto una condotta non significativamente colpevole o negligente (‘no significant fault or negligence‘)11 la sanzione può essere ridotta sino alla metà.
Nel procedimento davanti al Tas vige il principio della responsabilità oggettiva (‘strict liability’)12 : l’onere della prova è a carico dell’atleta, il quale, se vuole evitare la sanzione, deve chiarire:
1) come la sostanza è entrata nel suo corpo;
2) che nel caso di specie non ha agito con colpa o negligenza o con colpa o negligenza significative.
Nella decisione qui commentata, il Collegio non si limita a ribadire che, accertata la violazione formale, spetta all’atleta dimostrare con ogni mezzo possibile di avere tenuto una condotta non colpevole né negligente, ma stabilisce esattamente in cosa consista l’onere probatorio a carico dell’atleta.
In particolare, il collegio ritiene che il concetto di ‘onere della prova’ debba essere qualificato giuridicamente ai sensi dell’art. 8 del codice civile svizzero13 che pone in via generale l’onere della prova a carico della parte che invoca il diritto contestato. Ciò comporta che, nel procedimento in oggetto, sul ciclista gravasse l’onere – non certo agevole – di provare:
a) la possibilità dell’incolpevole ingestione di una bistecca contaminata;
b) l’impossibilità dell’assunzione della sostanza proibita in altro modo.
Contador ha ribadito la sua versione difensiva, secondo cui aveva mangiato una bistecca contaminata al clenbuterolo, sostanza che era all’epoca utilizzata come agente anabolizzante nei bovini.
In particolare, Contador ha affermato:
a) che ha consumato carne bovina sia il 20 che il 21 luglio 2010;
b) che ci sono sufficienti motivi per ritenere che la carne fosse contaminata con la sostanza vietata;
c) che l’ingestione di una bistecca contaminata determina la positività al test antidoping.
Ovviamente, essendo impossibile accertare l’effettiva presenza della sostanza incriminata nella carne consumata dal ciclista, le asserzioni del ciclista sono tutte di stampo probabilistico e, per lo più, ‘in negativo’.
I motivi ‘sufficienti’ cui al punto b), secondo la difesa dell’atleta, sono desumibili dai dati raccolti dal Wada a seguito dell’accurata indagine effettuata sulla filiera di produzione e di distribuzione della carne bovina all’oggetto del procedimento.
E’ stato infatti accertato che la bistecca mangiata da Contador provenisse da un macellaio di Irun, nei Paesi Baschi, che avrebbe acquistato la carne da un allevatore della regione spagnola della Castilla y Leon. Nel 2000, il fratello dell’allevatore di cui si tratta subì una condanna per aver commerciato carne ‘gonfiata’ con il clenbuterolo nel 1996. Per questa ragione, afferma Contador, è credibile che l’allevamento dal quale proveniva l’animale dal quale è stata ricavata la bistecca abbia utilizzato gli stessi metodi di adulterazione. In più, continua la difesa dell’atleta, non è certo al 100% che la carne avesse provenienza spagnola, potendo avere anche origine sudamericana.
Il Collegio ha disatteso queste argomentazioni proprio sulla base dell’indagine effettuata dal Wada.
Dopo aver accertato la provenienza spagnola della bistecca, il Wada ha posto in evidenza che il fratello dell’allevatore era sì stato condannato per adulterazione della carne, ma molti anni prima, nel 2000, e da allora, la normativa europea in materia alimentare era divenuta molto più severa.
In particolare in Spagna la somministrazione di beta-agonisti ai bovini è punita con sanzioni assai severe che arrivano fino ai 4 anni di reclusione. L’introduzione di sanzioni così pesanti ha azzerato i casi di carne adulterata in Spagna: i dati ufficiali diffusi dall’UE hanno mostrato che dal 2004 al 2008 in Spagna si è verificato un solo caso di contaminazione al clenbuterolo (nel 2006) e, comunque, nessun caso si è avuto né nei Paesi Baschi, né nella regione Castilla y Leon.
A questo punto, il Collegio è passato ad esaminare le ricostruzioni (“scenari”) ipotizzate dagli appellanti.
Il primo scenario è quello della trasfusione ematica.
Secondo il Wada e l’UCI, l’atleta si sarebbe sottoposto ad una trasfusione di globuli rossi per ossigenare il sangue e, il giorno seguente, per nascondere la variazione dei valori dell’emoglobina, si sarebbe iniettato del plasma. Purtroppo per il ciclista, però, il plasma sarebbe stato direttamente contaminato dal clenbuterolo.
Secondo il Wada, questo scenario è probabile per il concorso di tre fattori:
a) l’ambiente in cui si è allenato l’atleta, aduso a questa pratica (‘tainted environment‘);
b) i parametri del sangue;
c) tracce di ftalati (di per se, non sanzionabili ai sensi del Codice Wada perché non inclusi nella lista).
Il Collegio ha ritenuto non condivisibile la prima asserzione: non si può accusare un atleta di pratiche antisportive soltanto perché altri dello stesso ambiente le hanno adottate.
Per quanto concerne, invece, l’indagine sui parametri sanguigni, il Collegio ha riconosciuto che sia possibile manipolare il proprio profilo sanguigno sino a renderlo coerente con i valori naturali. Ma i medici del Wada sono riusciti soltanto a dimostrare che i valori sanguigni riscontrati nel ciclista nel Tour de France 2010 non erano in linea con i valori riscontrati nel 2007 e nel 2008 e il Collegio non ha ritenuto questi dati sufficienti al fine di dimostrare con sufficiente certezza che l’atleta si sia sottoposto ad una trasfusione.
Tuttavia, secondo il Collegio, queste congetture vanno poste in relazione con la riscontrata presenza di ftalati. Nel campione ematico prelevato il 20 luglio 2010 si è infatti riscontrata un’elevata presenza di queste sostanze, che sono agenti plastificanti utilizzati comunemente nella fabbricazione delle sacche in PVC, utilizzati nella pratica medica per conservare il sangue.
Secondo la tesi degli appellanti, Contador, nell’effettuare le due trasfusioni avrebbe utilizzato due diverse sacche di PVC contenenti, rispettivamente, il sangue ed il plasma. Quest’ultimo sarebbe stato contaminato da clenbuterolo perché proveniente da un donatore che ne aveva fatto uso massiccio (probabilmente, un body builder).
E’ interessante soffermarsi sul complesso ragionamento effettuato dagli esperti nominati circa la possibilità che il clenbuterolo rinvenuto nel campione delle urine di Contador sia da addebitarsi, effettivamente, ad una trasfusione di plasma contaminato.
La ricostruzione degli esperti ha natura tossicologica e farmacologica e parte dalla quantità di sostanza proibita rinvenuta nel campione prelevato: 50 pg/Ml.
Per raggiungere siffatte concentrazioni, per sé irrisorie, ma rilevanti se acquisite con una trasfusione di plasma, l’ipotetico donatore avrebbe dovuto assumere una ingente quantità di clenbuterolo al fine di aumentare la muscolatura (come si è detto, dovrebbe trattarsi di un body builder). In particolare, secondo la più accreditata tra le ricostruzioni, il donatore avrebbe dovuto sottoporsi ad una terapia di 200 ug al giorno per 21 giorni, con grave rischio per la sua salute.
Ma v’è di più. Il soggetto avrebbe dovuto donare il plasma entro il giorno successivo alla 21a donazione.
Quindi, Contador si sarebbe sottoposto ad un trasfusione sanguigna il 20 luglio 2010 utilizzando del sangue conservato in sacche di PVC. Gli ftalati sarebbero rimasti in circolo quel giorno e, dunque, sarebbero stati rinvenuti nel campione ematico prelevato quel giorno. Il giorno successivo si sarebbe iniettato del plasma proveniente da un donatore ‘dopato’ e talmente pervicace da aver assunto l’agente anabolizzante il giorno precedente.
Il Collegio, in questo caso, non ha potuto fare a meno di ritenere improbabile che il ciclista fosse stato cosi negligente (e stupido) da effettuare una trasfusione di plasma ricevuto da un donatore che aveva appena terminato un trattamento medico col clenbuterolo.
Il Collegio ha invece ritenuto probabile il secondo scenario, prospettato dal Wada con l’appello: l’assunzione di un integratore contaminato con clenbuterolo. Anche in un noto caso precedente14, una nuotatrice era stata condannata per aver ingerito un integratore contaminato con clenbuterolo, sebbene ella avesse affermato di aver sempre utilizzato integratori immessi sul mercato da un’azienda nota e, perciò, affidabile. Ugualmente, Contador si è difeso affermando di aver assunto sempre gli stessi integratori somministrati ai compagni del team Astana e, comunque, mai fuori dalla gara.
Il Collegio ha ritenuto teoricamente e tecnicamente possibile risultare positivi al clenbuterolo a seguito dell’ingestione di un integratore contaminato ed ha osservato, altresì, che l’atleta non ha fornito allegazioni sufficienti a discolparsi.
Il Collegio ha quindi ritenuto più verosimile che la positività al test dipenda da un integratore anziché da una bistecca contaminata.
Tuttavia, il Collegio, pur riformando la decisione di primo grado e comminando la condanna, ha sorprendentemente riconosciuto che la responsabilità dell’atleta non è da ritenere certa ‘oltre ogni ragionevole dubbio’.
Il ciclista presenterà ricorso presso il Tribunale Federale Svizzero contro la decisione del Tas: si tratta di un tentativo che difficilmente sortisce esito positivo essendo ammesso solo per ragioni formali15.
Tuttavia, la decisione presenta molti aspetti contraddittori proprio sul punto della ripartizione dell’onere della prova sicché non si può escludere una riforma da parte del Tribunale Federale.
Se è vero che l’onere della prova ricade interamente sul ciclista e che questi deve dimostrare di aver agito, quantomeno, senza colpa o negligenza significative, allora la tesi della bistecca contaminata, così come prospettata, è certo assai debole e soprattutto è stata confutata dalle indagini compiute dal Wada.
Qui il Collegio avrebbe potuto fermarsi e ritenere che il ciclista non aveva assolto all’onere della prova. Invece, e bisogna dire ragionevolmente, rendendosi conto che una rigida applicazione del criterio che addossa la prova “negativa” di non aver commesso coscientemente il fatto interamente sull’accusato porta a conseguenze giuridicamente poco accettabili, ha voluto esaminare se vi fossero ricostruzioni alternative, proposte dagli appellanti, più credibili. In altri termini, il Collegio sembra aver voluto introdurre un sistema “misto” in ordine alla prova, in contrasto con i principi richiamati inizialmente, ma più consono a principi di equità processuale.
Ma, una volta adottato questo sistema, appare incongruo giungere a una condanna sulla base di una valutazione di “minore improbabilità” della versione accusatoria.
Senza contare che lo ‘scenario’ dell’integratore contaminato non appare, comunque, convincente di per sè.
Adesso sarà interessante osservare con quali armi la difesa del ciclista affronterà il ricorso.
Certamente, questo caso farà discutere ancora molto.
* Avvocato in Venezia
1 Più precisamente, si tratta di un “beta-2-agonista” adrenergico che possiede proprietà ergogeniche che derivano dagli effetti stimolanti che è in grado di espletare sul sistema nervoso centrale. Viene utilizzato comunemente per il trattamento di patologie asmatiche, ma sono note le sue proprietà stimolanti: per questo il suo utilizzo presso gli sportivi costituisce un problema.
2 Il Wada (World Anti Doping Agency) è una fondazione a partecipazione mista creata per volontà del Comitato Internazionale Olimpico (IOC) il 10 novembre 1999 al fine di coordinare la lotta contro il doping nello sport. Attualmente la sua sede è a Montreal (Canada) ma giuridicamente resta regolata dal diritto privato svizzero.
Il Wada aggiorna periodicamente il Codice (WADC) contenente la normativa di riferimento in materia anti-doping. Il Codice, pubblicato per la prima volta nel 2003 (entrato in vigore il 1° gennaio 2004) e revisionato nel 2007 e nel 2009, è diviso in quattro parti: Doping Control; Education and Research; Roles and Responsabilities; Acceptance, Compliance, Modifications and Interpretation.
L’elenco delle sostanze e dei metodi proibiti (Prohibited List) è disciplinato dall’art. 4 del Codice, che ne impone l’aggiornamento a cadenza almeno annuale. Ogni modifica alla Prohibited List deve essere immediatamente comunicata dal Wada al direttore generale dell’UNESCO. L’ultimo aggiornamento è del 1° gennaio 2012.
3 Più precisamente, è inserito al Par. S1, punto n. 2 tra gli “other anabolic agents”, proibiti sia in gara che fuori dalla gara.
4 Nel procedimento d’appello avanti al Tas le norme applicabili sono soltanto quelle emanate dalle Federazioni Nazionali ed Internazionali, dalle organizzazioni nazionali anti-doping e dall’IOC. Il Codice Wada è applicabile solo laddove direttamente richiamato.
5 Union Ciclyste Internazionale.
6 Art. 2.1. Codice Wada e 21 UCI ADR.
7 Art. 21 UCI ADR.
8 Art. 4.4. Codice Wada.
9 Art. 10.2 Codice Wada.
10 Art. 10.5.1. Codice Wada.
11 Art. 10.5.2. Codice Wada.
12 Art. 2.1. Codice Wada.
13 “Unless the law provides otherwise, the burden of proving the existence o fan alleged fact shall rest on the person who derives rights from that fact”.
14 La nuotatrice americana Jessica Hardy il 23 luglio 2008 fu trovata positiva al clenbuterolo. Si difese affermando di aver incolpevolmente ingerito un integratore adulterato messo in commercio dalla nota azienda AdvoCare. Il Tas il 21 maggio 2010 ha confermato la decisione resa dall’American Arbitration Association and the Court of Arbitration for Sport che aveva comminato un anno di sospensione alla Hardy per aver ingerito l’integratore ‘with no significant fault or negligence’. L’IOC, lo scorso anno, l’ha riammessa ai giochi olimpici di Londra 2012.
15 In particolare, ai sensi dell’art. 190 PILA (Swiss Private International Law Act) il ricorso al Tribunale Federale è ammesso per questioni inerenti la nomina degli arbitri, la giurisdizione del Tas, l’omessa considerazione di prove fondamentali, la violazione delle norme in materia di giusto processo e di ordine pubblico.
Pubblicato su Osservatorio AD – Greenlex il 27 febbraio 2012
Sicurezza pubblica per le donne e garanzie processuali per gli stupratori.
MARIA (MILLI) VIRGILIO*
Fanno sempre polemizzare le misure cautelari coercitive che limitano la libertà personale prima della sentenza definitiva. Pensiamo da ultimo agli arresti domiciliari per il comandante Schettino o al carcere per i No Tav: condanna anticipata o presunzione di non colpevolezza?
Immediate e laceranti sono le prese di posizione sulla sentenza di Cassazione n. 4377 del 2012. Certamente non può piacere che la Cassazione parifichi lo stupro di gruppo allo stupro base. E neppure che la Cassazione – quindi – apra le porte del carcere per infliggere la meno gravosa misura degli arresti domiciliari. Ma, per capire, dobbiamo distinguere desideri e diritti e domandarci come è potuto accadere.
Il punto è che quel più duro trattamento per gli autori di violenze sessuali era uno dei frutti avvelenati del pacchetto sicurezza Maroni-Carfagna che nel 2009 era intervenuto con la mano pesante sull’onda della percezione del c.d. allarme sociale dello stupro di strada. Per raggiungere l’obiettivo e giustificare l’urgenza del decreto-legge il Governo non aveva messo mano a una riforma specifica e dedicata, ma aveva operato all’interno delle norme speciali previste per i delitti di mafia. Aveva così dovuto operare una doppia parificazione, la prima tra la violenza sessuale base e la violenza di gruppo (e altri reati a sfondo sessuale) e la seconda tra questi e i delitti di mafia (associazione di tipo mafioso e delitti posti in essere con metodi o per finalità mafiose). Da allora il giudice in tutti tali casi ha dovuto applicare obbligatoriamente sempre e solo la custodia cautelare in carcere, senza più poter scegliere nel ventaglio delle varie misure previste dal codice di procedura penale e senza più graduare secondo il criterio della adeguatezza al caso concreto. La svolta fu operata in nome del bene collettivo “sicurezza pubblica”, come indica il valore dichiarato nel titolo stesso di quella legge e delle altre intervenute in materia (sono ben lontani i tempi in cui faticosamente avevamo spostato la collocazione della violenza sessuale nell’ambito del bene giuridico individuale della “persona”, sganciandolo finalmente dall’altro bene collettivo in auge allora (e fino al 1996), quello della moralità pubblica e del buon costume. Orbene, proprio in nome della sicurezza pubblica, stupro semplice, stupro di gruppo, prostituzione minorile, pornografia minorile, turismo sessuale assunsero un trattamento severo, quello riservato alla mafia.
Così nei provvedimenti Maroni-Carfagna erano stati inseriti il divieto di sostituire il carcere con gli arresti domiciliari e l’arresto in flagranza per gli autori di stupro (ma non per l’ex che assassina la donna che ha osato interrompere la relazione sentimentale). Era passata anche la difesa legale a spese dello Stato e senza alcun limite di reddito, ma solo per le donne che hanno subito violenza di tipo sessuale. Nel decreto d’urgenza furono infilati anche lo stalking, le ronde e l’ergastolo per l’omicidio in occasione (?!) di violenza sessuale. Tutte le novità legislative furono intitolate alla sicurezza “pubblica”, giustificando la “straordinaria necessità e urgenza” –, indispensabili per scavalcare il Parlamento – con “l’allarmante crescita di episodi collegati alla violenza sessuale” (assunto indimostrato per mancanza di un Osservatorio nazionale).
Non può allora meravigliare che la norma fosse presto portata alla Corte Costituzionale che nel 2010 (n. 265) la dichiarò illegittima proprio nella parte in cui aveva disposto l’obbligatorietà della misura di custodia in carcere per i casi di prostituzione minorile, violenza sessuale e atti sessuali con minorenni (la sentenza si riferiva a giudizi per questi tipi di delitti). Pur ritenendo corretto assoggettarli ad un regime cautelare speciale, riteneva tuttavia ingiusto e irragionevole averli trattati alla pari dei delitti di stampo mafioso, tanto più che altri delitti pur sanzionati con pene ben più elevate restavano assoggettati alla regola generale della custodia in carcere “soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata”. Si trattava di una presunzione assoluta di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere che violava il quadro costituzionale di garanzie riservate alla libertà personale. Come non concordare!? Infatti la sentenza non provocò dissensi.
Il salto da quei delitti già considerati alla violenza sessuale di gruppo lo ha fatto la Cassazione, con una interpretazione adeguatrice ai principi già affermati dalla Corte, essendone logico e ragionevole sviluppo.
La sentenza (o meglio i resoconti e commenti dei media) hanno fatto polemizzare. Con quale risultato a favore della libertà femminile? Ancora una volta l’attenzione è focalizzata sui delitti di violenza sessuale e tanta visibilità (dopo tanto secolare silenzio) va allo stupro di strada, che è violenza (sessuale e agita fuori delle relazioni di fiducia) statisticamente minoritaria rispetto al ben più vasto ambito della violenza maschile e domestica sulle donne: la violenza maschile (“di genere”) non è solo sessuale, bensì fisica, psicologica, economica e che è “domestica”, nel senso di allignare prevalentemente nelle relazioni di prossimità e intimità, nonché di trovare origine nei rapporti di potere uomo/donna che nella famiglia trovano il luogo privilegiato di costruzione.
* Avvocato in Bologna
Pubblicato su Osservatorio AmbienteDiritto – Greenlex il 9 febbraio 2012
La Convenzione di Berna: ripercussioni sulla tutela penale dei fringillidi nella normativa italiana che disciplina l’attività venatoria.
DAVIDE BRUMANA* e LUCA PELLICIOLI**
Con la pronuncia dello scorso dicembre, la Corte di Cassazione ha comminato la sanzione penale prevista dalla normativa nazionale a tutela delle specie particolarmente protette, per la detenzione di un esemplare di peppola – specie appartenente alla famiglia dei fringillidi (Fringilla montifringilla) – poiché riconducibile tra le specie ricomprese nell’allegato 2 della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa del 19 settembre 1979, detta anche Convenzione di Berna (Cass. pen., Sez. 3, n. 47872, 22.12.2011).
Deve aggiungersi che già in precedenza la S.C., trattando un’ipotesi di attività di caccia in deroga alla disciplina nazionale e comunitaria ai sensi dell’art. 9 della dir. 2009/147/CE, ha ritenuto configurabile la violazione della L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. b) per l’abbattimento di un fringillide (frosone – Coccothraustes coccotrhaustes) in quanto rientrante tra le specie incluse nel menzionato allegato 2 della Convenzione di Berna (Cass. Pen., Sez. 3, n. 23931, 22.06.2010).
Si tratta però di decisioni non scontate e quindi particolarmente rilevanti. Ma procediamo con ordine.
La fauna selvatica, ai fini dell’esercizio venatorio di cui alla medesima L. n. 157/1992, è ricompresa in tre categorie, cui corrisponde un livello di protezione differente: massima protezione con divieto assoluto di caccia, cui corrispondono sanzioni decisamente gravi per le specie particolarmente protette di cui all’art. 2, lett. a), b) e c) e di cui all’art. 30, c. 1, lett. c); protezione ordinaria e divieto di caccia per tutte la altre specie di fauna selvatica che non figurano negli elenchi di cui all’art. 18; protezione ordinaria, e per di più limitata ad alcuni periodi dell’anno, per le specie elencate all’art. 18, che in alcuni periodi di tempo divengono cacciabili, in deroga al divieto generale di caccia che riguarda anche queste specie, ma che trova in riferimento alle stesse dei precisi limiti temporali.
Sempre la stessa L. n. 157 del 1992, all’art. 30, c. 1, lett. b) sanziona, con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, l’abbattimento, la cattura e la detenzione di mammiferi ed uccelli appartenenti alle specie particolarmente protette dettagliatamente elencate nell’art. 2.
Tale ultima disposizione, che individua l’oggetto della tutela assicurato dalla legge alla fauna selvatica, della quale fanno parte le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale, elenca alcune specie ritenute meritevoli, anche sotto il profilo sanzionatorio, di particolare protezione: art. 2, c. 1, lett. a) e b).
Oltre all’elencazione specifica delle singole specie, la disposizione in esame indica, tra le specie particolarmente protette, alla lett. c), tutte quelle altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicano come minacciate di estinzione. E tra le convenzioni internazionali in materia rientra la Convenzione di Berna, ratificata dall’Italia con la L. 5.08.1981, n. 503.
Ciò posto, in un quadro che pare chiaro, compare un’anomalia: infatti la L. n. 157/1992 prescrive la sanzione penale dell’ammenda per chi abbatte, cattura o detiene più di cinque fringillidi (art. 30, c. 1, lett. h), mentre, qualora il numero di fringillidi abbattuti, catturati o detenuti sia inferiore alla predetta quantità, all’art. 31, c. 1, lett. h), è prevista la sola sanzione amministrativa.
Ci si trova dinanzi ad un’evidente discrasia legislativa, come detto: infatti, nei casi che ci occupano, la detenzione o l’abbattimento di un solo esemplare appartenente alla famiglia dei fringillidi (peppola e frosone), secondo il tenore letterale della normativa, comporterebbe a carico del trasgressore una pena che può variare da una sanzione penale, quale l’ammenda o l’arresto, ad una sanzione amministrativa.
Quasi certamente tale incongruenza del sistema sanzionatorio in materia venatoria deriva anche dal fatto che al momento dell’entrata in vigore della medesima legge quadro sull’attività venatoria, la peppola, così come il fringuello (Fringilla coelebs), erano gli unici due fringillidi cacciabili, che poi sono stati espunti dall’elenco delle specie cacciabili a seguito dell’emanazione del D.P.C.M. del 22.11.1993.
Senza entrare nel merito della misura afflittiva disposta in concreto dal Collegio giudicante, risulta comunque interessante la definizione del rapporto in cui si pongono le richiamate pronunce rispetto agli istituti tipici del diritto penale, quali il favor rei, nonché il principio di tassatività della sanzione penale, rispetto ai quali crea perplessità l’applicazione di una sanzione penale in luogo di quella amministrativa, sopravvissuta (quanto meno per le specie divenute non cacciabili) a livello letterale.
A prescindere dalle evidenziate criticità, che solo un intervento normativo può superare, va constatato come, con le pronunce in esame, la S.C. abbia manifestato di accordare ai fringillidi la massima tutela penale prevista dall’ordinamento statale, in un’ottica di conservazione sovranazionale dell’avifauna che risponde del resto ai contenuti della disciplina comunitaria e internazionale.
Pare dunque affermarsi un nuovo orientamento giurisprudenziale sul tema, secondo il quale l’abbattimento, la cattura e la detenzione di fringillidi, quali specie elencate nell’allegato 2 della Convenzione di Berna, configura il reato di cui alla L. n. 157/1992, art. 30, lett. b), posto a tutela delle specie di fauna selvatica particolarmente protette.
* Dottore in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bergamo, master II livello in diritto dell’ambiente
** Medico veterinario, Phd in gestione e patologie della fauna selvatica presso l’Università degli Studi di Milano, Facoltà di medicina veterinaria





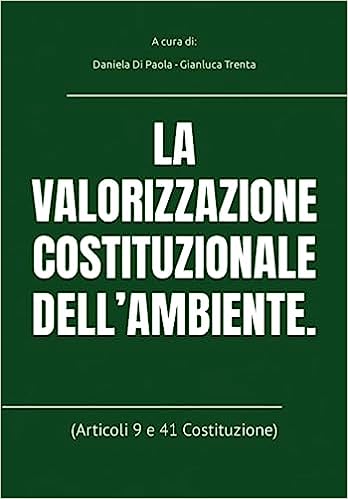
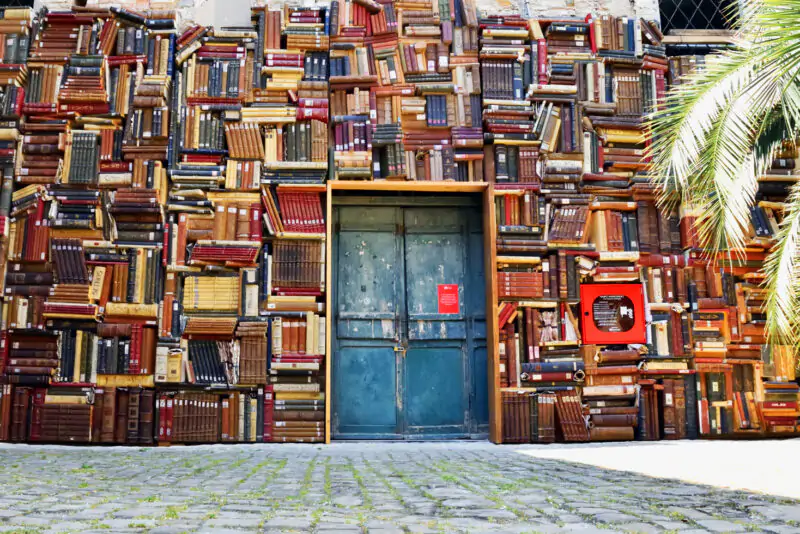 AMBIENTEDIRITTO.IT Casa Editrice
AMBIENTEDIRITTO.IT Casa Editrice