OSSERVATORIO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO
Work Safety Observatory
A cura di
Ambra Mostarda – Alessia Riommi – Chiara Trotta
N.B: PER LE SENTENZE PER ESTESO E ALTRE SENTENZE CONSULTARE LA BANCA DATI DI GIURISPRUDENZA
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DI: LAVORO, SICUREZZA, 231…
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Lavoro, 24 giugno 2025 (ud. 6/5/2025), Sent. n. 16935 (Pres. Tria, Est. Buconi)
SICUREZZA SUL LAVORO – Certificazione verde Covid-19 – Misure di sicurezza – Costi a carico del datore di lavoro – Spese nell’interesse del datore di lavoro – Modalità alternativa alla vaccinazione – Costi a carico del lavoratore.
Durante la pandemia di Covid-19, la valutazione sulla sicurezza del luogo di lavoro è stata effettuata dal legislatore ed è stata garantita attraverso la campagna vaccinale. A fronte di tale valutazione di sicurezza la certificazione verde Covid-19 non può essere minimamente assimilata alle misure che il datore di lavoro è tenuto ad adottare, sopportandone i relativi costi, per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, nel rispetto delle prescrizioni poste dal d.lgs. n. 81/2008. Si esclude dunque che possa essere invocato il principio secondo cui devono gravare sul datore di lavoro le spese che il prestatore sopporta nell’esclusivo interesse del primo, atteso che la previsione di una modalità alternativa alla vaccinazione è stata ispirata dall’intento di rispettare, ove possibile, la scelta del dipendente di rifiutare la somministrazione del vaccino.
(Nel caso di specie, si è escluso che l’Amministrazione fosse tenuta all’esecuzione di tamponi su tutto il personale (vaccinato e non vaccinato) e che fosse tenuta a sostenere i costi dei tamponi delle lavoratrici, non vaccinate).
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. 4°, 14 giugno 2025 (ud. 29/4/2025), Sentenza n. 22438 (Pres. Serrao, Est. Ricci)
231 – Messa alla prova – Responsabilità amministrativa degli enti – D.lgs. n. 231/2001 – Divieto di analogia – Principio di tassatività – Impossibilità di estensione all’ente – Imputato persona fisica.
L’istituto della messa alla prova di cui all’art. 168-bis c.p. non si applica alla responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 in forza dell’analogia in bonam partem o della interpretazione estensiva, in quanto il divieto di analogia per le norme penali, in applicazione del principio di tassatività, si traduce per il giudice nell’impossibilità di applicare sanzioni oltre i casi espressamente e specificamente contemplati dalla legge; la disciplina della messa alla prova ex art. 168-bis c.p. è modulata specificamente sull’imputato persona fisica e sui reati allo stesso astrattamente riferibili, con conseguente impossibilità di estensione all’ente cui è contestata la responsabilità amministrativa.
(Nel caso di specie, dopo aver ammesso alla prova, ex art. 168-bis c.p., l’ente cui era stato contestato l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies, comma 3, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in relazione alla commissione del delitto di cui all’art. 590, commi 1 e 3, c.p., il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti della società per essere stato l’illecito estinto per esito positivo della messa alla prova).
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. 4°, 16 maggio 2025 (ud. 30/1/2025), Sentenza n. 18438 (Pres. Dovere, Est. Lauro)
SICUREZZA SUL LAVORO – Rischio interferenziale – Compresenza di imprese – Rischio aggiuntivo – Interferenza funzionale – Datore di lavoro committente – Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze – Unicità.
Ai fini di cui all’art. 26 d.lgs. 81/2008, il rischio interferenziale è dato dal contatto rischioso tra il personale di imprese diverse operanti nello stesso contesto aziendale e pertanto occorre aver riguardo alla concreta interferenza tra le diverse organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori rischi per l’incolumità dei lavoratori. Si è, infatti, opportunamente precisato che, non solo il contatto rischioso tra lavoratori di imprese diverse che operano nel medesimo luogo di lavoro, ma anche la coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni genera la posizione di garanzia dei datori di lavoro. Pertanto, l’interferenza rilevante va intesa in senso funzionale, come interferenza non di soli lavoratori, ma derivante dalla coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi. In una prospettiva funzionale, l’interferenza rilevante deve essere intesa non solo e non tanto in termini di compresenza dei lavoratori, quanto piuttosto come coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni, le cui attività convergevano nella esecuzione di un compito unitario.
(Nel caso di specie, in presenza di rischio interferenziale, il datore di lavoro committente aveva, quindi, l’obbligo di redigere il DUVRI, ovvero un documento unico, e non invece tre distinti documenti, con ciascuna delle società appaltatrici, e relativi ai diversi compiti assegnati nella attività di pulizia della caldaia).
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. 4°, 15 maggio 2025 (ud. 26/3/2025), Sentenza n. 18410 (Pres. Montagni, Est. Lauro)
231 – Interesse o vantaggio per l’ente – D.lgs. n. 231/2001 – Condotta – Criterio di imputazione oggettiva – Risparmio di spesa esiguo ma apprezzabile – Inosservanza non sistematica delle cautele – Prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Posto che nei delitti colposi l’interesse o vantaggio per l’ente, di cui all’art. 5 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, non deve riferirsi all’evento del reato, ma deve riguardare unicamente la condotta, il criterio di imputazione oggettiva è integrato anche da un esiguo, ma oggettivamente apprezzabile, risparmio di spesa, collegato all’inosservanza, pur non sistematica, delle cautele per la prevenzione degli infortuni riguardanti un’area rilevante di rischio aziendale. Che il vantaggio per l’ente, pur apprezzabile, possa anche essere minimo, lo si ricava inoltre dal fatto che in tal caso non è esclusa la responsabilità, ma la sanzione applicabile deve essere diminuita ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a), d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Pertanto, l’impossibilità di giungere ad una esatta quantificazione di un non irrisorio vantaggio, certo nella sua esistenza, non esclude la responsabilità dell’ente.
(Nel caso di specie, la ripetuta violazione degli oneri manutentivi di un impianto, in presenza di conclamati indici di deterioramento, ha prodotto un risparmio di spesa che, sebbene non quantificabile, è giuridicamente apprezzabile).
231 – Responsabilità amministrativa degli enti – D.lgs. n. 231/2001 – Violazione della normativa antinfortunistica – Colpa di organizzazione – Inottemperanza dell’obbligo di adottare le cautele – Dovere di prevenzione.
Nel caso di responsabilità degli enti ritenuta in relazione a reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, la colpa di organizzazione deve intendersi in senso normativo ed è fondata sul rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individui i rischi e delinei le misure atte a contrastarli. L’ente risponde, quindi, per fatto proprio, per essere venuto meno al dovere di organizzazione funzionale alla prevenzione del rischio-reato: in questa prospettiva, la colpa di organizzazione dell’ente finisce per assumere la stessa funzione che la colpa assume nel reato commesso dalla persona fisica, ovvero di elemento costitutivo del fatto tipico, integrato dalla violazione “colpevole” (ovvero rimproverabile) della regola cautelare.
SICUREZZA SUL LAVORO – Presunzione di conformità – Modello di organizzazione aziendale – Certificazione – Standard internazionale – Adozione – Efficace attuazione.
Non è sufficiente la presunzione di conformità del modello di organizzazione aziendale, poiché certificato secondo lo standard internazionale – secondo quanto dispone l’art. 30, comma 5, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – in quando il modello non deve solo essere adottato, ma anche efficacemente attuato. Tale carenza non può essere colmata dalla nomina dell’organismo di vigilanza.
(Nel caso di specie, la mancanza di un programma specifico degli interventi di manutenzione delle passerelle, in uno con la mancata previsione di effettive procedure di controllo, è stata, quindi, ritenuta indice di una carenza organizzativa che si è riverberata, sul piano causale, sulle garanzie per la sicurezza dei lavoratori. È stata così rilevata la violazione dell’obbligo organizzativo, connesso alla gestione del rischio-reato, ovvero la mancata predisposizione di accorgimenti idonei a evitare la commissione di reati).
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 4^, 14 maggio 2025 (ud. 23/4/2025), Sentenza n. 18169 (Pres. Montagni, Est. Sessa)
SICUREZZA SUL LAVORO – Tutela della salute del lavoratore – Art. 2087 c.c. – Contratto di appalto – Amministratore di condominio – Committente – Obblighi di verifica – Idoneità tecnico professionale – Obbligo di informazione – Rischi specifici – Ambiente di lavoro – Misure di prevenzione e protezione.
In tema di tutela della salute del lavoratore, l’amministratore che stipuli un contratto di affidamento in appalto di lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio può assumere, ove una delibera assembleare o anche un incarico informalmente conferitogli, gli riconosca autonomia di azione e concreti poteri decisionali, la posizione di “committente”, come tale tenuto all’osservanza degli obblighi di verifica della idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice, di informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e di cooperazione e coordinamento nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione, dovendosi, peraltro, escludere che la non idoneità possa essere ritenuta per il solo fatto dell’avvenuto infortunio, in quanto il difetto di diligenza nella scelta dell’impresa esecutrice deve formare oggetto di specifica motivazione da parte del giudice.
SICUREZZA SUL LAVORO – Definizione di lavoratore – Organizzazione del datore di lavoro – Tipologia contrattuale – D.lgs. n. 81/2008 – Mansioni tipiche dell’impresa – Richiesta dell’imprenditore.
La definizione di “lavoratore” di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, richiede lo svolgimento dell’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione del datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale ed è più ampia di quella prevista dall’art. 3 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, che si riferiva, invece, al “lavoratore subordinato” e alla “persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro” (art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626), sicché, ai fini dell’applicazione delle norme incriminatrici previste nel citato d.lgs. n. 81 del 2008, rileva l’oggettivo espletamento di mansioni tipiche dell’impresa, anche eventualmente a titolo di favore, nei luogo deputato e su richiesta dell’imprenditore.
SICUREZZA SUL LAVORO – Infortuni sul lavoro – Contratto di appalto – Contratto di prestazione di opera – Obblighi del committente – Verifica di idoneità tecnico-professionale – Avvenuto infortunio.
In materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, dovendosi, peraltro, escludere che la non idoneità possa essere ritenuta per il solo fatto dell’avvenuto infortunio, in quanto il difetto di diligenza nella scelta dell’impresa esecutrice deve formare oggetto di specifica motivazione da parte del giudice.
SICUREZZA SUL LAVORO – Prevenzione degli infortuni sul lavoro – Responsabilità del committente – Incidenza della condotta – Eziologia dell’evento – Capacità organizzative – Situazioni di pericolo.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, occorre verificare in concreto l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Lavoro, 12 maggio 2025 (ud. 9/5/2025), Ordinanza n. 12518 (Pres. Tricomi, Est. Tria)
SICUREZZA SUL LAVORO – Mobbing – Pluralità di comportamenti pregiudizievoli – Intento persecutorio – Straining – Comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti del dipendente – Ambiente stressogeno – Danno alla salute.
È configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l’elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell’intendimento persecutorio nei confronti della vittima e ciò a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime. È, invece, configurabile lo straining quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie o esse siano limitate nel numero, ma anche nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori.
(La decisione datoriale di mettere a concorso un passaggio di livello piuttosto che assegnarlo ad un proprio dipendente avente i titoli per ricoprire la superiore qualifica non integra una ipotesi di straining, non potendo ravvisarsi alcun comportamento stressogeno scientemente attuato nei confronti del dipendente che, per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale e altre circostanze del caso concreto, possa far ravvisare nella specie un’ipotesi di straining.)
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Lavoro, 9 maggio 2025 (ud. 12/3/2025), Sentenza n. 12270 (Pres. Manna, Est. Amendola)
DIRITTO DEL LAVORO – Disabilità – Accomodamenti ragionevoli – Misure organizzative ragionevoli – Attività lavorativa – Licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore disabile – Datore di lavoro – Onere probatorio – Sforzo diligente ed esigibile – Soluzione organizzativa appropriata.
Circa l’adempimento o meno dell’obbligo legislativamente imposto dall’art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216 del 2003, ossia l’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli, il comportamento dovuto si caratterizza non tanto, in negativo, per il divieto di comportamenti che violano la parità di trattamento, quanto piuttosto, in positivo, per il suo profilo di azione volta alla ricerca di misure organizzative ragionevoli idonee a consentire lo svolgimento di un’attività lavorativa, altrimenti preclusa, a persona con disabilità. Dunque, nel giudizio avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento intimato per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore disabile, l’onere gravante sul datore di lavoro potrà essere assolto mediante la deduzione del compimento di atti o operazioni strumentali rispetto all’avveramento dell’accomodamento ragionevole, che assumano il rango di fatti secondari di tipo indiziario o presuntivo, i quali possano indurre nel giudicante il convincimento che il datore abbia compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata che scongiurasse il licenziamento, avuto riguardo a ogni circostanza rilevante nel caso concreto.
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. 4°, 8 maggio 2025 (ud. 30/4/2025), Sentenza n. 17467 (Pres. Ciampi, Est. Serrao)
231 – Responsabilità dell’ente – Illecito del soggetto apicale – Contrasto tra giudicati – Sentenza dichiarativa della responsabilità – Sentenza di assoluzione – Reato presupposto – diverso procedimento – Negazione del fatto storico.
Nel peculiare caso del rapporto tra responsabilità dell’ente e illecito commesso dal soggetto apicale si è affermato che non sussiste contrasto tra giudicati ex art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p. tra la sentenza dichiarativa della responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e la sentenza di assoluzione dell’imputato dal reato presupposto pronunciata in un diverso procedimento nel caso in cui, in quest’ultimo, sia stata accertata la ricorrenza del fatto illecito, discendendo l’inconciliabilità dei giudicati solo dalla negazione del fatto storico su cui essi si fondano e non anche dalla mancata individuazione del suo autore, posto che la responsabilità dell’ente ex art. 8 del citato d.lgs. sussiste pur se l’autore del reato non risulti identificato.
231 – Corrispondenza tra reati – Reato presupposto – Responsabilità del soggetto apicale della società produttrice – Responsabilità del datore di lavoro – Identità del fatto storico – Sovrapponibilità – Diversità di enti – D.lgs. n. 231/2001.
In tema di responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, il reato contestato alla persona fisica deve corrispondere a quello chiamato a fungere da presupposto per la responsabilità della persona giuridica, per cui l’esclusione della responsabilità del soggetto apicale della società produttrice di un macchinario, per essere l’infortunio ascrivibile esclusivamente al datore di lavoro, va intesa quale esclusione del reato presupposto. Ciò che conta, per la verifica dell’identità del fatto storico, è dunque il confronto delle condotte specificamente poste in essere dai medesimi soggetti per verificarne la sovrapponibilità, onde, l’identità del fatto storico nel quale si sostanzia il reato presupposto permane, pur a seguito dell’assoluzione di uno dei coimputati, qualora rimanga ferma la responsabilità degli altri o di persona non identificata le cui condotte siano comunque riferibili al medesimo Ente; mutando l’Ente di riferimento del soggetto apicale imputato muta, invece, anche il fatto storico.
(Nel caso di esame, il fatto storico sul quale si fonda la responsabilità dell’Ente produttore è un infortunio occorso a un dipendente di una società in occasione dell’uso di un macchinario nel quale era stata ipotizzata anche la responsabilità del produttore, mentre la sentenza emessa all’esito del giudizio di cognizione nei confronti degli imputati persone fisiche ha escluso la riconducibilità dell’infortunio al soggetto apicale dell’Ente produttore, affermando l’esclusiva responsabilità dei garanti della società datrice di lavoro).
Diversità del fatto storico – Infortunio sul lavoro – Infortunio correlato all’uso di macchinari – Infortunio ascritto all’impresa datrice – Infortunio ascritto al produttore.
Sussiste diversità del fatto storico tra un infortunio in materia di lavoro correlato all’uso di un macchinario ascritto all’impresa datrice di lavoro e il medesimo infortunio ascritto alla condotta del produttore del macchinario.
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Lavoro, 3 maggio 2025 (ud. 4/4/2025), Ordinanza n. 11631 (Pres. Marotta, Est. Casciaro)
SICUREZZA SUL LAVORO – Obbligo di prevenzione del datore di lavoro – Inadempimento – Colpa – Difetto di diligenza – Misure di sicurezza sul lavoro – Specificità del rischio.
Elemento costitutivo della responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell’obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 cod. civ. è la colpa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore; l’obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 cod. civ. impone all’imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene protetto dall’art. 41, secondo comma, Cost.
DIRITTO DEL LAVORO – Responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. – RISARCIMENTO DANNI – Onere di allegazione e prova – Responsabilità contrattuale – Risarcimento del danno – Infortunio sul lavoro.
La responsabilità conseguente alla violazione dell’art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale, sicché il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio, o l’Istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve allegare e provare la esistenza dell’obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile.
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Lavoro, 23 aprile 2025 (ud. 6/3/2025), Ordinanza n. 10730 (Pres. Bellè, Est. Cavallari)
DIRITTO DEL LAVORO – Mobbing – Insussistenza dell’intento persecutorio – Responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. – Ambiente stressogeno – Comportamenti non illegittimi che inducono disagi o stress – Pregiudizio per la personalità e la salute.
In tema di responsabilità del datore di lavoro per danni alla salute del dipendente, anche ove non sia configurabile una condotta di “mobbing”, per l’insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli, è ravvisabile la violazione dell’art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi.
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. 4°, 22 aprile 2025 (ud. 5/2/2025), Sentenza n. 15694 (Pres. Ciampi, Est. Bellini)
SICUREZZA SUL LAVORO – Responsabilità per infortunio sul lavoro – Interruzione del rapporto di causalità – Condotta imprudente del lavoratore – Criticità del sistema di sicurezza – Colpa del lavoratore – Comportamento abnorme – Comportamento estraneo al processo produttivo – Comportamento estraneo alle mansioni attribuite.
In tema di responsabilità per infortunio sul lavoro si applica il principio secondo cui l’interruzione del rapporto di causalità, sebbene in costanza della imprudente condotta del lavoratore non si realizza quando il sistema di sicurezza apprestato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità. Invero, le disposizioni di sicurezza perseguono infatti il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l’area di rischio da gestire comprende il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro impedire l’instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, come tali, latrici di possibili rischi per la sicurezza e la incolumità dei lavoratori. In tal senso, la colpa del lavoratore eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l’esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l’evento-morte o lesioni del lavoratore, che ne sia conseguito, può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all’evento quando, per la sua stranezza ed imprevedibilità, non sia neppure collegato al segmento di lavorazione impegnato; in tema di causalità, la colpa del lavoratore, concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica ascritta al datore di lavoro ovvero al destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione, esime questi ultimi dalle loro responsabilità solo allorquando il comportamento anomalo del primo sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore.
(Nel caso di specie, tale ipotesi non appare ipotizzabile essendo emerso che il lavoratore si era limitato a dare esecuzione ad uno specifico ordine di lavoro promanante dal preposto alle lavorazioni).
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. 4°, 22 aprile 2025 (ud. 18/3/2025), Sentenza n. 15697 (Pres. Ciampi, Est. Ricci)
SICUREZZA SUL LAVORO – Esercizio di fatto dei poteri direttivi – Posizione di garanzia – Datore di lavoro – Formale investitura – Esercizio in concreto dei poteri – Svolgimento di fatto delle mansioni – Corresponsabilità – Ruolo apparente.
In materia di sicurezza sul lavoro, l’art. 299 d.lgs. n. 81/2008, nel definire l’esercizio di fatto dei poteri direttivi, stabilisce che la posizione di garanzia relativa al datore di lavoro grava altresì su colui che, pur sprovvisto di formale investitura, eserciti in concreto i poteri riferiti al soggetto definito dall’art. 2. La norma nell’estendere gli obblighi di garanzia a coloro ai quali di fatto svolgono le mansioni tipiche delle figure di cui si è detto, non esclude la corresponsabilità di coloro i quali sono titolari formali della qualifica. Permane, dunque, in capo al titolare del rapporto di lavoro la posizione di garanzia, a meno che questi non abbia investito tramite delega altri soggetti delle funzioni prevenzionistiche. Pertanto, la responsabilità dell’amministratore di società, in ragione della posizione assegnatagli dall’ordinamento, non viene meno per il fatto che il ruolo rivestito sia apparente.
SICUREZZA SUL LAVORO – Responsabilità per infortunio – Obblighi del datore di lavoro – Valutazione dei rischi – Formazione dei lavoratori – Rischi connessi alle mansioni – Omessa formazione – Verificazione dell’evento – Nesso causale.
Il datore di lavoro risponde dell’infortunio occorso al lavoratore, in caso di violazione degli obblighi, di portata generale, relativi alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali siano chiamati ad operare i dipendenti, e della formazione dei lavoratori in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui devono essere svolte. È, infatti, tramite l’adempimento di tale obbligo che il datore di lavoro rende edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti. Ove egli non adempia a tale fondamentale obbligo, sarà chiamato a rispondere dell’infortunio occorso al lavoratore, laddove l’omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell’evento, ovvero laddove sia accertato che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo.
CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. III, 16 aprile 2025 (ud. 10/2/2025), Ordinanza n. 9972 (Pres. Travaglino, Est. Ambrosi)
SICUREZZA SUL LAVORO – Morte del lavoratore dipendente – Domanda di risarcimento del danno dei congiunti – Domanda iure proprio – Competenza del giudice ordinario – Criterio del valore – Autonomo diritto al risarcimento – Responsabilità extracontrattuale.
In tema di responsabilità civile per morte del lavoratore dipendente, la domanda di risarcimento del danno proposta iure proprio dai congiunti del lavoratore deceduto esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro e resta devoluta alla cognizione del giudice competente secondo il generale criterio del valore, in quanto tali soggetti agiscono non “iure hereditario” ma “iure proprio”, quali soggetti che dalla morte del loro congiunto hanno subìto danno e, quindi, quali portatori di un autonomo diritto al risarcimento che ha la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c.
DIRITTO DEL LAVORO – Assicurazione della responsabilità civile – Azione nei confronti dell’assicuratore – Rapporto danneggiante-assicurato e assicuratore – Terzo-danneggiato – Vincolo contrattuale.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente confronti dell’assicuratore del responsabile del danno (salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge), atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante-assicurato e l’assicuratore dello stesso. Soltanto l’assicurato è legittimato, pertanto, ad agire nei confronti dell’assicuratore, e non anche il terzo-danneggiato, nei confronti del quale l’assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana.
RISARCIMENTO DANNI – Assicurazione contro i danni – Diritto dell’assicurato all’indennizzo – Rischio assicurato – Ambito della garanzia – Onere della prova – Onere dell’assicurato-danneggiato – Evento coperto dalla garanzia.
In tema di assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell’art. 2697 c.c. spetta all’assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro.
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. 4°, 15 aprile 2025 (ud. 5/12/2024), Sentenza n. 14796 (Pres. Dovere, Est. Cenci)
231 – Responsabilità degli enti – D.lgs. n. 231/2001 – Criteri d’imputazione oggettiva – Fatto illecito – Reato presupposto – Interesse dell’ente – Vantaggio dell’ente.
Per la responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 sussistono due criteri d’imputazione oggettiva del fatto illecito all’ente in quanto tale, nel senso che l’illecito amministrativo a carico del soggetto collettivo si configura quando la commissione del reato presupposto (da parte delle persone fisiche che agiscono per conto dell’ente) sia funzionale ad uno specifico interesse o vantaggio a favore dell’ente stesso (v. art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2001): si tratta di concetti alternativi e concorrenti tra loro, in quanto l’interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo; il vantaggio ha, invece, una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito.
(Nel caso di specie, è stata accertata la sussistenza sia dell’interesse sia del vantaggio dell’ente, poiché la stipula di un contratto di appalto per non fare emergere il rapporto di lavoro subordinato – ritenuto in effetti sussistente – ha comportato risparmi di spesa per quanto riguarda gli adempimenti connessi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro).
231 – Responsabilità da reato degli enti – Mancanza od inidoneità dei modelli di organizzazione – Inefficace attuazione – Colpa di organizzazione – Colpa dei soggetti autori del reato – Reato presupposto – Nesso causale.
Ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, non sono “ex se” sufficienti la mancanza od inidoneità degli specifici modelli di organizzazione o la loro inefficace attuazione, essendo necessaria la dimostrazione della colpa di organizzazione, che caratterizza la tipicità dell’illecito amministrativo e che è distinta dalla colpa dei soggetti autori del reato. In particolare, la mancata adozione e l’inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatore rispettivamente agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 231 del 2001 e all’art. 30 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non assurge ad elemento costitutivo della tipicità dell’illecito dell’ente ma integra una circostanza atta a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione, la quale va però specificamente provata dall’accusa, mentre l’ente può dare dimostrazione della assenza di tale colpa. Pertanto, l’assenza del modello, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione non sono, di per sé, elementi costitutivi dell’illecito dell’ente, tali invece essendo, oltre alla compresenza della relazione organica e teleologica tra il soggetto responsabile del reato presupposto e l’ente (cd. immedesimazione organica), la colpa di organizzazione, il reato presupposto ed il nesso causale che deve intercorrere tra i due. Nondimeno, deve ritenersi che, ove il Giudice rilevi la mancanza di documentazione, sia onere dell’ente di spiegare come, altrimenti, abbia provveduto a dotarsi in concreto di un modello organizzativo e gestionale adeguato (artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 231 del 2001).
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. 4°, 14 aprile 2025 (ud. 23/1/2025), Sentenza n. 14443 (Pres. Dovere, Est. Branda)
SICUREZZA SUL LAVORO – Preposto – Posizione di garanzia – Sicurezza sul lavoro – Area di gestione del rischio – Natura ed entità delle funzioni e dei poteri – Obbligo di comunicazione – Deficienze delle misure protettive.
Il preposto assume una posizione di garanzia ed è debitore di sicurezza nei confronti dei lavoratori ma solo con riferimento all’area di rischio che è chiamato a gestire in relazione alla natura e alla entità delle funzioni e dei poteri esercitati. Più precisamente, il preposto non ha soltanto il compito di vigilare sull’osservanza delle disposte misure antinfortunistiche, ma anche l’incombenza di rendere edotto delle deficienze delle misure protettive colui che ha l’obbligo di provvedere alla relativa adozione.
(Nel caso di specie l’affermazione di responsabilità in capo al preposto è stata logicamente ritenuta sulla base dell’omessa segnalazione della situazione di pericolo all’ignaro datore di lavoro che, se prontamente segnalata, avrebbe consentito di evitare l’evento lesivo).
SICUREZZA SUL LAVORO – Preposto – Poteri decisionali – Funzione integrativa – Segnalazione ai superiori – Profili di criticità nelle misure di sicurezza – Omissione di vigilanza – Omissione di segnalazione di situazioni di pericolo.
Il soggetto preposto alla vigilanza sui lavori, anche se sprovvisto di poteri decisionali, ha una funzione integrativa in chiave di segnalazione ai superiori degli eventuali profili di criticità delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, e di sollecitazione nella predisposizione degli accorgimenti tecnici più idonei in relazione alla specificità della lavorazione, posizione di garanzia che non esclude ma integra quella dei superiori gerarchici dotati di autonomia e capacità decisionale. Nello specifico, il preposto, pur se sfornito di poteri decisionali e di spesa, è comunque responsabile in caso di eventi lesivi riconducibili all’omissione di vigilanza e segnalazione di situazioni di pericolo.
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. 3°, 9 aprile 2025 (ud. 23/1/2025), Sentenza n. 13809 (Pres. Ramacci, Est. Magro)
SICUREZZA SUL LAVORO – Esercizio di fatto di poteri direttivi – Posizioni di garanzia – Regolare investitura – Funzioni del datore di lavoro – Assetto fattuale – Principio di effettività.
A norma dell’art. 299 d.lgs. n. 81/2008 (Esercizio di fatto di poteri direttivi), le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. Deriva dal disposto di tale norma che l’assunzione degli obblighi relativi alla posizione di garanzia prescinde da qualunque formalizzazione del rapporto di lavoro, radicandosi sul mero espletamento in linea di fatto delle funzioni proprie del datore di lavoro, indipendentemente dalla regolarità o meno, sotto il profilo civilistico, contributivo, fiscale, e via discorrendo, di tale assetto fattuale. Pertanto, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto.
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. 4°, 8 aprile 2025 (ud. 13/2/2025), Sentenza n. 13532 (Pres. Dovere, Est. Mari)
SICUREZZA SUL LAVORO – Obbligo di vigilanza del datore di lavoro – Osservanza delle misure di sicurezza – Prassi elusive dei lavoratori – Comportamento anomalo – Responsabilità colposa – Conoscenza – Colpevole ignoranza – Esigibilità del comportamento.
In tema di infortuni sul lavoro, l’obbligo del datore di lavoro di vigilare sull’esatta osservanza, da parte dei lavoratori, delle prescrizioni volte alla tutela della loro sicurezza, può ritenersi assolto soltanto in caso di predisposizione e attuazione di un sistema di controllo effettivo, adeguato al caso concreto, che tenga conto delle prassi elusive seguite dai lavoratori di cui il datore di lavoro sia a conoscenza; conseguendone che, in presenza di tale elemento, è ravvisabile la colpa del datore di lavoro anche in caso di comportamento anomalo del dipendente. Da ciò deriva lo speculare principio per cui in presenza di una prassi dei lavoratori elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, non è ravvisabile la colpa del datore di lavoro, sotto il profilo dell’esigibilità del comportamento dovuto omesso, ove non vi sia prova della sua conoscenza, o della sua colpevole ignoranza, di tale prassi.
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Lavoro, 30 marzo 2025 (ud. 18/12/2024), Ordinanza n. 8358 (Pres. Doronzo)
DIRITTO DEL LAVORO – Giusta causa di licenziamento – Gravità dei fatti addebitati al lavoratore – Proporzionalità tra fatti e sanzione – Contagio – False dichiarazioni – Non corretta gestione dell’emergenza sanitaria – Uso improprio del certificato INAIL – Scopo di nuocere al datore di lavoro.
Alla luce dei criteri interpretativi sanciti dall’art. 1362 c.c., per esprimere la valutazione dell’idoneità della condotta a giustificare il licenziamento ex art. 2119 c.c. si devono considerare l’insieme delle condotte contestate, non solo isolatamente, ma nella loro dimensione unitaria e reiterata, tenendo presenti non tanto e solo la mera violazione delle prescrizioni aziendali, ma anche le esigenze di sicurezza pubblica a cui quelle prescrizioni presiedevano, per valutare la complessiva gravità.
(Nel caso di specie, deve essere valorizzata la formulazione unitaria degli addebiti disciplinari, che certamente esprime nella contestualità dei fatti a cui sono riferiti, tutti realizzatisi durante il medesimo turno di servizio, un significativo rifiuto di svolgere l’attività lavorativa nel rispetto della normativa sulla sicurezza stradale e sul lavoro. Nello specifico, ad assumere rilievo sono le condotte di insubordinazione riportate dalla ricorrente, consistenti sostanzialmente nel : – ripetuto rifiuto del lavoratore, nell’ambito del medesimo turno lavorativo, di effettuare le comunicazioni al Centro radio che avrebbero favorito l’adempimento delle procedure per l’occupazione della sede stradale, preordinate alla sicurezza dei lavori, non solo per gli addetti, ma per gli automobilisti di passaggio; – avere ribadito il rifiuto, nonostante l’invito del Tecnico competente; – avere poi rifiutato di adempiere un ordine del medesimo tecnico di effettuare il cambio dell’automezzo).
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Lavoro, 27 marzo 2025 (ud. 11/12/2024), Ordinanza n. 8152 (Pres. Leone, Est. Pagetta)
SICUREZZA SUL LAVORO – Dispositivi di Protezione Individuale – Barriera protettiva – Rischi per la salute e sicurezza – Indumenti di lavoro – Datore di lavoro – Obbligo di continua fornitura – Obbligo di mantenimento in stato di efficienza – Diritto al rimborso – Spese sostenute per la pulizia dei DPI.
In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l’art. 2087 c.c.; ne consegue la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I., con la conseguenza che i lavoratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per la pulizia degli indumenti di protezione forniti dal datore di lavoro.
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Lavoro, 24 marzo 2025 (ud. 29/1/2025), Ordinanza n. 7788 (Pres. Pagetta, Est. Cinque)
DIRITTO DEL LAVORO – Giusta causa di licenziamento – Gravità dei fatti addebitati al lavoratore – Proporzionalità tra fatti e sanzione – Contagio – False dichiarazioni – Non corretta gestione dell’emergenza sanitaria – Uso improprio del certificato INAIL – Scopo di nuocere al datore di lavoro.
La sussistenza in concreto di una giusta causa di licenziamento va accertata in relazione sia della gravità dei fatti addebitati al lavoratore – desumibile dalla loro portata oggettiva e soggettiva, dalle circostanze nelle quali sono stati commessi nonché dall’intensità dell’elemento intenzionale -, sia della proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta, con valutazione dell’inadempimento in senso accentuativo rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” dettata dall’art. 1455 c.c. In ossequio a tali principi, deve ritenersi sussistente la giusta causa in presenza dei seguenti elementi: a) il dipendente non si era limitato riferire di avere contratto il virus, ma si era spinto ad affermare, con false dichiarazioni, che il contagio era stato frutto di una non corretta gestione dell’emergenza sanitaria da parte del suo datore di lavoro; b) le dichiarazioni erano state inserite in un modulo indirizzato ad un Ente (INAIL) a cui istituzionalmente è demandato il potere di controllo del rispetto da parte del datore di lavoro delle norme in tema di sicurezza sul lavoro; c) si trattava di precisazioni, fermo l’obbligo di denuncia e di comunicazione dell’infortunio e di invio di tutta la documentazione indispensabile a tal fine, non necessarie ai fini della tutela previdenziale richiesta, in una situazione in cui, per l’INAIL, già sussisteva una presunzione semplice, per l’operatore sanitario contagiato, di avere contratto il virus nell’ambiente lavorativo; d) era ravvisabile, pertanto, un uso improprio del certificato INAIL, con lo scopo di nuocere al datore di lavoro in quanto le affermazioni riguardavano fatti risultati insussistenti.
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Lavoro, Sent. 20 marzo 2025 (ud. 4/2/2025), n. 7483 (Pres. Tria, Est. Di Paolantonio)
SICUREZZA SUL LAVORO – Certificazione verde Covid-19 – Misure di sicurezza – Costi a carico del lavoratore – Campagna gratuita di vaccinazione – Test antigenico in sostituzione dell’obbligo vaccinale – Modalità alternativa alla vaccinazione – Scelta di rifiutare la somministrazione del vaccino.
La certificazione verde Covid-19 non può essere minimamente assimilata alle misure che il datore di lavoro è tenuto ad adottare, sopportandone i relativi costi, per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal d.lgs. n. 81/2008. Sul punto va evidenziato che il legislatore, una volta avviata la campagna gratuita di vaccinazione, che le più autorevoli voci scientifiche a livello mondiale indicavano come strumento idoneo a contrastare la diffusione del virus, ha permesso ad alcune categorie di lavoratori, pubblici e privati, la presentazione del test antigenico in sostituzione dell’attestato di avvenuto adempimento dell’obbligo vaccinale, e ciò ha fatto nell’esclusivo interesse del prestatore al quale è stato consentito di non sottoporsi alla vaccinazione, senza incorrere nella sospensione prevista dal legislatore quale conseguenza della mancata sottoposizione alla vaccinazione medesima. Conseguentemente non può essere invocato il principio secondo cui devono gravare sul datore di lavoro le spese che il prestatore sopporta nell’esclusivo interesse del primo, atteso che la previsione di una modalità alternativa alla vaccinazione è stata ispirata dall’intento di rispettare, ove possibile, la scelta della persona di rifiutare la somministrazione del vaccino.
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. 4°, 17 marzo 2025 (ud. 29/1/2025), Sentenza n. 10465 (Pres. Ciampi, Est. Cappello)
SICUREZZA SUL LAVORO – Responsabilità – Cause sopravvenute – Esclusione del rapporto di causalità – Processo causale autonomo – Sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico.
In materia di responsabilità per la sicurezza dei lavoratori, le cause sopravvenute idonee a escludere il rapporto di causalità sono solo quelle che innescano un processo causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dalla condotta omissiva o commissiva dell’agente, ovvero quelle che danno luogo a uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico, pur se eziologicamente riconducibile ad essa.
SICUREZZA SUL LAVORO – Posizione di garanzia – Automatico addebito di responsabilità – Principio di colpevolezza – Violazione della regola cautelare – Prevedibilità ed evitabilità dell’evento – Nesso causale.
La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del soggetto deputato a gestire il rischio, poiché il principio di colpevolezza impone la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione – da parte di costui – di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire, sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso.
SICUREZZA SUL LAVORO – Preposto – Misure di prevenzione – Esonero del datore di lavoro da responsabilità – Valutazione dei rischi – Modello collaborativo – Area di rischio – Comportamenti trascurati del lavoratore – Idoneità delle attrezzature.
La designazione di un preposto al rispetto delle misure di prevenzione non esonera il datore di lavoro da responsabilità ove risulti l’inidoneità di una misura prevista nel documento di valutazione dei rischi. In tal senso, è vero che il legislatore ha considerato anche il lavoratore nel novero dei soggetti garanti della sicurezza sui luoghi di lavoro, ma il modello “collaborativo” così delineato – in virtù del quale gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori – non implica alcun esonero di responsabilità in capo al datore di lavoro all’interno dell’area di rischio, nella quale si colloca il suo obbligo di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore. Invero, inerisce al datore di lavoro l’obbligo di predisporre e fornire ai lavoratori attrezzature idonee a svolgere in sicurezza le singole lavorazioni.
(Nel caso di specie, le attrezzature fornite sono state considerate inadeguate siccome incapaci di garantire la stabilità necessaria per effettuare la lavorazione demandata, da svolgersi in quota).
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Lavoro, 17 marzo 2025 (ud. 21/2/2025), Ordinanza n. 7033 (Pres. Tricomi, Est. Buconi)
DIRITTO DEL LAVORO – Prescrizione – Decorrenza – RISARCIMENTO DANNI – Malattia – Contagio – Percezione del danno ingiusto – Diligenza – Conoscenze scientifiche.
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Lavoro, 16 marzo 2025 (ud. 21/1/2025), Ordinanza n. 6984 (Pres. Doronzo, Est. Amendola)
SICUREZZA SUL LAVORO – Responsabilità datoriale per la salute e sicurezza sul lavoro – Onera della prova – Individuazione delle specifiche norme di cautela violate – Condizione di pericolo – Danno psicofisico – Nesso causale.
In caso di responsabilità datoriale per violazione delle regole di tutela della salute e sicurezza sul lavoro non spetta al lavoratore provare la colpa del datore danneggiante, né individuare le regole violate, né le misure cautelari che avrebbero dovuto essere adottate per evitare l’evento dannoso. In tal senso, in punto di allegazione del “fatto costituente inadempimento” l’onere gravante sul lavoratore non può estendersi fino a comprendere anche l’individuazione delle specifiche norme di cautela violate, specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate ma di casi in cui molteplici e differenti possono essere le modalità di conformazione del luogo di lavoro o delle modalità esecutive della prestazione ai requisiti di sicurezza; è, piuttosto, necessario, che il lavoratore alleghi la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, ed il nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo e danno psicofisico sofferto, incombendo a questo punto su parte datoriale l’onere di provare l’inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti.
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. 3°, 4 marzo 2025 (ud. 28/1/2025), Sentenza n. 8898 (Pres. Di Nicola, Est. Bucca)
SICUREZZA SUL LAVORO – Altezza dal suolo – Metri due – Precauzioni – Pericoli di caduta – Lavoro eseguito in altezza – Terreno sottostante – Piano di calpestio del lavoratore.
L’altezza superiore a metri due dal suolo, di cui all’art. 16 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 (ed oggi all’art. 107 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), in tema di precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose, va calcolata in riferimento all’altezza alla quale il lavoro viene eseguito rispetto al terreno sottostante e non al piano di calpestio del lavoratore.
SICUREZZA SUL LAVORO – Lavoro in quota – Rischi di caduta – Altezza superiore ai due metri – Nozione di applicazione generale – Costruzioni edilizie – Attività comportanti rischio di cadute.
La nozione di “lavoro in quota”, di cui all’art. 107 del Testo Unico del 2008, che si riferisce a lavori comportanti rischi di caduta da un’altezza superiore ai due metri, è nozione di applicazione generale, al punto di non essere limitata al settore delle costruzioni edilizie, riguardando tutte le attività in quota che possano determinare cadute dall’alto dei lavoratori.
(Nel caso di specie, essendo configurabile la nozione di lavoro in quota, il piano operativo di sicurezza – di cui al combinato disposto dell’art. 17, comma 1 lett. a, dell’art. 489, comma 1, lett. h, e dell’allegato XV del d.lgs. n. 81/2008 – doveva necessariamente recare specifica menzione delle misure preventive e protettive, nonché dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori; l’assenza di tali indicazioni, rilevante ai fini del rischio concretizzatosi, è stata specificamente valutata come elemento deponente per l’inidoneità del piano operativo di sicurezza predisposto dall’impresa).
SICUREZZA SUL LAVORO – Infortunio sul lavoro – Comportamento negligente, imprudente e imperito – Rischio eccentrico – Esclusione della responsabilità del garante – Cautele finalizzate al governo del rischio – Disposizioni di prevenzione e sicurezza.
In tema di infortunio sul lavoro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un rischio eccentrico, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia predisposto anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante. Infatti, qualora l’evento sia riconducibile alla violazione di una molteplicità di disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, il comportamento del lavoratore che abbia disapplicato elementari norme di sicurezza non può considerarsi eccentrico o esorbitante dall’area di rischio propria del titolare della posizione di garanzia, in quanto l’inesistenza di qualsiasi forma di tutela determina un ampliamento della stessa sfera di rischio fino a ricomprendervi atti il cui prodursi dipende dall’inerzia del datore di lavoro.
(Nel caso di specie, anche a voler addebitare al defunto un comportamento imprudente e anomalo, lo stesso, in quanto strettamente connesso alle mansioni di adibizione, non si risolve in una condotta esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulsa da ogni ipotizzabile scelta del lavoratore, in grado di attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia).
SICUREZZA SUL LAVORO – Datore di lavoro committente – Posizione di garanzia – Scelta dell’impresa – Controllo dell’appaltatore – Inadeguatezza delle misure precauzionali – Informazioni sui rischi specifici – DVR – Responsabile dei lavori.
Il committente datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa e in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini, sia con riguardo al dovere di fornire all’appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui i suoi dipendenti sono incaricati di lavorare. Più precisamente, in mancanza di un documento di valutazione dei rischi e di un responsabile dei lavori, a fronte di un contratto stipulato oralmente che non risulta contempli fra le prestazioni richieste la messa in sicurezza dell’area dell’intervento e di una situazione di pericolo che trae origine dal luogo stesso ove i lavoratori della ditta appaltatrice sono chiamati a operare, grava sulla società committente l’obbligo di procedere, quanto meno, a una preventiva verifica in ordine alle cautele volte a garantire lo svolgimento del lavoro in sicurezza.
CORTE DI CASSAZIONE Sez. Lavoro, 3 marzo 2025 (ud. 9/1/2025), Ordinanza n. 5618 (Pres. Doronzo, Est. Amendola)
APPALTI – SICUREZZA SUL LAVORO – Appalto – Responsabilità civile del committente – Mesotelioma pleurico contratto dal dipendente dell’appaltatore – Esposizione ad amianto – Prevenzione del rischio – Ambiente di lavoro – Lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2087 c.c.
Anche prima che il committente assumesse un’espressa posizione di garanzia, in attuazione della direttiva 92/57/CEE, nell’ambito dei lavori affidati in appalto, sussisteva la sua responsabilità civile, esclusiva o concorrente, originariamente prevista nei soli casi di ingerenza, direttiva o tecnico-operativa, nell’attività appaltata o di manifesta inidoneità dell’appaltatore, e, successivamente, per la prevenzione del rischio derivante dalla conformazione dell’ambiente di lavoro, nel caso di violazione dell’obbligo di destinare all’appaltatore un ambiente di lavoro sicuro. In generale, l’art. 2087 c.c., che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all’imprenditore l’adozione di misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, tenuto al dovere di provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori anche se non dipendenti da lui, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico-organizzativi dell’opera da eseguire.
RISARCIMENTO DANNI – Quantificazione del danno terminale – Morte causata da illecito – Danno morale terminale – Intensità della sofferenza – Danno biologico terminale – Lasso di tempo tra lesioni colpose e morte – Inabilità temporanea assoluta – Fattori di personalizzazione.
Nel danno non patrimoniale risarcibile iure hereditatis in caso di morte causata da un illecito si distinguono due componenti: il danno morale terminale (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell’avvertire consapevolmente l’ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall’apprezzabilità dell’intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l’intensità della sofferenza medesima; il danno biologico terminale, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell’integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo. In merito alla quantificazione in equivalente pecuniario di tale tipologia di danni, ferma la natura intrinsecamente equitativa della stima per non avere il valore della persona un prezzo, sono state avallate tecniche di liquidazione del danno biologico commisurate alle tabelle che stimano l’inabilità temporanea assoluta con opportuni “fattori di personalizzazione” che tengano conto dell’entità e dell’intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile exitus.
N.B: PER LE SENTENZE PER ESTESO E ALTRE SENTENZE CONSULTARE LA BANCA DATI DI GIURISPRUDENZA
OSSERVATORIO DI DIRITTO TRIBUTARIO
a cura di
Claudia Fava* e Michele Mauro** con la collaborazione di: Giuseppe Farcomeni ***
Rassegna di GIURISPRUDENZA in ambito di: FISCALITÀ AMBIENTALE (rifiuti, inquinamento, acque…) – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE in genere – ENTI LOCALI (fiscalità, urbanistica, edilizia, oneri…) – TRIBUTI ERARIALI – TRIBUTI DOGANALI – AGEVOLAZIONI FISCALI (Esenzioni…) – DIRITTO EUROPEO – DIRITTO PROCESSUALE TRIBUTARIO.
L’Osservatorio nasce come gruppo di studio con la finalità di fornire agli operatori del diritto un nuovo punto di riferimento in tema di fiscalità ambientale, agevolando l’aggiornamento giurisprudenziale. L’Osservatorio ospiterà repertori della giurisprudenza di merito e delle Corti superiori, anche sovranazionali, preceduti da una sintetica classificazione delle questioni affrontate. L’idea è quella di arricchire l’offerta editoriale della Rivista “AmbienteDiritto”, in maniera tale da attrarre l’attenzione dei lettori su argomenti particolarmente complessi e delicati, in continua evoluzione. Le pronunce giurisprudenziali oggetto di attenzione saranno saranno inserite in ordine cronologico
N.B: PER LE SENTENZE PER ESTESO E ALTRE SENTENZE CONSULTARE LA BANCA DATI DI GIURISPRUDENZA
GIURISPRUDENZA DI DIRITTO TRIBUTARIO
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA TOSCANA, Sez. III, 25/09/2025 (ud. 19/09/2025), Sentenza n. 1023
DIRITTO DELL’ENERGIA – IMPOSTE SUI REDDITI – Ires – Agevolazioni – Cumulabilità – Tremonti Ambiente – Tariffa GSE.
In tema d’imposte sui redditi, la dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare, in contrasto con l’art. 53 della Costituzione, l’assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge è emendabile anche in sede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza. (Pres. Greco, Est. Fugacci)
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI BARI, Sez. III, 24/09/2025 (ud. 15/09/2025), Sentenza n. 2228
DIRITTO URBANISTICO – TRIBUTI LOCALI – IMU – Riduzione – Fabbricati – Inagibilità – Inabitabilità – Documentazione – Accertamento dell’UTC a carico del proprietario.
La legge prevede la riduzione al 50 per cento della base imponibile ai fini IMU per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; l’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. (Pres. ed Est. Miccolis)
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI RIMINI, Sez. II, 23/09/2025 (ud. 15/09/2025), Sentenza n. 304
IMPOSTE SUI REDDITI – Ires – Ricerca e sviluppo – Prova.
Il fatto storico della avvenuta esecuzione del progetto relativo alla ricerca e sviluppo e dell’esborso delle relative somme, non può dirsi utilmente contestato dall’Ufficio (assenza di sistematicità, rendicontazione tardiva, dichiarazione integrativa) attraverso elementi che costituiscono mere perplessità, che non giungono ad integrare prova, neppure presuntiva, ai sensi dell’art. 2729 c.c., della falsità del fatto storico. Tale prova deve essere fornita dall’Ufficio poiché non può essere chiesto al contribuente di esibire una prova negativa, dopo avere assolto alla prova positiva mediante esibizione documentale. (Pres. ed Est. De Cono)
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL PIEMONTE, Sez. I, 23/09/2025 (ud. 15/09/2025), Sentenza n. 673
IMPOSTE SUI REDDITITI – Ires – Agevolazioni – Tremonti Ambiente – Rimborso.
Il diritto al rimborso vantato dal contribuente non è condizionato al necessario avvio di alcun procedimento, essendo sufficiente l’effettuazione dell’investimento ambientale, comprovata da perizia asseverata. (Pres. Giusta, Est. Paladino)
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LIGURIA, Sez. I, 23/09/2025 (ud. 07/07/2025), Sentenza n. 768
IMPOSTA DI REGISTRO – Agevolazione – Revoca – Causa di forza maggiore.
Il mancato rispetto del termine (ex art. 1 delle tariffe parte prima del DPR 131/1986) dipesa da ritardi burocratici attribuibili alla P.A. e non all’inerzia della società, può essere qualificata come “causa di forza maggiore”, e dunque, non determina la revoca dell’agevolazione. (Pres. Cardino, Est. Alessandri)
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI MESSINA, Sez. IV, 22/09/2025 (ud. 18/07/2025), Sentenza n. 5475
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Imposte locali – TARI – Notifica – Termini.
Il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il mittente deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario, tanto che la notifica venga operata a mezzo posta, quanto che la notifica venga operata a mezzo ufficiale giudiziario: la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto. (Pres. ed Est. De Marco)
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ANCONA, Sez. II, 16/09/2025 (ud. 04/07/2025), Sentenza n. 375
PROCESSO TRIBUTARIO – Giudicato – Identità di questioni – Mancata impugnazione.
Nel processo tributario si assiste spesso alla “serialità” dei ricorsi in relazione alle varie annate, tanto che una sentenza non impugnata in relazione ad un’annualità dello stesso tributo può avere la forza preclusiva di giudicato. (Pres. Samuele, Est. Marziali)
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA, Sez. VII, 15/09/2025 (ud. 08/09/2025), Sentenza n. 6312
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Provvedimento amministrativo – Incompetenza “assoluta” e “relativa” – Distinzione ed effetti – Carenza di potere – Nullità.
In presenza di un atto emesso da soggetto privo di competenza, va distinta la c.d. “incompetenza relativa”, che riguarda il provvedimento amministrativo che doveva essere emanato da organo diverso dello stesso ente, o dello stesso complesso organizzativo, dalla c.d. “incompetenza assoluta”, o difetto assoluto di attribuzione, a sua volta definita “carenza di potere in astratto”, vale a dire l’ipotesi in cui l’Amministrazione esercita un potere che in realtà nessuna norma le attribuisce, o perché non esiste proprio una norma che tale potere preveda, o perché, come in questo caso, lo preveda in capo ad altro ente. (Pres. Virzì, Est. Trebastoni)
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI COSENZA, Sez. IX, 19/09/2025 (ud. 15/09/2025), Sentenza n. 5839
DIRITTO DELL’AMBIENTE – Contributi consortili – presupposto – difesa idro-geologica.
Il presupposto impositivo dei contributi consortili che consiste, ai sensi degli artt. 860 с.c. е 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l’immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del piano di classifica e dell’inclusione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile. La presunzione è superata ove il contribuente provi che, in concreto, non sono state esplicate funzioni o compiti attribuiti dalle leggi statali e regionali, quali manutenzione, l’esercizio, la custodia delle opere di bonifica, la difesa idro-geologica e la tutela dell’ambiente da parte del Consorzio su nessun immobile di proprietà del contribuente medesimo. (Pres. ed Est. Pellegrino)
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI TARANTO, Sez. I, 16/09/2025 (ud. 10/09/2025), Sentenza n. 1433
RIFIUTI – DIRITTO DELL’AMBIENTE – Chi inquina paga – Rifiuti speciali – Smaltimento a proprie spese – Determinazione della superficie assoggettabile alla TARI – Presupposto impositivo.
La materia dei rifiuti speciali è disciplinata esclusivamente dal comma 649 dell’art. 1 della legge 147/2013, secondo la quale nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Ne consegue che i cespiti che producono rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani non sono assoggettabili al tributo, non per effetto di una agevolazione, ma per la semplice ragione che non realizzano il presupposto di fatto impositivo. Non realizzandosi il presupposto di fatto impositivo, i produttori di tali rifiuti vengono ad essere esclusi dal servizio, in ossequio al principio sovranazionale secondo cui (solo) chi inquina paga. (Pres. ed Est. Brandimarte)
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI BRINDISI, Sez. I, 28/08/2025 (ud. 18/06/2025), Sentenza n. 447
DIRITTO DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Ecotassa – Veicoli inquinanti – Riduzione emissioni.
La legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 1042, prevede un’ecotassa con la quale il legislatore ha inteso disincentivare, nell’arco temporale di riferimento, che ulteriori veicoli inquinanti potessero circolare sul territorio italiano, aggiungendosi a quelli già in circolazione rispetto alla data del 1° marzo 2019, siano essi nuovi di fabbrica o già immatricolati in un altro Stato. (Giud. Monocratico Esposito)
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO SECONDO GRADO DELLA LIGURIA, Sez. II, 28/08/2025 (ud. 13/05/2025), Sentenza n. 690
TRIBUTI ERARIALI – Parametri normativi – Presunzione legale – Mancato raggiungimento dei volumi minimi di ricavi – Onere probatorio – Interpello antielusivo – Art. 30, c.1, L. n. 724/1994.
Il mancato raggiungimento degli standard minimi di ricavi di cui al comma 1 dell’art. 30, l. n. 724/1994 costituisce una mera presunzione legale relativa alla natura non operativa della società contribuente, presunzione che il contribuente può vincere dimostrando, attraverso l’interpello finalizzato alla disapplicazione delle disposizioni antielusive, ovvero in giudizio, dimostrando le oggettive situazioni che abbiano reso impossibile raggiungere il volume minimo di ricavi o di reddito determinato secondo i predetti parametri normativi. (Pres. Castaldi, Est. Caridi)
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIA, Sez. V, 28/08/2025 (ud. 07/05/2025), Sentenza n. 5671
PROCESSO TRIBUTARIO – Accertamento – Diritto di difesa – TRIBUTI ERARIALI – Motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria – Necessità.
Il novellato art. 7, l. 212/2000 prescrive un obbligo di chiarezza e motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria, con indicazione specifica dei presupposti, dei mezzi di prova, e delle ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. La disposizione prescrive tale obbligo contenutistico-motivazionale, a pena di annullabilità, e si raccorda con le innovazioni normative in tema di onere probatorio a carico dell’amministrazione finanziaria. Trattasi, altresì, di una norma della quale non va obliterato il raccordo con l’esigenza di difesa, non (più) limitata da uno sbilanciamento di poteri tra Ufficio e contribuente. In questa ottica e nell’obiettivo di dare propulsione alla finalità di un corretto bilanciamento di interessi, che presiede non solo all’attività giurisdizionale ma già anche prima alla formazione degli atti impositivi, va riconosciuta la tutela piena del contribuente chiamato ad una collaborazione con l’attività degli organi finanziari ed a contribuire ad evitare defatiganti contenziosi giudiziari. Pres. DI MAIO, Rel. ORIO
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO, Sez. II, 08/08/2025 (ud. 19/06/2025), Sentenza n. 5097
RIFIUTI – TARI – Tariffa – Riduzione – TRIBUTI LOCALI – Contrazione servizio – Applicabilità.
Le riduzioni tariffarie tecniche previste, in tema di TARI, essendo chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio spettano ope legis, a prescindere dalla loro previsione nel regolamento comunale e senza la necessità di una specifica e preventiva domanda, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi. (Pres. Liotta, Est. Frattarolo)
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI FOGGIA, Sez. III, 25/08/2025 (ud. 04/07/2025), Sentenza n. 1642
TRIBUTI ERARIALI – Divieto di doppia imposizione – Accertamento – Persona interposta – rimborso – Art. 37, c.5, d.P.R. n. 600/1973.
Il divieto di doppia imposizione è ravvisabile solo quando una medesima imposta gravi sullo stesso soggetto e non già invece quando l’ente impositore la richieda a persone diverse. In quest’ultimo caso, individuato il soggetto effettivamente debitore, l’estraneo maturerà il diritto a richiedere il rimborso di quanto eventualmente versato. In caso contrario, non si capirebbe l’esplicita previsione del d.P.R. n. 600/1973, art. 37, comma 5, che prevede che le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente imputati, a norma del comma 3, ad altro contribuente, possono chiederne il rimborso (e in misura non superiore a quanto effettivamente riscosso dall’interposto). (Pres. D’Alessio, Est. Labianca)
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO, Sez. VI, 07/08/2025 (ud. 20/06/2025), Sentenza n. 43941
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – TRIBUTI LOCALI – IMU – Esenzione – Immobile a prevalente destinazione ricettiva.
L’esclusiva, e comunque assolutamente prevalente, destinazione ad uso ricettivo dell’unità immobiliare determina il venir meno di uno dei requisiti essenziali per il riconoscimento dell’esenzione prevista dalla normativa in tema di IMU, permanendo il solo dato, per la verità di carattere meramente formale, della residenza anagrafica in esso della sua proprietaria, ma difettando quello dell’effettiva adibizione a dimora sua e del proprio nucleo familiare. (Pres. e Est. Petruzziello)
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO, Sez. I, 06/08/2025 (ud. 15/04/2025), Sentenza n. 5041
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – TRIBUTI LOCALI – IMU – Università religione valdese – Assimilazione seminari chiesa cattolica – Esenzione.
Lo stabile dove ha sede la Facoltà Valdese di teologia, per la formazione di pastori e diaconi, dove si svolge attività di preghiera, studio, accoglienza e solidarietà sociale, è assimilabile ad un seminario della religione cattolica; il fatto che i docenti siano pastori conferma tale assunto; anche le unità ove vivono le famiglie dei pastori hanno le stesse finalità e non hanno un utilizzo diverso dai locali dedicati allo studio come le aule, al riposo come il convitto, alla preghiera come la chiesa e ciò, indipendentemente, dalla categoria catastale attribuita. Proprio tale assimilazione, consente di ritenere che tali immobili siano esenti da Imu. (Pres. Terrinoni, Est. Pannone)
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA, Sez. XXIV, 05/08/2025 (ud. 16/05/2025), Sentenza n. 2440
URBANISTICA E EDILIZIA – CATASTO – Rendita catastale – Immobili di lusso – Criteri.
Un immobile di lusso (categoria catastale A/1 – abitazioni di tipo signorile) si caratterizza per ampie metrature, finiture di alta qualità, impiego di materiali di costruzione pregiati, sistemi tecnologici avanzati e servizi esclusivi. Gli edifici accatastati in A/1 vantano standard costruttivi e tecnologici di alto livello, superando di gran lunga le comuni abitazioni residenziali. (Pres. ed Est. Dettori)
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA, Sez. III, 04/08/2025 (ud. 07/07/2025), Sentenza n. 940
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – TRIBUTI LOCALI – IMU – Diniego di rimborso – Prova – Abitazione principale.
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore (e non più anche il proprio nucleo familiare) dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L’assenza (o pressoché l’assenza) di consumi nei mesi invernali, induce a ritenere (in assenza di difese sul punto) che il possessore al più vi dimori nei mesi estivi, ma non già stabilmente e abitualmente. (Pres. Silvestrini, Est. Carra)
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI RIMINI, Sez. II, 01/08/2025 (ud. 16/06/2025), Sentenza n. 268
Atto di recupero emesso e notificato dall’ Agenzia delle Entrate – IRES – Credito d’imposta “ricerca e sviluppo” – Prova – Parere tecnico MISE – Eccesso di potere.
È nullo l’atto di recupero emesso e notificato dall’ Agenzia delle Entrate, relativo al credito “Ricerca e Sviluppo”, per evidente eccesso di potere, in quanto l’Ufficio, per poter contestare efficacemente nel merito la sua spettanza, avrebbe dovuto acquisire il parere tecnico del MISE; infatti: pur trattandosi di una facoltà e non di un obbligo, di fronte a problematiche di grande complessità, diventa necessaria la valutazione di un organismo tecnico maggiormente qualificato. In assenza del parere tecnico, le pur articolate motivazioni esposte nell’atto di recupero si pongono di fatto sullo stesso piano delle altrettanto deduzioni difensive e, quindi, appaiono intrinsecamente insufficienti a legittimare la pretesa impositiva. (Pres. De cono, Est. Ercolani)
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI PERUGIA, Sez. II, 24/07/2025 (ud. 03/07/2025), Sentenza n. 474
DIRITTO DEL’ENERGIA – IRES – Investimenti ambientali – Agevolazione – C.d. Tremonti ambiente – Accertamento.
La ritrattabilità della dichiarazione risulta possibile anche per la mancata fruizione di un beneficio, qualora tale comportamento (scelta) sia imputabile ad obiettiva incertezza interpretativa su una norma agevolativa e ciò specificamente in ordine alla cumulabilità delle agevolazioni consistenti nella tariffa incentivante prevista dal “conto energia” e nella detassazione, “ora per allora”, degli investimenti ambientali ai sensi della c.d. Tremonti Ambientale. Pres. CATALANO, Rel. MANUALI
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ROMA, Sez. XL, 24/07/2025 (ud. 17/07/2025), Sentenza n. 10598
RIFIUTI – Corretta determinazione della TARI – Superficie calpestabile – TRIBUTI LOCALI – Avviso di accertamento – Illegittimità.
Ai fini della corretta determinazione della Tari, l’avviso di accertamento deve tenere conto esclusivamente della superficie calpestabile. Giud. monocratico FILIPPI
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LIGURIA, Sez. I, 24/07/2025 (ud. 28/04/2025), Sentenza n. 637
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Presenza vicino alla casa di terreni coltivabili (vitigni, oliveti) – Rapporto economico funzionale fra i due beni immobili – Valore aggiunto – Rapporto pertinenziale di cui all’art. 817 cod.civ. – Accertamento.
La presenza vicino alla casa di terreni coltivabili (vitigni, oliveti) può costituire un valore aggiunto per la stessa abitazione instaurando un rapporto economico funzionale fra i due beni immobili, che configura un rapporto pertinenziale di cui all’art. 817 cod.civ.. Pres. PIOMBO, Rel. CHITI
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA, Sez. I, 23/07/2025 (ud. 03/07/2025), Sentenza n. 2327
DIRITTO DELL’ENERGIA – Risparmio energetico – Detrazione – Controllo dell’Amministrazione finanziaria – Termini – IRES.
Il controllo dell’Amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione, deve riguardare la dimostrazione, da parte del contribuente, che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico; il mancato rispetto del termine di novanta giorni dalla fine dei lavori in capo al soggetto passivo non è perentorio in quanto ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico. Pres. ANCONA, Rel. BIANCHI
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA, Sez. III, 23/07/2025 (ud. 14/04/2025), Sentenza n. 2321
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Tributi o contributi – Cancellazione della società dal registro delle imprese – estinzione.
In tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione, disposizione di natura sostanziale, operante solo nei confronti dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi – implica che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ROMA, Sez. XXIX, 21/07/2025 (ud. 27/02/2025), Sentenza n. 10328
RIFIUTI – Indicazione della superficie imponibile – TRIBUTI LOCALI – Avviso di accertamento TARI – Indicazione nell’atto impositivo di tutti gli elementi posti a base della pretesa fiscale – Mancanza – Atto nullo – Diritto di difesa del contribuente.
Deve essere annullato l’avviso di accertamento Tari in assenza dell’indicazione della superficie imponibile, in quanto, trattandosi di pretesa tributaria, l’atto deve consentire la comprensibilità e con essa la possibilità di valutare la legittimità della pretesa fiscale, incombendo sull’Ente impositore l’onere di indicare nell’atto impositivo tutti gli elementi posti a base della pretesa fiscale, al fine di garantire il rispetto del diritto di difesa del contribuente. Pres. CORIGLIANO CAMPOLITI, Rel. FILOCAMO
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI CUNEO, Sez. II, 21/07/2025 (ud. 07/07/2025), Sentenza n. 123
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – IRES – Agevolazione Tremonti ambiente – Controlli automatizzati della dichiarazione integrativa – Accertamento
È legittima la procedura in base alla quale l’Agenzia delle entrate, a seguito dei controlli automatizzati della dichiarazione integrativa, emergendo degli importi non coerenti con la dichiarazione del periodo d’imposta precedente, genera una comunicazione di irregolarità il cui esito sarà comunicato al contribuente che, in tale sede, dovrà esibire la documentazione idonea ad evidenziare le modalità di rideterminazione delle risultanze che emergono dalla dichiarazione integrativa. Pres. MACAGNO, Rel. GRECO
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI, Sez. XXIV, 21/07/2025 (ud. 14/05/2025), Sentenza n. 13183
RIFIUTI – Tributi locali – TARI – Immobile in cui l’attività afferente alla categoria applicata non venga più svolta – Imposizione.
La circostanza in cui in un immobile l’attività afferente alla categoria applicata non venga più svolta, non determina il venir meno della pretesa impositiva. Pertanto, sussiste l’obbligo di pagare la tassa rifiuti in tutti i casi in cui l’immobile è idoneo a produrre rifiuti a prescindere dall’effettiva produzione degli stessi per volontà o esigenze dell’utente.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ROMA, Sez. XXI, 21/07/2025 (ud. 25/06/2025), Sentenza n. 10363
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – TRIBUTI LOCALI – Preavviso di fermo amministrativo – Eccezione di prescrizione e decadenza per mancata notifica nei termini – Impugnazione.
Il contribuente non può formulare avverso il preavviso di fermo amministrativo l’eccezione di prescrizione e decadenza per mancata notifica nei termini di legge delle relative cartelle di pagamento, dovendo essa proporsi entro il termine di impugnazione di quest’ultime, decorso il quale, divengono definitive.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI REGGIO CALABRIA, Sez. III, 18/07/2025 (ud. 12/06/2025), Sentenza n. 5378
RIFIUTI – TRIBUTI LOCALI – Codice ATECO – Esenzione TARI – Onere di denuncia/richiesta.
Il mero possesso di un codice ATECO in capo ad una impresa contribuente, assente ogni comunicazione da parte di quest’ultima volta a dimostrare la sussistenza in concreto delle condizioni che consentono l’esenzione TARI è irrilevante ai fini dell’ufficio, non potendosi prescindere – in presenza di una specifica previsione regolamentare – dall’onere di denuncia/richiesta di esenzione.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI, Sez. XXX, 18/07/2025 (ud. 26/06/2025), Sentenza n. 13072
PROCESSO TRIBUTARIO – Osservazioni del contribuente – Obbligo di motivazione della P.A. – Contraddittorio informato ed effettivo – TRIBUTI ERARIALI – Accertamento – Contraddittorio endoprocedimentale – Schema d’atto.
L’art. 6-bis, comma 4, della legge 212/2000 prescrive che “l’atto adottato all’esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l’Amministrazione ritiene di non accogliere”. Se la ratio della norma, esplicitata dal primo comma della disposizione in esame, è quella di assicurare un “contraddittorio informato ed effettivo” è evidente come, nella specie, non vi sia stato alcun contraddittorio “effettivo”, non avendo l’amministrazione fornito alcun “effettivo”, reale riscontro alla documentazione offerta dalla contribuente, con la conseguenza che l’intero segmento procedimentale si è rivelato, ex post, fine a sé stesso, tradendo lo spirito dell’innovazione legislativa. Conseguenza dell’accertata violazione è l’annullamento degli atti impugnati. Pres. FERRARA, Rel. GUGLIANO
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO, Sez. V, 17/07/2025 (ud. 27/06/2025), Sentenza n. 3962
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Credito imposta – Ricerca e sviluppo – Presupposto – Campo scientifico o tecnologico.
Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, dunque, assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. La condizione del perseguimento di un progresso o un avanzamento delle conoscenze e delle capacità generali si considera realizzata anche nel caso dell’adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o della tecnica al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI, Sez. I, 17/07/2025 (ud. 22/05/2025), Sentenza n. 12992
RIFIUTI – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – TRIBUTI LOCALI – TARI – Determinazione della quota – Variabile del tributo – Componenti del nucleo familiare.
Solo in relazione alle utenze domestiche il detto decreto prevede che, per la determinazione della quota variabile del tributo, debba tenersi conto del numero dei componenti del nucleo familiare.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI BRESCIA, Sez. III, 15/07/2025 (ud. 23/06/2025), Sentenza n. 605
DIRITTO DELL’ENERGIA – AGEVOLAZIONE – TREMONTI AMBIENTE – Presupposto.
Non dispongono dei presupposti per accedere agli incentivi le “imprese di scopo”, ovvero quei soggetti che producono energia elettrica non per l’autoconsumo ma per la cessione sul mercato.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL’ABRUZZO, Sez. VII, 30/06/2025 (ud. 09/06/2025), Sentenza n. 543
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Accertamento – Ne bis in idem – Cumulo sanzionatorio.
Il nucleo del principio del ne bis in idem, dunque, fuori dall’ipotesi dell’avvio di un nuovo giudizio dopo la conclusione del primo, appare riconducibile, con peculiare riguardo alle sanzioni tributarie, al seguente enunciato: la sostanziale simultaneità del procedimento penale e di quello amministrativo-tributario, che assolvono a scopi diversi e complementari in relazione ai parametri normativi che giustificano l’esercizio dell’azione penale e attesa la pacifica circolazione probatoria tra i due giudizi del materiale ritualmente prodotto. Parallelamente, nel giudizio non osta alla irrogazione di una duplice sanzione (penale e tributaria), ferma la necessità di una valutazione, in concreto, della complessiva afflittività del cumulo sanzionatorio che deve rispondere a criteri di proporzionalità.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO, Sez. XV, 30/06/2025 (ud. 26/06/2025), Sentenza n. 4110
DIRITTO TRIBUTARIO EUROPEO – IVA – Rimborso.
È ricorrentemente ribadito il principio secondo cui il rimborso dell’IVA può essere eseguito con “modalità […] devono segnatamente consentire al soggetto passivo di recuperare, in condizioni adeguate, la totalità del credito risultante da detta eccedenza di IVA, il che implica che il rimborso sia effettuato, entro un termine ragionevole mediante pagamento con somme liquide di denaro o in un modo equivalente, e che, in ogni caso, il sistema di rimborso adottato non deve far correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo (v. C-25/07; C-525/11; C-387/16)” perché una differente interpretazione si porrebbe in contrasto con il diritto unionale e con il principio di neutralità fiscale sancito dalla Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA).
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA, Sez. II, 30/06/2025 (ud. 28/02/2025), Sentenza n. 835
DIRITTO TRIBUTARIO EUROPEO – Agevolazioni – Investimenti ambientali – Detassazione.
Con l’articolo 6, commi da 13 a 19, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, è stata introdotta un’agevolazione volta ad incentivare le piccole e medie imprese che realizzano “investimenti ambientali” effettuati fino al 26 giugno 2012. La ratio delle citate disposizioni è quella di incentivare gli investimenti ambientali da parte delle piccole e medie imprese (PMI), offrendo una detassazione fiscale per la quota di reddito destinata a tali investimenti. In sostanza, la legge mira a favorire la transizione verso un’economia più sostenibile, riducendo la pressione fiscale sulle PMI che adottano pratiche eco-compatibili.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL’ABRUZZO, Sez. VII, 30/06/2025 (ud. 12/05/2025), Sentenza n. 540
DIRITTO TRIBUTARIO EUROPEO – Discriminazione sulla base della residenza – Tassazione dei dividendi.
Il tema del regime di tassazione italiano dei dividendi distribuiti in Italia ad O.I.C.R. esteri è stato oggetto di una attività investigativa da parte della Commissione UE (cfr. EU PILOT 8105/15/TAXU) in merito all’incompatibilità con il diritto europeo e la possibile discriminazione rispetto al trattamento riservato agli O.I.C.R. nazionali. Ed invero, la normativa interna è stata modificata dalla Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020 c. da 631 a 633, prevedendo che con riferimento ai dividendi percepiti dal 1° gennaio 2021, il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da O.I.C.R. di diritto estero, stabiliti in Stati UE o SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni (tassati al 26%), fosse equiparato al trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze realizzati da analoghi organismi istituiti e residenti in Italia (esenti da imposizione).
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI BRESCIA, Sez. II, 30/06/2025 (ud. 20/06/2025), Sentenza n. 550
DIRITTO TRIBUTARIO EUROPEO – Accertamento – Stabile organizzazione – Esterovestizione.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 73 TUIR, una società è considerata residente in Italia se la sede dell’amministrazione, intesa come luogo effettivo in cui vengono adottate le decisioni essenziali, coincide con il territorio italiano. Se gli atti istruttori rilevano che le assemblee e le decisioni strategiche si svolgevano in Italia e che la documentazione contabile e la gestione operativa erano attuate tramite strutture italiane, ne deriva che il centro decisionale è localizzato in Italia. La natura artificiosa dell’interposizione è il mezzo per ottenere un vantaggio fiscale indebito. Infatti, l’interposizione fittizia, distinta dalla mera stabile organizzazione, consiste nella volontaria attribuzione formale di redditi a una società terza (la interposta) per sottrarli all’imposizione dell’effettivo titolare.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CALABRIA, Sez. II, 27/06/2025 (ud. 03/06/2025), Sentenza n. 1829
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Imposte ambientali – IRBA – Incompatibilità con il diritto unionale.
L’Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione (IRBA) è incompatibile con il diritto dell’Unione Europea; tale incompatibilità discende dal fatto che l’IRBA non soddisfa il requisito di “finalità specifica” imposto dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, come chiarito dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza del 9 novembre 2021, causa C-255/20) e dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione (es. sentenze n. 6687/5 del 06.03.2023 e n. 6858) La “finalità specifica” non può essere meramente di bilancio, ma deve essere in grado di influenzare il comportamento dei contribuenti per raggiungere lo scopo invocato.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ROMA, Sez. V, 27/06/2025 (ud. 23/06/2025), Sentenza n. 8950
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PROCESSO TRIBUTARIO – Accertamento – Nullità della notificazione – Potere impositivo.
Nel processo tributario, poiché la notificazione dell’atto impositivo è inerente al legittimo esercizio del relativo potere, il contribuente che deduce un qualsiasi vizio relativo alla notificazione stessa non formula una “eccezione” in senso proprio, bensì compie una mera “contestazione”, avente ad oggetto proprio l’illegittimità dell’esercizio in concreto del potere impositivo.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI MACERATA, Sez. II, 26/06/2025 (ud. 13/03/2025), Sentenza n. 208
TRIBUTI – IMPOSTE AMBIENTALI – Addizionale provinciale sull’accisa dell’energia elettrica – Illegittimità – Retroattività – Prodotti energetici – Applicazione della disciplina europea.
L’addizionale provinciale sull’accisa dell’energia elettrica di cui all’art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 deve essere disapplicata per contrasto con l’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, in quanto priva della finalità specifica richiesta dal diritto dell’Unione Europea. Tale illegittimità si estende retroattivamente al periodo dal 1° gennaio 2004, momento in cui la Direttiva 2003/96/CE ha esteso l’ambito di applicazione della disciplina europea anche ai prodotti energetici.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SIRACUSA, Sez. I, 26/06/2025 (ud. 14/04/2025), Sentenza n. 1367
DIRITTO DELL’AMBIENTE – Ecotassa – Recupero energia dai rifiuti – Smaltimento ecosostenibile – Tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Il tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla l. n 549/1995, art. 3, commi 24-41, è una c.d. “ecotassa”, la cui ratio, argomenta il comma 24, è quella di incentivare la minore produzione possibile di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima e di energia (riducendo la convenienza economica dello smaltimento mediante semplice deposito in discarica od incenerimento senza il recupero di energia). (Pres. Saito, Est. Marchionni)
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI COSENZA, Sez. IX, 25/06/2025 (ud. 26/06/2025), Sentenza n. 4615
RIFIUTI – Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti – IMPOSTE AMBIENTALI – TARI – Determinazione della tariffa – Principio “chi inquina paga”.
La Tari, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è disciplinata dai commi da 641 a 668 della legge di stabilità del 2014, che individuano i presupposti della stessa (comma 641) e i criteri di determinazione della tariffa, come stabiliti dal d.P.R. n. 158 del 1999 (commi 650 e 651), sulla base dei princìpi contenuti nei commi 252 e 254 del “chi inquina paga”, di cui alla Direttiva 2008/98/CEE (art. 14).
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA, Sez. VII, 25/06/2025 (ud. 23/06/2025), Sentenza n. 4585
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Ente pubblico (Consorzio di Bonifica) – Delega delle proprie potestà impositive ad altri soggetti anche se pubblici – ACCERTAMENTO – Nullità – difetto assoluto di attribuzione.
Un ente pubblico, (nel caso di specie un Consorzio di Bonifica) non può delegare, in nessun modo, le proprie potestà impositive ad altri soggetti, anche se pubblici. In questa ipotesi, il provvedimento impugnato è nullo per difetto assoluto di attribuzione perché l’ente delegato esercita un potere impositivo che nessuna norma le ha attribuito.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI MODENA, Sez. III, 25/06/2025 (ud. 16/01/2025), Sentenza n. 243
RIFIUTI – Determinazione della superficie assoggettabile alla TARI – Principio “chi inquina paga” – Art. 6-bis Legge n. 212/2000 – Rifiuti speciali.
Costituisce violazione dell’obbligo di motivazione l’ipotesi in cui l’Ente impositore non motiva compiutamente sulle ragioni di non accoglimento delle osservazioni formulate nelle controdeduzioni presentate all’esito dell’instaurato contraddittorio preventivo ex art. 6-bis, legge n. 212/2000, con particolare riferimento alla contrarietà della pretesa comunale al principio “chi inquina paga”. Nel caso di specie, l’Amministrazione non ha applicato il comma 649, dell’art. 1, L. n. 147 del 27/12/2013, in forza del quale “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI CATANZARO, Sez. IV, 25/06/2025 (ud. 23/06/2025), Sentenza n. 1385
TRIBUTARIO – Accertamento dell’IVA – Operazioni soggettivamente inesistenti – Onere probatorio – Giurisprudenza.
In materia di accertamento dell’IVA, mentre le operazioni oggettivamente inesistenti sono completamente fittizie, sicché per l’Amministrazione è sufficiente provare l’inesistenza dell’operazione stessa al fine di giustificare il recupero dell’Iva illecitamente detratta, le operazioni soggettivamente inesistenti sono realmente avvenute, ma non già con il soggetto formalmente indicato nella fattura (fornitore interposto o “cartiera”) bensì con un soggetto diverso. In tale ultimo caso, anche in applicazione dei princìpi eurounitari, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare, anche tramite presunzioni semplici, che il contribuente era o avrebbe dovuto essere consapevole dell’effettiva identità del reale cedente, senza ovviamente esigere che il contribuente, per acclarare la fittizietà o meno della controparte, effettui verifiche che non rientrano nella sua competenza (ex plurimis, Cass. civ. n.2800/2025; n. 14102/2024; n. 4619/2023; CGUE C-440/2004; C-80/2011). Giudice Monocratico NANIA
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI LATINA, Sez. II, 24/06/2025 (ud. 09/05/2025), Sentenza n. 766
DIRITTO DELL’ENERGIA – Accisa provinciale sull’energia elettrica – Accertamento – Imposta ambientale.
L’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica, all’art. 6, d.l. 28 novembre 1988 n. 511 è stata ritenuta costituire tributo contrario al diritto europeo, per contrasto con l’art. 1, par. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di Giustizia della UE con le sentenze 5.3.2015, causa C-553/13 e 25.7.2018, causa C/103/17, in quanto il relativo gettito non è stato destinato a specifici scopi ambientali. Pres. BOTTIGLIERI, Rel. RESCIGNO
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, Sez. XVI, 23/06/2025 (ud. 04/06/2025), Sentenza n. 1528
DIRITTO DELL’ENERGIA – Imposte ambientali – Accisa sull’energia – Potestà impositiva.
Il contrasto tra la disciplina interna e il diritto europeo rilevato con riferimento alla direttiva n. 2008/118/CE, recepita dallo Stato italiano con d. lgs. 48/2010, con effetto dal 1° aprile 2010, va esteso anche alla previgente Direttiva 92/12/CEE, data la sostanziale continuità tra l’art. 3, par. 2, della Direttiva 92/12/CEE e l’art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE, nella parte in cui condizionano l’esercizio della potestà impositiva degli Stati membri nell’applicazione di altre imposte indirette ai prodotti sottoposti ad accisa alla previsione di “finalità specifiche” di tali prelievi.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ROMA, Sez. XIII, 20/06/2025 (ud. 17/06/2025), Sentenza n. 8597
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Accertamento – Sanzioni – Principio di proporzionalità.
La misura sanzionatoria adottata (ad es. fermo di veicolo) non può essere sproporzionata rispetto alla entità della pretesa tributaria (in specie € 322,43). Occorre rispettare la necessaria proporzionalità tra lo strumento di tutela offerto dall’ordinamento al creditore e l’interesse del debitore che viene conseguentemente sacrificato. In particolare, il giudizio di ragionevolezza deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dall’Amministrazione rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire. Tali princìpi valgono, pertanto, sia come criteri di interpretazione delle norme, sia come canoni di legittimità dell’azione del legislatore e dell’Amministrazione, e da ultimo hanno trovato espressa codificazione nel diritto tributario con l’art. 10 ter dello Statuto del Contribuente.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO, Sez. III, 20/06/2025 (ud. 14/05/2025), Sentenza n. 3454
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-Tributi locali- RIFIUTI – Smaltimento a proprie spese – Esenzione dal pagamento della TARI – Onere della prova.
Il presupposto per poter accedere all’esenzione dal pagamento della Tari per i rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, direttamente o avvalendosi di soggetti autorizzati, è il rispetto della normativa ambientale sul ciclo dei rifiuti declinata nel Codice dell’Ambiente. Per questo motivo, i soggetti interessati hanno l’obbligo di fornirne la prova, attraverso l’attestazione dell’avvenuto smaltimento; o attraverso l’esibizione di documenti contabili, come fatture o attestazioni di pagamento; o attraverso documentazione di tipo tecnico-amministrativo, quali contratti, attestazioni di avvenuto smaltimento, formulario di identificazione/ documento di trasporto; registro di carico e scarico ecc.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO, Sez. XVIII, 20/06/2025 (ud. 04/06/2025), Sentenza n. 165
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Tributi locali – RIFIUTI – TARI – Esenzione / esclusione – Qualifica di “luogo di culto” – Accertamento in base a elementi oggettivi.
La qualifica di “luogo di culto”, idonea eventualmente a giustificare una diversa considerazione ai fini impositivi, deve essere accertata in base a elementi oggettivi, idonei a comprovare un uso esclusivamente religioso del bene.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI COMO, Sez. II, 19/06/2025 (ud. 28/04/2025), Sentenza n. 165
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Tributi locali – Gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani – RIFIUTI – TARSU/TIA – Requisiti della fatturazione.
Gli atti con cui il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di tariffa di igiene ambientale, anche quando gli stessi dovessero avere la forma di fattura commerciale, non attengono al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma a un’entrata pubblicistica, per cui, avendo natura di atti impositivi, anche le fatture TIA debbono rispondere ai requisiti sostanziali propri di questi provvedimenti e possono essere impugnate davanti agli organi della giustizia tributaria.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA, Sez. II, 19/06/2025 (ud. 10/06/2025), Sentenza n. 4441
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Tributi locali – RIFIUTI – TIA – Competenza – Giurisdizione esclusiva in materia di tariffa riconosciuta al giudice tributario.
La giurisdizione esclusiva in materia di tariffa riconosciuta al giudice tributario dal costante orientamento giurisprudenziale ha fatto emergere: che non vi è reale differenza, nel presupposto e nella disciplina giuridica sostanziale, tra la Tassa rifiuti e TIA, trattandosi comunque di entrate pubblicistiche non negoziali e non sinallagmatiche; che gli atti con cui viene richiesta la TIA al contribuente hanno natura di atti amministrativi impositivi; che tali atti sono impugnabili in commissione tributaria e devono recare un determinato contenuto al fine di consentire l’esercizio da parte del destinatario del diritto alla difesa.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ROMA, Sez. III, 19/06/2025 (ud. 11/06/2024), Sentenza n. 8530
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Tributi locali – RIFIUTI -RegolamentoTARI emanato da “Roma capitale” – Esenzione – Condizioni obiettive di non utilizzabilità (Covid-19).
In merito al regolamento Ta.Ri emanato da “Roma capitale” il cui art. 8, comma 2, lett. e) stabilisce, tra l’altro, che non sono soggetti all’applicazione della tassa alcuni locali e aree scoperte che, per condizioni obiettive di non utilizzabilità (Covid-19), a causa di forza maggiore sono stati impossibilitati a produzione di rifiuti, occorre evidenziare la non applicabilità della normativa quando l’attività esercitata (operante nel settore della ristorazione) – seppur con le limitazioni governative disposte per prevenire la diffusione della pandemia dovuta al Covid-19 – non è completamente cessata, consentendo il suo esercizio con il servizio di asporto e la consegna a domicilio.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ROMA, Sez. XXI, 19/06/2025 (ud. 09/04/2025), Sentenza n. 8512
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – RIFIUTI – TRIBUTI LOCALI – TARI – Termini di sospensione – Prescrizione e decadenza in materia di liquidazione – Controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori.
Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento comportano, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI AGRIGENTO, Sez. I, 19/06/2025 (ud. 17/02/2025), Sentenza n. 1945
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – URBANISTICA E EDILIZIA – Recupero di somme approntate dal Comune creditore per costi di demolizione di abusi edilizi – Giurisdizione.
Il credito relativo all’iscrizione a ruolo avente ad oggetto il recupero di somme approntate dal Comune creditore per costi di demolizione di abusi edilizi non ha natura tributaria. Ne consegue il difetto di giurisdizione in capo al Giudice Tributario adito, in quanto il contenzioso relativo al detto carico esula dalle materie devolute alla giurisdizione tributaria.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA, Sez. XXIX, 17/06/2025 (ud. 25/02/2025), Sentenza n. 1901
RIFIUTI – TRIBUTI LOCALI – Riconoscimento delle agevolazioni TASI – Obbligo di comunicazione.
In materia di TASI, relativamente alla quota di competenza dell’assegnatario di alloggi di E.R.P., occorre evidenziare che gli alloggi in questioni sono assegnati dal Comune che è a conoscenza del nominativo degli assegnatari. Per questo motivo l’assegnatario non è tenuto, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni TASI, ad alcun obbligo dichiarativo in merito alla destinazione degli alloggi in applicazione dell’art. 6 dello statuto del Contribuente.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ROMA, Sez. XIX, 17/06/2025 (ud. 11/06/2025), Sentenza n. 8302
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – TRIBUTI – Illuminazione – Regolamento di Roma Capitale C.I.P – TARIFFA – Determinazione – Canone applicabile alle installazioni.
In applicazione del Regolamento di Roma Capitale il canone applicabile alle installazioni si determina in base alla superficie espositiva autorizzata, tenuto conto del maggior o minore impatto ambientale del mezzo in relazione alla collocazione, alle caratteristiche e con particolare riferimento all’illuminazione.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIA, Sez. XIV, 17/06/2025 (ud. 20/05/2025), Sentenza n. 4368
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Alloggi IACP – TRIBUTI LOCALI – IMU – Esenzione – Art. 2697 cod. civ.
Non tutti gli alloggi IACP possono essere considerati sociali, ma solo quelli per i quali risulta provata, in concreto, la loro natura sociale, scontano l’esenzione dell’imposta. La prova resta sempre a carico del contribuente, secondo gli ordinari criteri previsti dall’art. 2697 cod. civ., fermo restando che non può ritenersi che tale prova l’Istituto non abbia fornito sol perché non abbia prodotto documenti già pacificamente in possesso dell’ente impositore in ragione del peculiare ruolo da questo rivestito nella procedura di assegnazione degli alloggi secondo la disciplina regionale.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI CATANIA, Sez. III, 16/06/2025 (ud. 11/06/2025), Sentenza n. 5203
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – TRIBUTI – IRPEF – Oneri deducibili – Prova.
Una delle cause del mancato riconoscimento delle “spese per interventi di riqualificazione energetica” deriva dalla mancata produzione della documentazione che confermi l’intervento (neppure in sede contenziosa). Tale omessa presentazione non può considerarsi una semplice violazione formale, trattandosi di previsione che ha riflessi sul piano fiscale, essendo stata posta dal legislatore come condizione necessaria per la fruizione del beneficio.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SIRACUSA, Sez. III, 16/06/2025 (ud. 01/04/2025), Sentenza n. 1254
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – TRIBUTI LOCALI – IRES – Calcolo delle variazioni in diminuzione – Reddito d’impresa delle piccole e medie imprese derivanti da investimenti ambientali – Detassazione.
In relazione al calcolo delle variazioni in diminuzione dal reddito d’impresa delle piccole e medie imprese derivanti da investimenti ambientali, la parte ricorrente ha correttamente provveduto a detrarre dal costo dell’investimento effettuato, il costo di una centrale tradizionale, applicando il principio generale, per cui l’investimento ambientale è stato calcolato come maggiore costo sostenuto dall’impresa per l’acquisto del bene con le caratteristiche di tutela ambientale rispetto al minor costo che l’impresa avrebbe sostenuto se, nell’acquisizione del bene stesso, non avesse valutato gli effetti sull’ambiente della propria attività, al netto dei benefici attesi in termini di maggiore produttività e minori costi futuri.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SASSARI, Sez. III, 12/06/2025 (ud. 30/05/2025), Sentenza n. 289
RIFIUTI – TRIBUTI LOCALI – TARI – Vani tassabili (suscettibili a produrre rifiuti urbani) – Costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo – Presupposti.
Si considerano locali tassabili agli effetti della Tari tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l’uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il tributo è dovuto anche se i locali e le aree non sono utilizzati purché risultino predisposti all’uso. I locali si considerano predisposti all’uso se risultano allacciati almeno ad una delle forniture dei servizi pubblici a rete (gas, energia elettrica, acqua) o anche solo parzialmente ammobiliate, arredate od occupate da suppellettili di qualsiasi genere o natura.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLE MARCHE, Sez. II, 11/06/2025 (ud. 20/05/2025), Sentenza n. 507
DIRITTO TRIBUTARIO EUROPEO – Artt. 41, 47, 48, 51 Carta dei Diritti Fondamentali della UE – Norme tributarie interne – Inapplicabilità.
Gli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei Diritti Fondamentali della UE trovano applicazione nell’ambito del diritto dell’Unione Europea soltanto laddove la materia oggetto del giudizio rientri nel perimetro di applicazione del diritto comunitario, ai sensi dell’art. 51 della medesima Carta. Ove la questione dedotta in giudizio attiene esclusivamente all’applicazione di norme tributarie interne e non involge ambiti di attuazione del diritto europeo le suddette disposizioni sono inapplicabili.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI AREZZO, Sez. I, 11/06/2025 (ud. 16/04/2025), Sentenza n. 124
URBANISTICA ED EDILIZIA – Catasto dei fabbricati – Procedura DOCFA – Rendita degli immobili – Funzione di «rendita proposta» – Termine rettifica.
In tema di catasto dei fabbricati l’introduzione della procedura DOCFA consente al dichiarante di proporre la rendita degli immobili. Tale procedura ha lo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto o il suo aggiornamento attribuendo alle dichiarazioni presentate la funzione di «rendita proposta» fino a quando l’ufficio non provveda alla determinazione della rendita definitiva, sicché il termine di un anno assegnato all’Ufficio non ha natura perentoria con conseguente decadenza dell’amministrazione dal potere di rettifica ma meramente ordinatoria.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI UDINE, Sez. III, 10/06/2025 (ud. 04/04/2025), Sentenza n. 115
URBANISTICA ED EDILIZIA – Catasto dei fabbricati – Benefici fiscali – Abitazioni lusso – Rendita – Nozione di superficie utile complessiva.
Al fine di stabilire se un’abitazione è di lusso, e come tale esclusa da detti benefici fiscali, occorre fare riferimento alla nozione di superficie utile complessiva che deve essere determinata escludendo dalla estensione globale riportata nell’atto di acquisto sottoposto all’imposta, quella di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA, Sez. VI, 09/06/2025 (ud. 08/11/2024), Sentenza n. 4241
TRIBUTI – REGISTRO – Avviso di liquidazione – Coobbligati – Pretesa erariale nei confronti della parte venditrice.
A seguito della definitività dell’avviso di liquidazione in capo alla contribuente per mancata impugnazione risulta legittima la pretesa erariale nei confronti della parte venditrice, in qualità di coobbligata solidale per le maggiori imposte di registrazione, dovute in relazione all’atto di compravendita.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL’UMBRIA, Sez. I, 09/06/2025 (ud. 10/04/2025), Sentenza n. 150
TRIBUTI – REGISTRO – Agevolazione per la piccola proprietà contadina – Pertinenze.
Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento.
N.B: PER LE SENTENZE PER ESTESO E ALTRE SENTENZE CONSULTARE LA BANCA DATI DI GIURISPRUDENZA
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIA, Sez. XIII, 12/05/2025 (ud. 08/04/2025), Sentenza n. 3558
TRIBUTI – ACCERTAMENTO – Avviso di accertamento – Inutilizzabilità delle prove – Nullità derivata.
Sussiste la nullità derivata dell’avviso di accertamento per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo e violazione degli artt. 12 e 7-quinquies Statuto, nell’ipotesi in cui la mancata allegazione e notifica del PVC ha inciso sulla possibilità del ricorrente di esperire l’attività difensiva volta a contrastare la pretesa tributaria, contestabile unicamente attraverso la piena conoscenza e disponibilità degli elementi istruttori alla base dell’avviso di accertamento, segnatamente il PVC ed i sui allegati, mai entrati nella sfera di conoscenza, nemmeno per relationem.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1° Napoli, Sez. XIX, 29/04/2025 Sentenza n. 7480
DIRITTO TRIBUTARIO – Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo – Redditi fondiari – Mancati canoni di locazione – Convalida di sfratto per morosità – Intimazione di sfratto per morosità o ingiunzione di pagamento – Necessità.
Ai sensi dell’art. 26, d.P.R. 917/1986), i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento. Nel dettaglio, con riferimento ai redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, l’art. 23, comma 1, d.P.R. 917/1986 prevede che tali redditi, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1° Milano, Sez. XVI, 24/04/2025, Sentenza n. 1876
DIRITTO TRIBUTARIO – Doppia imposizione da parte di due diversi Stati – Principio di tassazione su base mondiale – Credito d’imposta – Artt. 3, 165, d.P.R. n. 917/1986.
L’art. 165, d.P.R. n. 917/1986 consente l’eliminazione della duplice imposizione del medesimo reddito da parte di due diversi Stati, riconoscendo al contribuente la detrazione, dall’imposta netta dovuta in Italia, delle imposte pagate all’estero a titolo definitivo. Il sistema tributario italiano prevede infatti, sulla base dell’art. 3, d.P.R. 917/1986, il principio della tassazione su base mondiale, in forza del quale i soggetti fiscalmente residenti in Italia sono tassati sui redditi ovunque prodotti. Ciò comporta che, qualora il reddito prodotto all’estero dal contribuente residente sia assoggettato a tassazione anche nel paese della fonte, si verifichi un fenomeno di doppia imposizione. Al fine di eliminare tale evidente penalizzazione (in violazione del principio di capacità contributiva), per i soggetti che operano anche all’estero, la normativa sia italiana che convenzionale ha previsto il metodo del credito d’imposta, in base al quale l’imposta pagata all’estero dal contribuente residente è detraibile dall’imposta dovuta sul medesimo reddito nel paese di residenza.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI LECCE, Sez. II, 15/04/2025 (ud. 09/04/2025), Sentenza n. 705
AMBIENTE – CONTRIBUTI – CONSORZIO DI BONIFICA – Debenza del tributo – Prova.
La prova negativa dell’assenza di beneficio e diretto al fondo (circostanza che, di per sé, esclude la debenza del tributo), unito al dato (non dirimente, ma comunque rilevante) relativo all’assenza di prova in ordine agli interventi di bonifica concretamente eseguiti, consentono di ritenere non dovuto il contributo richiesto.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI FOGGIA, Sez. IV, 15/04/2025 (ud. 10/02/2025), Sentenza n. 721
AMBIENTE – CONTRIBUTI – CONSORZIO DI BONIFICA – Efficienza del sistema scolante e dall’equilibrio del regime idraulico – Prova
Gli immobili situati in un territorio dove opera un Consorzio di bonifica ricevono indubbiamente il fondamentale beneficio derivante dall’efficienza del sistema scolante e dall’equilibrio del regime idraulico, beneficio di carattere generale che non interessa le singole proprietà in quanto tali, ma determina condizioni di stabilità del suolo, che vanno a garanzia di un territorio e delle proprietà sullo stesso ubicate. Non è perciò onere del consorzio fornire la prova di avere adempiuto a quanto indicato nel piano di classifica, approvato dalla autorità regionale.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SASSARI, Sez. I, 15/04/2025 (ud. 11/03/2025), Sentenza n. 169
RIFIUTI – Attività effettivamente svolta – TRIBUTI LOCALI – Calcolo della TARI – Onere probatorio.
Ai fini del calcolo della Tari spetta al contribuente dimostrare il tipo di attività effettivamente svolta, producendo, ad esempio, il registro dei beni strumentali: l’assenza di macchinari avrebbe dato la prova che l’attività svolta nei locali non prevedeva la consumazione in loco di caffetteria o bibite.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO, Sez. III, 14/04/2025 (ud. 10/04/2025), Sentenza n. 2468
RIFIUTI – TRIBUTI LOCALI – TARI – Morosità.
Le ragioni del soggetto passivo non possono essere paralizzate dalla circostanza dedotta dall’ente locale, secondo cui il diritto al regime speciale di pagamento della Tari viene meno ove vi sia morosità nel pagamento della tassa predetta, in quanto la facoltà di eccepire la morosità quale condizione di non applicabilità della esenzione non è prevista a livello normativo, né regolamentare.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° Marche, Sez. II, 14/04/2025, Sentenza n. 343
DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianto fotovoltaico – Investimento agevolabile e disciplina degli aiuti – L. 388/2000 (cd. legge Tremonti ambiente).
In materia di agevolazione spettante per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, l’art. 6, comma 15, della legge 388/2000 (cd. legge Tremonti ambiente), letto unitamente alla disciplina degli aiuti di Stato in materia ambientale, contenuta nella comunicazione n. 2008/C 82/01, quantifica l’investimento complessivamente agevolabile considerando: a) i costi d’investimento supplementari o sovraccosti rispetto alla realizzazione di un impianto tradizionale, a cui vengono sottratti, b) i profitti operativi e aggiunti c) i costi operativi attinenti all’impianto, relativi ai primi cinque anni dall’entrata in funzione del medesimo. Dalla lettura delle due disposizioni riportate si evince che i “costi operativi”, idonei ad essere aggiunti al costo dell’investimento iniziale, sono solo quei costi legati all’effettivo utilizzo di un bene strumentale eco-compatibile, che l’impresa non avrebbe sostenuto nell’ipotesi in cui avesse impiegato un bene analogo, ma con una maggiore incidenza sull’ambiente.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI UDINE, Sez. II, 14/04/2025 (ud. 09/04/2025), Sentenza n. 72
TRIBUTI – IRES – Trust opaco – società di fatto.
Secondo quanto espresso nella circolare n. 48/E/2007, nella successiva risoluzione n.425/E/2008 e nella circolare 61/2010 dell’Agenzia delle Entrate, il trust può dirsi opaco quando il trustee ha potere discrezionale circa l’attribuzione dei frutti e a questo suo potere corrisponde la mancanza di un diritto in capo ai beneficiari in ordine all’attribuzione dei frutti. Il trust opaco non determina profili impositivi in capo ai beneficiari. Pertanto, non possono ravvisarsi ragioni per affermare la sussistenza della società di fatto tra le beneficiarie dietro lo schermo del trust fittizio, tenuto conto che, quand’anche a mezzo della costituzione del trust si sia in concreto realizzato un risparmio di imposta, la scelta di operare secondo schemi giuridici leciti rientra nella libera discrezionalità dell’imprenditore.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1°Napoli,Sez. XIX, 29/04/2025 Sentenza n. 7480
DIRITTO TRIBUTARIO -Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo-Redditi fondiari – Mancati canoni di locazione – Convalida di sfratto per morosità -Intimazione di sfratto per morosità o ingiunzione di pagamento – Necessità.
Ai sensi dell’art. 26, d.P.R. 917/1986), i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento. Nel dettaglio, con riferimento ai redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, l’art. 23, comma 1, d.P.R. 917/1986 prevede che tali redditi, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1°Milano,Sez. XVI, 24/04/2025, Sentenza n. 1876
DIRITTO TRIBUTARIO -Doppia imposizioneda parte di due diversi Stati- Principio di tassazione su base mondiale – credito d’imposta -Artt. 3, 165, d.P.R. n. 917/1986.
L’art. 165, d.P.R. n. 917/1986 consente l’eliminazione della duplice imposizione del medesimo reddito da parte di due diversi Stati, riconoscendo al contribuente la detrazione, dall’imposta netta dovuta in Italia, delle imposte pagate all’estero a titolo definitivo. Il sistema tributario italiano prevede infatti, sulla base dell’art. 3, d.P.R. 917/1986, il principio della tassazione su base mondiale, in forza del quale i soggetti fiscalmente residenti in Italia sono tassati sui redditi ovunque prodotti. Ciò comporta che, qualora il reddito prodotto all’estero dal contribuente residente sia assoggettato a tassazione anche nel paese della fonte, si verifichi un fenomeno di doppia imposizione. Al fine di eliminare tale evidente penalizzazione (in violazione del principio di capacità contributiva), per i soggetti che operano anche all’estero, la normativa sia italiana che convenzionale ha previsto il metodo del credito d’imposta, in base al quale l’imposta pagata all’estero dal contribuente residente è detraibile dall’imposta dovuta sul medesimo reddito nel paese di residenza.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI LECCE, Sez. II, 15/04/2025 (ud. 09/04/2025), Sentenza n. 705
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Contributi – Consorzio di bonifica – Prova.
La prova negativa dell’assenza di beneficio e diretto al fondo (circostanza che, di per sé, esclude la debenza del tributo), unito al dato (non dirimente, ma comunque rilevante) relativo all’assenza di prova in ordine agli interventi di bonifica concretamente eseguiti, consentono di ritenere non dovuto il contributo richiesto.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI FOGGIA, Sez. IV, 15/04/2025 (ud. 10/02/2025), Sentenza n. 721
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Contributi – Consorzio di bonifica – Prova.
Gli immobili situati in un territorio dove opera un Consorzio di bonifica ricevono indubbiamente il fondamentale beneficio derivante dall’efficienza del sistema scolante e dall’equilibrio del regime idraulico, beneficio di carattere generale che non interessa le singole proprietà in quanto tali, ma determina condizioni di stabilità del suolo, che vanno a garanzia di un territorio e delle proprietà sullo stesso ubicate. Non è perciò onere del consorzio fornire la prova di avere adempiuto a quanto indicato nel piano di classifica, approvato dalla autorità regionale.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SASSARI, Sez. I, 15/04/2025 (ud. 11/03/2025), Sentenza n. 169
RIFIUTI – TRIBUTI LOCALI – TARI – Prova.
Ai fini del calcolo della Tari spetta al contribuente dimostrare il tipo di attività effettivamente svolta, producendo, ad esempio, il registro dei beni strumentali: l’assenza di macchinari avrebbe dato la prova che l’attività svolta nei locali non prevedeva la consumazione in loco di caffetteria o bibite.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2°Marche,Sez. II, 14/04/2025, Sentenza n. 343
DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianto fotovoltaico – Investimento agevolabile e disciplina degli aiuti – L. 388/2000 (cd. legge Tremonti ambiente).
In materia di agevolazione spettante per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, l’art. 6, comma 15, della legge 388/2000 (cd. legge Tremonti ambiente), letto unitamente alla disciplina degli aiuti di Stato in materia ambientale, contenuta nella comunicazione n. 2008/C 82/01, quantifica l’investimento complessivamente agevolabile considerando: a) i costi d’investimento supplementari o sovraccosti rispetto alla realizzazione di un impianto tradizionale, a cui vengono sottratti, b) i profitti operativi e aggiunti c) i costi operativi attinenti all’impianto, relativi ai primi cinque anni dall’entrata in funzione del medesimo. Dalla lettura delle due disposizioni riportate si evince che i “costi operativi”, idonei ad essere aggiunti al costo dell’investimento iniziale, sono solo quei costi legati all’effettivo utilizzo di un bene strumentale eco-compatibile, che l’impresa non avrebbe sostenuto nell’ipotesi in cui avesse impiegato un bene analogo, ma con una maggiore incidenza sull’ambiente.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO, Sez. III, 14/04/2025 (ud. 10/04/2025), Sentenza n. 2468
RIFIUTI – TRIBUTI LOCALI – TARI – Morosità.
Le ragioni del soggetto passivo non possono essere paralizzate dalla circostanza dedotta dall’ente locale, secondo cui il diritto al regime speciale di pagamento della Tari viene meno ove vi sia morosità nel pagamento della tassa predetta, in quanto la facoltà di eccepire la morosità quale condizione di non applicabilità della esenzione non è prevista a livello normativo, né regolamentare.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO, Sez. II, 14/04/2025 (ud. 26/02/2025), Sentenza n. 2212
RIFIUTI – TRIBUTI LOCALI – TARI – Parcheggi.
Ai fini del calcolo della Tari i parcheggi sono da considerare aree frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttive di rifiuti.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI COSENZA, Sez. VIII, 11/04/2025 (ud. 11/04/2025), Sentenza n. 2743
TRIBUTI LOCALI – IMU – Alloggi IACP – Esenzione.
Gli alloggi di proprietà dell’Ente ricorrente, concessi in locazione, possono – avendone le caratteristiche – beneficiare dell’esenzione Imu in quanto assimilati all’abitazione principale, ai sensi dell’articolo 13, comma 2 lettera b), del DL n. 201/2011.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI AGRIGENTO, Sez. I, 10/04/2025 (ud. 31/03/2025), Sentenza n. 1057
RIFIUTI – TRIBUTI LOCALI – TARI – Immobili rurali.
La ruralità di un immobile non comporta particolari benefici ai fini della TARI se non nei seguenti termini: le utenze non domestiche, nella determinazione della superficie delle quali non si tiene conto di quella parte di esse ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, anche assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, hanno diritto alla esenzione totale del tributo tanto nella quota variabile che in quella fissa.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI RIMINI, Sez. I, 10/04/2025 (ud. 07/04/2025), Sentenza n. 155
RIFIUTI – TRIBUTI LOCALI – TARI – Imballaggi Terziari.
I rifiuti degli imballaggi terziari, nonché quelli degli imballaggi secondari ove non sia attivata la raccolta differenziata, non possono essere assimilati dai Comuni ai rifiuti urbani ed i regolamenti che una tale assimilazione abbiano previsto vanno perciò disapplicati in parte qua dal giudice tributario.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI, Sez. XXIII, 09/04/2025 (ud. 09/04/2025), Sentenza n. 6316
RIFIUTI – TRIBUTI LOCALI – TARI – contraddittorio preventivo.
L’avviso di accertamento relativo alla Tari rientra nell’alveo degli atti esentati dal preventivo contraddittorio in quanto derivanti da un processo di controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dal contribuente, incrociati con quelli in possesso dell’Agenzia delle Entrate.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, Sez. XXI, 07/04/2025 (ud. 17/03/2025), Sentenza n. 914
DETASSAZIONE AMBIENTALE – RIMBORSO – Inammissibilità.
L’omessa presentazione della dichiarazione integrativa da parte della Società per l’anno di competenza rende inammissibile l’istanza di rimborso, poiché essa fa riferimento a imposte liquidate e versate in forza di dichiarazioni dei redditi ormai divenute non più emendabili.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIA, Sez. V, 04/04/2025 (ud. 05/03/2025), Sentenza n. 2788
CREDITO IMPOSTA – BONIFICA AMIANTO – Sanzione.
Nell’ipotesi dell’utilizzo di un credito di imposta per interventi di bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto, credito portato in compensazione poi revocato, è necessario distinguere, al fine dell’irrogazione della sanzione tra, l’inesistenza del credito che corrisponde ad una falsa rappresentazione documentale ( a cui si applica una sanzione dal 100% al 200%), dalla non spettanza dello stesso che è piuttosto legata alla carenza di uno o più presupposti costitutivi richiesti dalla norma ( a cui si applica una sanzione pari al 30% del credito utilizzato).
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SIRACUSA, Sez. III, 04/04/2025 (ud. 04/02/2025), Sentenza n. 752
ATTIVITA’ RICERCA E SVILUPPO – CREDITO D’IMPOSTA – Presupposto.
A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d’imposta nella misura del 25 per cento, elevata al 50 per cento nei casi indicati al comma 6-bis, delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL PIEMONTE, Sez. I, 03/04/2025 (ud. 17/02/2025), Sentenza n. 2743
REGISTRO – AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – Pertinenze.
In tema di agevolazioni tributarie per acquisto prima casa il concetto di pertinenza è fondato sul criterio attuale della destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra, senza che rilevi la qualificazione catastale dell’area che ha esclusivo rilievo formale. Il carattere pertinenziale di un bene rispetto ad altro bene dipende dalla circostanza che la pertinenza sia destinata “a servizio od ornamento (art. 817 cod. civ.) del bene principale” che dipende a sua volta da un fattore oggettivo (strumentalità di un bene rispetto all’altro) e da un fattore soggettivo (la volontà del titolare dei beni di asservire l’uno all’altro).
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO, Sez. III, 02/04/2025 (ud. 20/03/2025), Sentenza n. 2259
DETASSAZIONE AMBIENTALE – DINIEGO RIMBORSO – Decadenza.
Il rimborso dei versamenti diretti di cui all’art. 38 del dpr 602/1973 è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui all’art. 2 comma 8 bis dpr 322/1998.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° Liguria, Sez II, 31/03/2025, Sentenza n. 259
DIRITTO TRIBUTARIO -Imposta di registro – Atti di compravendita – Scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto ed il valore normale del bene – Quotazioni OMI – Art. 51 TUR, d.P.R. n. 131/1986.
In materia di valore da attribuire agli atti di compravendita ai fini dell’imposta di registro, l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla compravendita non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto ed il valore normale del bene quale risultante dalle quotazioni OMI. Infatti, per l’individuazione del valore venale occorre fare sempre riferimento ai criteri stabiliti dall’art. 51 del TUR, d.P.R. n. 131 del 1986, ossia ai trasferimenti a qualsiasi titolo, alle divisioni e alle perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell’atto, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1° Bari, Sez. V, 28/03/2025, Sentenza n. 820
INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Ecotassa – Emissioni biossido di carbonio – Immatricolazione autoveicoli usati acquistati all’estero – Esonero – Limiti – Fenomeno della c.d. “discriminazione alla rovescia” – Principio del “chi inquina paga”.
La ratio dell’imposta ex art. 1, commi da 1042 a 1046-bis, l. n. 145 del 2018, parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi dai veicoli per chilometro, non va individuata nella dissuasione dall’immissione nel territorio nazionale di auto inquinanti provenienti da altri Stati, bensì nell’immatricolazione – quale presupposto indefettibile alla circolazione del mezzo nello Stato – di ulteriori auto di per sé inquinanti, rispetto a quelle già circolanti. Esonerando dall’imposta i veicoli usati acquistati all’estero, ne verrebbe elusa la finalità disincentivante posta a base della norma istitutiva del tributo, potendosi verificare il fenomeno della c.d. “discriminazione alla rovescia” – risultando più convenienti i mezzi esteri in luogo di quelli nazionali – nonché lo stesso principio, di matrice europea, del “chi inquina paga”.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° Campania, Sez. XIII, 27/03/2025 Sentenza n. 2557
DIRITTO TRIBUTARIO – Reati tributari – Qualifica di amministratore “di fatto” – Art. 2639 c.c. – Attività gestoria.
In tema di reati tributari, ai fini dell’attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore “di fatto”, di cui all’art. 2639, comma 1, c.c., non occorre l’esercizio di “tutti” i poteri tipici dell’organo di gestione, ma un’apprezzabile attività gestoria, svolta, cioè, in modo non episodico od occasionale. Si tratta di poteri che devono estrinsecarsi, comunque, nell’esercizio concreto e con un minimo di continuità delle funzioni proprie degli amministratori o di una di esse, coordinata con le altre. Nel caso in cui l’Amministrazione non assolva a tale onere probatorio, la relativa qualifica non può essere attribuita al soggetto accertato.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° Sardegna, Sez. III, 26/03/2025, Sentenza n. 436
DIRITTO TRIBUTARIO – Deducibilità dei costi – Giudizio di inerenza – Antieconomicità dell’operazione.
In materia di indebita deduzione di componenti negativi, in violazione dell’art. 109, comma 5, d.P.R. 917 del 1986, l’opportunità di un costo e la sua eventuale indeducibilità non può essere sindacata dall’Amministrazione finanziaria, in quanto si tratta di scelta che concerne la strategia commerciale ed è, dunque, riservata al giudizio esclusivo dell’imprenditore. Il costo, per poter superare positivamente il giudizio di inerenza e partecipare alla formazione dell’imponibile, deve presentare una relazione con l’attività d’impresa esercitata, anche in un’ottica indiretta, potenziale o in proiezione futura. Laddove l’Amministrazione contesti la deducibilità, deve dimostrare in modo certo e diretto la mancanza di correlazione tra costi e ricavi, nonché l’antieconomicità dell’operazione, che presuppone un’evidente ed inequivoca contrarietà a criteri generalmente seguiti dagli imprenditori dello specifico settore interessato.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1° Bari, Sez. III, 21/03/2025, Sentenza n. 750
RIFIUTI – Discarica – Tutela della salute e dell’ambiente dagli inquinanti organici persistenti – DIRITTO TRIBUTARIO – Infondatezza della pretesa tributaria – Carenza di motivazione – Art. 7, d.lgs. n. 36/2003 – D.M. 27/9/2010 – Reg. CE n. 850/2004.
L’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 36/2003 stabilisce che i rifiuti sono ammessi in discarica esclusivamente se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica secondo quanto stabilito dal decreto, mentre il d.M. 27/9/2010, in conformità con il Regolamento CE n. 850/2004 in materia di tutela della salute e dell’ambiente dagli inquinanti organici persistenti, definisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica e fissa i limiti dei valori necessari per l’ammissibilità in discarica. Conseguentemente, la violazione dei predetti limiti comporta l’assoluta inammissibilità in discarica. Pertanto, non può essere annullato, per infondatezza della pretesa tributaria, un avviso di accertamento che renda palese, in questi termini, la ragione sottostante alla rettifica operata dall’Ufficio.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° Campania, Sez. I, 19/03/2025, Sentenza n. 2336
RIFIUTI – Ecotassa – Metodo c.d. “normalizzato” di calcolo della TARI – Principio “chi inquina paga” – Presunzioni legali.
Il metodo c.d. “normalizzato” di calcolo della TARI è stato ritenuto legittimo dalla Corte di giustizia dell’Unione europea che, nelle pronunce del 24.6.2008 in causa C-188/07 e del 16.7.2009 in causa C254/08, ne ha affermato la conformità al principio “chi inquina paga”, recepito dall’art. 11 della direttiva 75/442. Trattandosi di un metodo presuntivo, esso è soggetto, quale limite imposto dalla Corte di Giustizia, alla discrezionalità delle autorità nazionali, alle quali non è consentito introdurre regimi impositivi i cui fatti costitutivi si fondino su presunzioni legali, che non ammettono prova contraria, ed è legittimo qualora rispetti la condizione di non ingenerare, a carico di fasce di contribuenti, trattamenti irragionevolmente gravosi.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° Lombardia, Sez. XV, 18/03/2025, Sentenza n. 753
DIRITTO TRIBUTARIO – Polizze sottoscritte da una società di capitali che assicurano il Presidente del CdA – Base ACE – Prodotto di investimento.
Le polizze sottoscritte da una società di capitali che vedono come soggetto assicurato il Presidente del CdA, in caso morte, e beneficiaria la società contraente, non sono polizze di puro rischio, ma contengono una componente finanziaria costituita da titoli obbligazionari, immobiliari e azionari che subiscono evidentemente la fluttuazione di mercato. Di talché, sono pienamente assimilabili ad un prodotto di investimento assicurativo da sterilizzare ai fini dell’ACE, poiché tali strumenti permettono, sia pure in via indiretta, un investimento in titoli come previsto dall’art. 1, c 6-bis d.l. 201/2011, in forza del quale la cd. “base ACE” deve essere sterilizzata in misura pari agli investimenti in titoli e valori mobiliari effettuati successivamente al 31 dicembre 2010.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° Piemonte, Sez. II, 13/03/2025, Sentenza n. 206
DIRITTO TRIBUTARIO – Compravendita di immobili – Natura dell’immobile (strumentale vs civile abitazione) – Acquisto prima casa vs acquisto di appartamento ad uso diverso.
Nella compravendita di immobili, il discrimine della tassazione è la natura dell’immobile (strumentale vs civile abitazione) piuttosto che la destinazione dello stesso (acquisto prima casa vs acquisto di appartamento ad uso diverso). Pertanto, se non è trasferito un immobile strumentale, non può essere applicata la norma eccezionale di cui all’art. 1-bis della tariffa allegata al d.P.R. 31 ottobre 1990, n. 347 e (per l’imposta catastale) dell’art. 10, comma 1, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (vendita di beni strumentali per natura). Dovrà, invece applicarsi la norma ordinaria, prevista dall’art. 1 della tariffa e del cpv. dell’art. 10, del citato d.P.R. n. 347/1990.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° Veneto, Sez. I, 11/03/2025, Sentenza n. 132
DIRITTO TRIBUTARIO – Responsabilità del consulente – Culpa in vigilando – Obbligazione tributaria.
Se il contribuente si avvale di un professionista per la presentazione della dichiarazione, dalla quale risultino violazioni delle disposizioni tributarie, il contribuente ha l’onere di provare la propria assenza di colpa. Di conseguenza, il contribuente è chiamato a rispondere per l’illecito asseritamente commesso dal professionista incaricato, ove non dimostri di aver vigilato sullo stesso, nonché sul comportamento fraudolento dal medesimo tenuto, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento, mediante la falsificazione di modelli F24 ovvero di altre modalità di difficile riconoscibilità da parte del mandante. Dunque, l’obbligazione tributaria grava sul soggetto passivo d’imposta, che è tenuto a controllare l’operato del proprio consulente fiscale, atteso che un eventuale comportamento omissivo non esonera il contribuente dalle sanzioni tributarie previste dall’ordinamento giuridico.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1°Macerata, Sez.I, 10/03/2025, Sentenza n. 76
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Rimborso – Addizionale provinciale energia elettrica – Dogane.
Deve essere affermato il diritto della parte ricorrente alla restituzione di quanto dovuto da parte dell’amministrazione resistente (Dogane), senza che costituisca un dirimente ostacolo l’invio dell’istanza di rimborso al soggetto (Provincia) effettivamente percettore dell’importo versato e che solo apparentemente risultava debitore.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° Lazio, Sez. XII, 10/03/2025, Sentenza n. 1556
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Disciplina IMU, riguardante i fabbricati “storici” – Norma agevolativa – Interpretazione restrittiva – Rimborso – Presupposti.
La disciplina IMU, riguardante i fabbricati “storici”, non presenta ambiti di incertezza o difficoltà interpretativa; trattandosi norma agevolativa, essa è soggetta a stretta interpretazione, cosicché è da escludersi la possibilità di estensione ai beni immobili sottoposti a tutela indiretta attraverso la prescrizione di distanze e altre misure dirette ad evitare alterazioni delle condizioni di ambiente e di decoro degli immobili di interesse culturale.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1° Napoli, Sez.XV, 10/03/2025, Sentenza n. 4237
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – IMU – Nozione di abitazione principale – Accertamento della dimora abituale e residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore – Coniuge con residenza anagrafica in diverso comune.
In materia di Imu va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell’immobile ove dimori abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° Lazio, Sez. XI, 09/03/2025, Sentenza n. 1549
RIFIUTI – TARI – Laboratorio vetreria – Rifiuti speciali – Ditta specializzata alla raccolta e smaltimento – Accertamento – Esclusione.
Non è dovuta l’imposta nei locali adibiti ad un laboratorio vetreria se il ricorrente prova che negli stessi sono prodotti rifiuti speciali per i quali lo stesso ha incaricato una ditta specializzata alla raccolta e smaltimento degli stessi. Altra cosa sono i locali adibiti ad uffici e servizi igienici per i quali, non vi è dubbio, deve provvedersi al pagamento della tassa.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1° Vibo Valentia, Sez. I, 07/03/2025, Sentenza n. 262
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – IMU – Cooperative edilizie a proprietà indivisa – I.A.C.P. – Imposta dovuta.
Dal 2013 è stata operata una distinzione tra unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, ed alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, ed è stato stabilito che solo le prime sono esenti dall’IMU, mentre gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, sono rimasti imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1° Salerno, Sez. IX, 07/03/2025, Sentenza n. 1363
RIFIUTI – TARI – Rifiuti speciali, tossici o nocivi – Esclusione dal tributo opera ipso iure.
Le superfici destinate a produrre in modo ordinario rifiuti speciali, tossici o nocivi, non sono imponibili a prescindere dal fatto che l’utente abbia o meno dimostrato di avere adempiuto ad obblighi o adempimenti prescritti per diverse finalità (in particolare tutela ambientale). In questi casi l’esclusione dal tributo opera ipso iure e l’utente non è onerato, come nel caso delle esenzioni, della prova della sussistenza dei presupposti della esclusione.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIAdi 2°Lombardia,Sez. XIX, 07/03/2025, Sentenza n. 661
RIFIUTI – Esenzione dal pagamento della TARI – Limiti.
L’esenzione dal pagamento della Tari non può riguardare le intere aree di vendita in quanto in tali luoghi prevale la presenza umana (clienti e dipendenti) e, quindi, la produzione anche di rifiuti urbani.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1°Catania, Sez.II, 06/03/2025 Sentenza n. 1837
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – IMU – Immobili d’interesse storico Presupposti – Imposta dovuta – Art. 10 del Codice dei Beni Culturali e Ambientali.
Perché un immobile possa essere qualificato di indiscusso interesse storico-architettonico destinato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e, pertanto, ritenuto esente dal tributo IMU, non basta una dichiarazione del proprietario, ma è necessario un decreto emesso secondo le previsioni di cui all’art. 10 del Codice dei Beni Culturali e Ambientali. Nell’ipotesi in cui l’immobile dovesse ricadere in zona centro storico del PRG non può comunque ritenersi esente dal pagamento dell’imposta, non essendo riconducibile neanche al regime di esenzioni di cui agli articoli 10 e 12 del Regolamento IMU.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1° Roma, Sez. XXXV, 05/03/2025 Sentenza n. 2973
RIFIUTI – Denuncia di cessazione – Omissione della presentazione – Accertamento per gli anni successivi a quello in cui tale evento – TARI – Esclusione.
In materia di Tari, anche in caso di omissione della presentazione della denuncia di cessazione nell’anno in cui questa è avvenuta, la tassa non è dovuta per gli anni successivi a quello in cui tale evento si è verificato, qualora: a) l’utente presenti denuncia tardiva di cessazione e fornisca la prova di non aver effettivamente continuato, dalla data indicata, l’occupazione o la detenzione; b) anche a prescindere dalla produzione della denuncia tardiva, risulti che la tassa è stata assolta dal soggetto che è subentrato, a seguito di denuncia o di iscrizione a ruolo d’ufficio a suo carico.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1° Roma, Sez. XXI, 05/03/2025, Sentenza n. 2993
DIRITTO DELL’ENERGIA – Efficientamento energetico – Incentivi indebitamente concessi sulla base di provvedimenti annullati o oggetto di decadenza – Arricchimento a danno di altri – Art. 2033 cod.civ. – IVA – Prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto – Esclusione.
Gli incentivi indebitamente concessi sulla base di provvedimenti annullati o oggetto di decadenza integrano obbligazioni restitutorie, riconducibili alla comune fattispecie di indebito oggettivo e danno luogo al diritto di ripetere quanto pagato ex art. 2033 cod.civ.; tale diritto ha, quale presupposto, che l’incentivo sia stato erogato senza causa e ha una funzione recuperatoria, in quanto tende a evitare l’arricchimento a danno di altri; pertanto, trattandosi di somme corrisposte in mancanza di valido titolo giustificativo, non possono essere ricondotte alla nozione “di pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto” ai sensi dell’art. 40 del testo unico.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1° Savona, Sez. I, 05/03/2025, Sentenza n. 61
DIRITTO URBANISTICO – IMU – Mancanza di abituale dimora nell’immobile – Prima casa – Onere probatorio – Ente impositore.
L’onere di provare la mancanza di abituale dimora nell’immobile per cui si pretende il pagamento del tributo è a carico dell’Ente impositore.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1° Parma, Sez. I, del 04/03/2025, Sentenza n. 93
DIRITTO URBANISTICO – IMU – Le pertinenze in ambito tributario – Esenzione.
Con riguardo alle pertinenze in ambito tributario deve essere respinta la tesi secondo la quale l’elenco di cui alla Tariffa limiterebbe il beneficio alle sole categorie catastali indicate, dovendosi invece ritenere che il legislatore, laddove afferma “sono ricomprese tra le pertinenze…”, evidenzia con chiarezza che per le unità immobiliari di cui alle categorie C/2, C/6 e C/7 una sola unità immobiliare, per ciascuna di dette categorie, può godere dell’agevolazione. La norma non comprende, pertanto, una elencazione esclusiva in quanto il carattere pertinenziale di un bene rispetto ad un altro dipende dalla circostanza che la pertinenza sia destinata “a servizio od ornamento” del “bene principale”, che dipende, a sua volta, sia da un fattore oggettivo, ossia l’obiettivo carattere strumentale di un bene rispetto all’altro, e sia da un fattore soggettivo, e cioè la volontà del titolare dei beni in questioni di “asservire l’uno all’altro.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1°Terni, Sez. II, del 03/03/2025, Sentenza n. 44
RIFIUTI – Qualità di erede e formale rinuncia all’eredità – TARI – Esenzione.
La mancata acquisizione della qualità di erede a seguito di formale rinuncia all’eredità comporta l’esclusione dalla responsabilità per i debiti ereditari. Non può avere, dunque, alcun rilievo quanto dedotto dal Comune in ordine alla circostanza che un soggetto, diverso dal de cuius, abbia abitato nell’immobile per il quale sono state richieste le imposte relative allo smaltimento dei rifiuti urbani.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° Lazio, Sez. II, 03/03/2025 Sentenza n. 1409
RIFIUTI – TARI – Tutela dell’affidamento incolpevole del contribuente – Buona fede del contribuente – Sanzioni tributarie – Esclusione.
In tema di sanzioni tributarie, la tutela dell’affidamento incolpevole del contribuente costituisce espressione di un principio generale dell’ordinamento tributario, sicché deve ritenersi che la situazione di incertezza interpretativa, ingenerata da risoluzioni dell’Amministrazione finanziaria, deve essere valutata ai fini dell’esclusione dell’applicazione delle sanzioni. Pertanto, costituisce situazione tutelabile solo quella caratterizzata: a) da un’apparente legittimità e coerenza dell’attività dell’Amministrazione finanziaria, in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall’assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c) dall’eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2°Lombardia, Sez. XVI, 03/03/2025, Sentenza n. 603
DIRITTO DELL’ENERGIA – Attestato di certificazione energetica – Detrazioni – Opere riqualificazione energetica – Onere a carico del contribuente di trasmettere all’ENEA – Termini.
L’onere a carico del contribuente di trasmettere all’ENEA l’attestato di certificazione energetica, entro i termini normativamente previsti, non costituisce un adempimento necessario per poter usufruire della detrazione, data l’assenza di un’espressa previsione di decadenza e la sua finalità meramente statistica e di monitoraggio/valutazione del risparmio energetico conseguito dal lavoro ultimato.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° Bolzano, Sez. I, 03/03/2025, Sentenza n. 19
DIRITTO DELL’ENERGIA – Produttori di energia da fonti non rinnovabili – Prevenzione dei danni ambientali causati nell’esercizio della propria attività produttiva -Agevolazioni – Tremonti ambiente – Presupposto.
L’agevolazione “Tremonti ambiente” si applica esclusivamente alle imprese per l’acquisto delle immobilizzazioni materiali necessari per prevenire danni ambientali causati nell’esercizio della propria attività produttiva, con esclusione di imprese di produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili, le quali prevengono danni causati da terzi (produttori di energia da fonti non rinnovabili).
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° Sardegna, Sez. II, 28/02/2025, Sentenza n. 334
DIRITTO TRIBUTARIO – Deducibilità dei costi e delle spese dei beni o delle prestazioni di servizio – Azione penale – Determinazione dei redditi – Art. 6, Tuir – l. n. 537/1993 – Artt. 424 e 425 c.p.c. – Art. 157 c.p..
Nella determinazione dei redditi di cui all’art. 6, comma 1, del Tuir, non sono ammessi in deduzione, ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537/1993, i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo, per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale, o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’art. 424 c.p.c., ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 c.p.c., fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall’art. 157 c.p.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° Sardegna, Sez. II, 28/02/2025, Sentenza n. 333
DIRITTO TRIBUTARIO – Rapporto tra giudicato penale e processo tributario – Efficacia del giudicato penale ope legis – ius superveniens – Sentenza definitiva di assoluzione – Legge n. 130/2022 – d.lgs. n. 87/2024 – d.lgs. n. 74/2000.
La sentenza penale irrevocabile di cui all’art. 1, comma 1, lett. m) d.lgs. n. 74/2000 (come modificato dall’art. 21-bis, d.lgs. n. 87/2024, assume efficacia vincolante e opera automaticamente nel processo tributario. In base a tale principio, introdotto dalla Legge n. 130/2022, che ha radicalmente modificato il rapporto tra giudicato penale e processo tributario, la sentenza penale irrevocabile non assume più mera efficacia probatoria, bensì efficacia di giudicato automaticamente rilevabile nel processo tributario. Pertanto, la sentenza definitiva di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, fa stato nel giudizio tributario, con riferimento ai fatti materiali accertati in sede penale.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° Toscana,Sez. III, 27/02/2025 Sentenza n. 255
DIRITTO TRIBUTARIO – Transfer pricing – Vendite a prezzi inferiori al “valore normale” – Prezzi applicati dalla società madre alle consociate – Metodo del full range (intervallo compreso fra il prezzo minimo e il prezzo massimo praticato).
Il fine principale che delle disposizioni sul transfer pricing è quello di evitare che le multinazionali pervengano, attraverso una sovrastima o una sottostima dei prezzi, al trasferimento di porzioni di reddito imponibile in Stati a fiscalità ridotta o in giurisdizioni dove l’impresa multinazionale vanta uno specifico interesse. L’esistenza di vendite a prezzi inferiori al “valore normale”, come definito dall’art. 9 comma 3, d.P.R. n. 917/1986, va valutata con riferimento agli specifici criteri utilizzati nel caso concreto. In specie, i prezzi applicati dalla società madre alle consociate, che vengono utilizzati come riferimento con il metodo del full range (intervallo compreso fra il prezzo minimo e il prezzo massimo praticato), non possono essere ritenuti affidabili in quanto, essendo svincolati dalle quantità, richiederebbero, di volta in volta, una verifica della rappresentatività dei prezzi rispetto alla categoria di prodotti considerata (DCS).
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1° Potenza Sez. II, 26/02/2025, Sentenza n. 142
DIRITTO URBANISTICO – IMU – Pertinenze dell’abitazione principale – Esenzione.
Ai fini Imu, per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Pertanto, è illegittima la pretesa impositiva dell’IMU su un immobile pertinenziale all’abitazione principale, il cui vincolo perdura immutato (durevolezza) fino a quando il ricorrente proprietario mantiene la sua destinazione funzionale al servizio dell’abitazione principale.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° Lazio, Sez. XV, 25/02/2025, Sentenza n. 1230
RIFIUTI – Gestione dei rifiuti speciali assimilabili – Mancata attivazione del servizio – TARI – Esenzione – Onere della prova – Giudice tributario per l’annullamento dell’atto impositivo.
La mancata istituzione o la mancata attivazione del servizio di gestione dei rifiuti speciali assimilabili ed assimilati in una parte o zona del territorio comunale devono essere provate dal contribuente che pretende di avvalersene dinanzi al giudice tributario per l’annullamento dell’atto impositivo, non rilevando che si tratti di “fatti negativi”, potendo la prova essere fornita mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2°puglia,Sez. III, 25/02/2025, Sentenza n. 674
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – IRES -Metodo di calcolo dell’approccio incrementale – Agevolazioni – Immobilizzazioni materiali per prevenire, ridurre e riparare i danni causati all’ambiente.
L’agevolazione prevista dall’art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000, quale applicabile ratione temporis, va richiesta, in assenza di diversa disposizione di legge, per l’intero importo dell’investimento, secondo il metodo di calcolo dell’approccio incrementale, con riferimento all’anno in cui il costo d’acquisto delle relative immobilizzazioni materiali necessarie a prevenire, ridurre e riparare i danni causati all’ambiente è iscritto nello stato patrimoniale.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° Abruzzo, Sez. VI, 25/02/2025, Sentenza n. 93
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Credito d’imposta – Ottenimento dell’agevolazione – Recupero – Requisiti.
Il requisito della novità al fine dell’ottenimento dell’agevolazione prevista dall’art 3 Dl. n. 145 del 2013 si configura non solo in caso di creazione ex novo di un prodotto, ma anche in caso di introduzione di miglioramenti significativi nello stesso, con esclusione delle modifiche di lieve entità o delle attività di routine.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° Campania, Sez. XVIII, 25/02/2025, Sentenza n. 1722
DIRITTO TRIBUTARIO – Sanzioni doganali – Presunzione di colpa e assenza assoluta di colpa – certificato doganale falso – Rilevabilità d’ufficio – Codice doganale comunitario – Reg n. 2913/1992/CEE.
Ai sensi dell’art. 220, par. 2, lett. b), del regolamento CEE del 12 ottobre 1992, n. 2913 (Codice doganale comunitario) e dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, nelle sanzioni tributarie doganali sussiste una presunzione di colpa per l’atto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, lasciando a costui l’onere di provare di aver agito senza colpa, sicché va esclusa la rilevabilità d’ufficio di una presunta carenza dell’elemento soggettivo, sotto il profilo della mancanza assoluta di colpa. Purtuttavia, sussiste l’assenza assoluta di colpa, anche lievissima, nel caso in cui l’importatore utilizzi, per la dichiarazione, i dati presenti in un certificato doganale di accompagnamento della merce falso, formatosi all’estero senza che il contribuente abbia partecipato alla sua formazione e la cui elevata verosimiglianza all’originale abbia indotto in errore la stessa Amministrazione.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1° Cuneo, Sez. I, 25/02/2025, Sentenza n. 18
PROCESSO TRIBUTARIO – Transazione fiscale – Riscossione – Accordo di ristrutturazione dei debiti.
È illegittima e, conseguentemente inefficace, la cartella di pagamento, notificata successivamente alla stipula di una transazione fiscale con ADM, emessa nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti di gruppo, omologato dal tribunale, ai sensi degli artt. 40, 57, 61, 284, co. 2, e 23, co. 2, lettera b), CC.II. Invero, anche quando la transazione fiscale non realizzi un effetto novativo e/o remissorio dell’obbligazione tributaria, è evidente che solo al ricorrere di una causa di risoluzione dell’accordo l’obbligazione tributaria rivive integralmente come originariamente determinata, con conseguente immediato ripristino dell’originaria posizione creditoria erariale. Ne consegue che, nelle more dell’esecuzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, e fino a quando il soggetto passivo esegua puntualmente i versamenti previsti dalla transazione fiscale, non v’è ragione perché il Fisco intimi – con un atto a valenza esecutiva (cartella esattoriale) – l’adempimento di obbligazioni non più esigibili nei termini originari.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° Emilia-Romagna, Sez. X, 25/02/2025, Sentenza n. 151
DIRITTO DELL’ENERGIA – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Direttiva europea – Oli minerali (combustibile per riscaldamento o carburante per motori) – Tassa ambientale – Dir. 96/2003/CE.
Con il d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, è stata attuata la direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro europeo per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. In base alla norma comunitaria sono soggetti ad accisa una serie di prodotti vocati per loro natura all’impiego energetico (gli oli minerali) e un’ulteriore serie di prodotti annoverati tra i prodotti energetici (e quindi sottoposti a tassazione), esclusivamente laddove vengano utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1° Messina, Sez. IX, 24/02/2025 Sentenza n. 1056
RIFIUTI – Titolo dell’occupazione ed effettiva occupazione dell’immobile – TARI – Requisiti – Prova.
Il titolo dell’occupazione, in materia di Tari, assume rilievo secondario a fronte della effettiva occupazione dell’immobile.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° Marche, Sez. I, 24/02/2025 Sentenza n. 190
RIFIUTI – Tari – Tariffe -PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Deliberazione consiliare che differenzia le tariffe degli alberghi rispetto a quella delle famiglie – Giurisprudenza CEDU.
La determinazione delle tariffe TARI non necessita di motivazione. La deliberazione consiliare che differenzia le tariffe degli alberghi rispetto a quella delle famiglie appare legittima. Sul punto la Corte di Giustizia UE, Sez. III, con sentenza 4 marzo 2015 n. 534 ha riconosciuto come legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri è stata distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1°Sassari,Sez. III, 24/02/2025, Sentenza n. 66
RIFIUTI -TARI (quota fissa e parte variabile del prelievo)- Rifiuti di imballaggio – Produzione “continuativa e prevalente” di rifiuti speciali- Codice dell’ambiente.
Le superfici in cui si producono, in via continuativa e prevalente, imballaggi e rifiuti di imballaggio, non sono da assoggettare alla TARI, quantomeno per la parte variabile del prelievo. Nonostante la produzione “continuativa e prevalente” di rifiuti speciali, resta comunque dovuta la quota fissa della Tari, in quanto destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e servizio nell’interesse dell’intera collettività. Inoltre, la quota fissa finanzia anche i costi dei rifiuti esterni, in modo da coprire anche le pubbliche spese afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente.
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. V, del 16/02/2025, Ordinanza n. 3913
DIRITTO URBANISTICO – Immobile collabente -Categoria catastale F/2e interventi edilizi, all’uso abitativo – DIRITTO TRIBUTARIO – Imposte di registro- Agevolazione prima casa.
In materia di agevolazione prima casa, posto che la norma agevolativa non esige l’idoneità abitativa dell’immobile già al momento dell’acquisto, il beneficio può essere riconosciuto anche all’acquirente di immobile collabente, non essendo preclusiva la classificazione del fabbricato in categoria catastale F/2, ed invece rilevando la suscettibilità dell’immobile acquistato ad essere destinato, con i dovuti interventi edilizi, all’uso abitativo.
CORTE DI CASSAZIONE, Sez.V, 12/02/2025, Ordinanza n. 3595
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Enti Locali – Tributi – ICI – Tassazione autonoma delle aree pertinenziali – Art. 817 c.c. – Presupposti.
In tema di ICI, la tassazione autonoma delle aree pertinenziali è esclusa quando il Comune sia venuto a conoscenza di tale vincolo a seguito di apposita comunicazione effettuata dal contribuente. I presupposti di cui all’art. 817 c.c. – a) l’oggettiva destinazione di una cosa a servizio od ornamento di un’altra per volontà del titolare della cosa principale e – b) la durevolezza, ovvero la circostanza che non sia possibile una diversa destinazione del bene senza radicale trasformazione – non sono sufficienti per la relativa detassazione ai fini fiscali, ma occorre anche che l’Amministrazione sia effettivamente consapevole di tale destinazione. Tale consapevolezza, se non emerge da altri fatti conosciuti per altra via dall’Amministrazione, deve risultare da una comunicazione proveniente dal contribuente, senza che quest’ultimo possa invocare la sussistenza del vincolo di pertinenzialità solo in fase di giudizio.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1°Genova,Sez. III, 12/02/2025 Sentenza n. 133
DIRITTO TRIBUTARIO – Cessione di oro industriale – Regime IVA- Reverse change – risoluzione n. 375/2002.
L’art. 3 della l. n. 7/2000 ha previsto che la cessione di oro industriale sia assoggettata al regime IVA del cd. reverse charge. In linea con quanto precisato nella risoluzione n. 375 del 2002, l’imposta è dovuta con tale meccanismo nell’ipotesi in cui la rivendita di beni d’oro usati è finalizzata al processo industriale di fusione e successiva affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso. Tale fattispecie si verifica sia qualora l’attività di lavorazione industriale dei metalli preziosi rappresenti l’attività esclusiva svolta dall’azienda cessionaria, sia qualora l’attività di lavorazione industriale sia strumentale alla produzione di nuovi oggetti d’oro. In sostanza, il fatto che la cessionaria non svolga esclusivamente attività di lavorazione industriale dei metalli non assume, di per sé, rilevanza decisiva per la non applicazione del meccanismo del cd. reverse change.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2°Campania,Sez. VI, 05/02/2025, Sentenza n. 1127
DIRITTO TRIBUTARIO – ENTI LOCALI -Tariffe TARI sulla base del tipo di attività commerciale-Direttiva europea – chi inquina paga – inquinamento sui rifiuti.
Il Comune può determinare le tariffe TARI ai sensi del comma 651 dell’art.1 della legge n.147/2013 e dell’art. 6, d.P.R. n. 158/1999, ovvero sulla base del tipo di attività commerciale (per la parte fissa) e della quantità di rifiuti conferita, utilizzando anche criteri presuntivi (per la parte variabile). Alternativamente a tali criteri, l’ente comunale può quantificare la TARI in forza del successivo comma 652, ovvero, nel rispetto del principio “chi inquina paga” (sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008), può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIAdi 2°Campania,Sez. VII, 04/02/2025 Sentenza n. 1089
DIRITTO TRIBUTARIO – Direttiva europea – Imposta ecapacità contributiva – INQUINAMENTO ACUSTICO – Inquinamento e disinquinamento acustico – Aree prossime agli aeroporti – Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) – D.lgs. n. 13/2005 – direttiva 2002/30/CE.
L’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA), istituita dagli artt. 90-95, l. n. 342/2000, non si pone in contrato con gli artt. 3 e 53 Cost., perché individua gli esercenti di aeromobili quali soggetti passivi dell’imposta e definisce la loro capacità contributiva, intesa quale partecipazione alle spese conseguenti ai danni ambientali derivanti dalle emissioni sonore nelle aree prossime agli aeroporti. L’imposta in esame è finalizzata a promuovere il disinquinamento acustico in relazione al traffico aereo e promuove la tutela dell’ambiente, conformemente a quanto disposto dalla direttiva 2002/30/CE del 26 marzo 2002, (recepita dal d.lgs. n. 13/2005), relativa all’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2°CAMPANIA, Sez. XIX, 31/01/2025 Sentenza n. 948
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione – IRES – Rottamazione-quater – L. n.197/2022 – Piano rateale concordato – Estinzione.
In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ex art. 1, commi 231 – 252 della l. n.197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell’intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione- in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell’Agenzia sul numero, l’ammontare delle rate e le relative scadenze – ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1° Trapani, Sez. II, 31/01/2025, Sentenza n. 113
DIRITTO TRIBUTARIO – Accertamento integrativo – Ne bis in idem – Esercizio dell’autotutela sostitutiva.
Nel caso in cui l’Amministrazione annulli in autotutela un avviso di accertamento per vizi sostanziali, il relativo potere accertativo su quel dato periodo di imposta si è consumato, sicché un nuovo avviso, basato sui medesimi elementi già noti all’Ufficio, è illegittimo e va annullato, per violazione del principio del ne bis in idem di cui all’art 9-bis dello Statuto. L’esercizio dell’autotutela sostitutiva, invero, deve tenere conto del diritto del contribuente di subire una sola azione accertativa da parte dell’Amministrazione Finanziaria per ogni periodo d’imposta.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1° di Pesaro, Sez. II, 31/01/2025, Sentenza n. 36
DIRITTO TRIBUTARIO – Tributi erariali – IRPEF -Autorimesse o posti auto pertinenziali – Deducibilità realizzazione box auto.
L’utilizzo del termine “realizzazione” di cui al comma 1 lettera d) dell’art. 16 bis del TUIR, evidenzia come il legislatore abbia consapevolmente escluso che l’agevolazione fiscale venga riconosciuta alla sola “costruzione” di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, non escludendo che vi rientri l’ipotesi della ristrutturazione e/o creazione di nuovo ambiente tramite modifiche dell’immobile.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° Basilicata, Sez. II, del 30/01/2025,Sentenza n. 26
DIRITTO TRIBUTARIO EUROPEO – Rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare – DIRITTO DELL’ENERGIA – Categorie catastali dei gruppi D ed E – Incentivi per la produzione e l’uso di energie rinnovabili (eolico).
Secondo l’art. 1, comma 21, l. n. 208/2015, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Invero, la ratio della norma è conforme al principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, previsto dall’art. 194, lett. C, TFUE, alle direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE e all’accordo Parigi del 22/04/2016, che, al fine di contenere il surriscaldamento del pianeta, incentivano la produzione e l’uso di energie rinnovabili. In tale contesto normativo, deve essere espunto dal calcolo della rendita catastale tutto ciò che è strumentale e funzionale alla produzione dell’energia eolica, ovvero gli elementi di natura impiantistica, ivi inclusa la torre, che si trova in rapporto esclusivo con la parte dell’impianto deputata in maniera più specifica alla produzione dell’energia elettrica, sfruttando la forza del vento, che, agendo sull’elica, provoca la rotazione del rotore.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1° di Reggio Calabria, Sez. VII del 29/01/2025, Sentenza n. 752
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Accertamento – Bollo auto – Prescrizione.
Il termine prescrizionale applicabile al credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli ha durata triennale, ed inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa ma dall’inizio dell’anno successivo.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1° Roma, Sez. XXIV 28/01/2025, Sentenza n. 1109
RIFIUTI – Aree adibite allo stoccaggio di medicinali (magazzino o deposito) – Tari – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Accertamento – Esenzione – Presupposti.
Non sono assoggettabili al tributo le aree adibite allo stoccaggio di medicinali, ovvero il magazzino destinato alla conservazione o deposito degli stessi, senza che vi siano interventi di lavorazione che possano produrre rifiuti.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1° di Reggio Calabria, Sez. VIII, 28/01/2025, Sentenza n. 702
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Beni immobili inedificabili – IMU – Esclusione.
Il pagamento dell’Imu non può essere richiesto relativamente ai beni immobili inedificabili, nei quali certamente rientrano le aree a rischio idraulico, dove non è consentito eseguire alcun tipo di intervento edilizio.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1° Modena, Sez. I, 28/01/2025, Sentenza n. 38
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Ires – Spese di riqualificazione energetica – Omessa preventiva comunicazione dell’elenco delle spese – Benefici fiscali – Termine.
L’omessa preventiva comunicazione dell’elenco delle spese di riqualificazione energetica, prevista dall’art. 4, del D.M. 19 febbraio 2007, in mancanza di una espressa sanzione di decadenza in caso di ritardo o omissione non può, di per sé, comportare la perdita del beneficio fiscale.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° Campania, Sez. VI, del 28/01/2025 Sentenza n. 899
RIFIUTI – Esclusioni dall’indifferenziata e sottoposizione alla TARI – Circostanze escludenti la produttività e la tassabilità – Denuncia di variazione o originaria – Necessità – Controlli.
Eventuali esclusioni dall’indifferenziata sottoposizione alla TARI non sono mai automatiche; le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità devono essere dedotte “nella denuncia originaria” o in quella “di variazione”, e devono essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o in base a idonea documentazione.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1° Genova, Sez. XXVI, 27/01/2025, Sentenza n. 1063
RIFIUTI – Scarti della lavorazione del legno – ENTE LOCALE – Rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani (assimilati con regolamento comunale) – Accertamento e limiti – Tari – Presupposti.
Gli scarti della lavorazione del legno sono rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani, non potendo trovare applicazione, ratione temporis, le modifiche di cui la D.lgs. 116/2020. In particolare, sia la disposizione che includeva, nei rifiuti urbani, quelli non pericolosi (assimilati con regolamento comunale), sia quella che attribuiva il potere regolamentare all’Ente locale, sono state soppresse soltanto dal citato decreto.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1° Roma, Sez. IX, 27/01/2025, Sentenza n. 998
RIFIUTI – TARI – Atti liquidazione – Indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile – Regolarità.
La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1° Napoli, Sez. XXVIII 27/01/2025, Sentenza n. 1345
RIFIUTI – TARI – Invito al pagamento della tassa rifiuti – Atto autonomamente impugnabile – Giudice tributario – Atti liquidazione – Impugnabilità.
L’invito al pagamento della tassa rifiuti è atto autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario, contenendo una chiara ed inequivoca formulazione della pretesa tributaria per l’anno di riferimento e generando l’interesse del contribuente a contestarne l’an e/o il quantum. A nulla rileva che l’atto impugnato sia una richiesta di pagamento a titolo di acconto, in quanto trattasi, comunque, di atto espressivo della potestà impositiva.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1° Napoli, Sez. XXVIII, del 27/01/2025, Sentenza n. 1345
RIFIUTI – Aree che producono rifiuti speciali in via prevalente – Esclusione dalla TARI – Agevolazione.
Per dimostrare che una data superficie produce rifiuti speciali in via prevalente, con conseguente esclusione dalla TARI, si deve verificare che i rifiuti speciali prodotti superino la metà (siano prevalenti) dei rifiuti presuntivamente prodotti dalla medesima superficie.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° LAZIO, Sez. XII, 27/01/2025 Sentenza n. 495
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – IRES – Piccole e medie imprese – Agevolazioni i cui all’art. 6, l. n. 388/2000 – Investimenti ambientali – Presupposti soggettivi e oggettivi – Tremonti ambiente.
Per poter accedere all’agevolazione di cui all’art. 6, l. n. 388/2000 – prevista per le piccole e medie imprese – è necessaria la sussistenza di presupposti soggettivi e oggettivi. In particolare, con riferimento al requisito soggettivo per classificare una impresa piccola e media, è necessario il possesso dell’indipendenza, sussistente se il capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese. Quanto al requisito oggettivo occorre che l’investimento sia necessario per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente dall’attività dell’impresa che lo realizza.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° Piemonte, Sez. III, 27/01/2025, Sentenza n. 79
DIRITTO TRIBUTARIO – Direttiva europea – Aliquota di accisa ridotta per il gasolio commerciale – Interessi sociali di mobilità ed esigenze di tutela dell’ambiente – Direttiva 96/2003/CE.
L’aliquota di accisa ridotta per il gasolio commerciale utilizzato come propellente per il trasporto “regolare” di passeggeri, prevista dall’art. 24-ter del TUA, non può essere estesa al carburante usato per il servizio di trasporto di persone c.d. atipico, a carattere occasionale, gestito in forma privatistica, quale l’attività di noleggio di autobus con conducente. Invero, l’art. 7 della Direttiva 96/2003/CE, sulla tassazione dei prodotti energetici, non riconosce l’attribuzione del beneficio a qualsiasi tipo di servizio di trasporti, poiché il beneficio in questione risponde sia a interessi sociali inerenti alla mobilità, sia ad esigenze di tutela dell’ambiente.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° PIEMONTE, Sez. III, 27/01/2025, Sentenza n. 78
DIRITTO TRIBUTARIO EUROPEO – Direttiva 2003/96/CE – Accisa ridotta – Gasolio commerciale.
In relazione alla giurisprudenza comunitaria, secondo cui l’art. 7 paragrafo 3, lett. b) della Direttiva 2003/96/CE non osta ad una normativa nazionale – qual è, nella specie, l’art. 24 ter del TUA – che preveda un’aliquota di accisa ridotta per il gasolio commerciale utilizzato come propellente soltanto per il trasporto “regolare” di passeggeri, si ritiene che tale nozione non includa il servizio di trasporto di persone c.d. atipico, a carattere occasionale, gestito in forma privatistica, quale l’attività di noleggio di autobus con conducente.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1° Roma, Sez. II, 24/01/2025, Sentenza n. 61
RIFIUTI – Assenza dei dati catastali dell’immobile oggetto di tassazione – Accertamento ENTE LOCALE – Individuazione di superficie non accatastata – TARI differenza con l’IMU – Presupposti.
Circa la assenza dei dati catastali dell’immobile oggetto di tassazione, si osserva che, differentemente dall’IMU, il tributo TARI prescinde dall’accatastamento dell’immobile e richiede solo la localizzazione della superficie, anche non accatastata, ritenuta, salvo dichiarazione/comunicazione del contribuente, produttiva di rifiuti.
N.B: PER LE SENTENZE PER ESTESO E ALTRE SENTENZE CONSULTARE LA BANCA DATI DI GIURISPRUDENZA
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2°Lazio, Sez. XVIII, 22/01/2025 Sentenza n.428
RIFIUTI – Regolamento Comunale TIA – Soggetti a tariffa – Esclusione – Superfici dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Accertamento – Presupposti.
Il Regolamento Comunale TIA è applicabile, ratione temporis, quando, nel disciplinare la superficie utile, stabiliva che “Non sono soggetti a tariffa, e quindi non si computano, le superfici dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti o che non comportino, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile”.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° Lazio, Sez. XVII, 21/01/2025, Sentenza n. 407
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ENTI LOCALI – IMU – Riduzione per proprietari di beni storico-artistici – Funzione dell’agevolazione.
L’agevolazione per i proprietari di beni storico-artistici riveste una funzione non solo compensativa delle restrizioni e dei vincoli posti alla proprietà privata ma anche di stimolo a compiere opere di conservazione e protezione dell’immobile soggetto al vincolo.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA 2° Lazio, Sez. II, 21/01/2025, Sentenza n. 388
RIFIUTI – Aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative – Accertamento – Tari – Esclusioni.
Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. L’individuazione delle superfici escluse dalla tassazione concerne unicamente le aree scoperte che si caratterizzino per la pertinenza rispetto al locale o all’area principale, purché non operative.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° Lazio, Sez. II, del 21/01/2025 Sentenza n. 388
RIFIUTI – ENTI LOCALI – TARI (zone in cui non è effettuata la raccolta) – Agevolazione – Riduzione in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta.
Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° Campania, Sez. VIII, 20/01/2025 Sentenza n. 619
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – IMU Prima casa – Esenzione per l’abitazione principale – Oneri probatori.
In tema di ICI ed IMU, ai fini dell’esenzione prevista per l’abitazione principale è necessario che, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente, conformemente alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative. La mancanza di consumi delle utenze domestiche, ed in particolare quelli elettrici e idrici, costituiscono prove utilizzabili dai comuni per superare le risultanze anagrafiche, in quanto una presenza sporadica e non costante del contribuente non consente il diritto all’esenzione.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° TOSCANA, Sez. V, 20/01/2025, Sentenza n. 52
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE- ENTI LOCALI – IMU – Fabbricati inagibili o inabitabili per motivi connessi ad una “irregolarità” a livello urbanistico-edilizio, oltre che igienico-sanitario – Esenzione – Esclusione.
In materia di IMU, il legislatore ha previsto esenzioni o riduzioni dell’imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili: se l’immobile è stato dichiarato inagibile per motivi connessi ad una “irregolarità” a livello urbanistico – edilizio, oltre che igienico-sanitario – non è possibile fruire dell’agevolazione.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° Toscana, Sez. III, 20/01/2025, Sentenza n. 43
DIRITTO TRIBUTARIO – Imposta unica sulle scommesse – Libertà di stabilimento – Soggettività passiva.
In tema di soggettività passiva nell’imposta unica sulle scommesse, prevista dall’art. 3, d.lgs. n. 504/98, il centro di trasmissione dati, deputato alla raccolta delle scommesse, non è un semplice “prestatore di servizi transfrontalieri”, in quanto non si limita solo a trasmettere dati al bookmaker, che ha sede all’estero. Invero, gestendo in concreto i locali dove le persone si recano per scommettere ed erogando le vincite, è soggetto passivo del tributo, il cui il presupposto è correlato alla prestazione del servizio che consiste nell’organizzazione del gioco e nella raccolta delle scommesse nel territorio italiano. Sul punto, nei confronti del bookmaker che ha sede all’estero trova giustificazione la restrizione al principio di libera prestazione dei servizi di cui all’art. 56 del TFUE, poiché, in primo luogo, l’imposta in questione non ha natura armonizzata ed inoltre il settore dei giochi d’azzardo con somme in denaro pone dei problemi di tutela dei consumatori, di prevenzione dall’incitamento ad una spesa eccessiva collegata al gioco, di prevenzione di possibili turbative dell’ordine sociale.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1° Reggio nell’Emilia, Sez. II, 20/01/2025, Sentenza n. 18
DIRITTO TRIBUTARIO – Tutela dei crediti erariali -Procedura “velocizzata”-Contraddittorio informato – Prova di resistenza – Fondato pericolo per la riscossione.
Il comma 2 dell’art 6-bis, l. n. 212/200 ha lo scopo di tutelare i crediti erariali “anticipandone”, il più possibile, la riscossione in quelle fattispecie in cui si appalesi un fondato pericolo per la loro riscossione. Purtuttavia, tale procedura “velocizzata”, in luogo di quelle “ordinaria” prevista dal comma 1, è consentita dalla norma solo se emergano dei sintomi del possibile verificarsi dell’evento dannoso, non quando l’evento stesso si sia già verificato. Ne consegue che, non essendo gli atti impugnati preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo (come disciplinato dai commi 1 e 4), gli stessi vanno annullati. Invero, la sola carenza dello svolgimento del contraddittorio informato è sufficiente a che il Giudice possa dichiarare la nullità degli atti impugnati, non essendo più richiesta la c.d. “prova di resistenza”, che l’abrogato art. 5-ter, comma 5, d.lgs. n. 218/1997 prevedeva.
N.B: PER LE SENTENZE PER ESTESO E ALTRE SENTENZE CONSULTARE LA BANCA DATI DI GIURISPRUDENZA
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° Umbria, Sez. II, 15/01/2025, Sentenza n. 21
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Errori di fatto o di diritto commessi nella redazione della dichiarazione – Accertamento – Tremonti ambiente – Rimborso – Art. 38 d.p.r. n. 602/1973.
Il rimborso dei versamenti diretti di cui all’art. 38 del d.p.r. 602 del 1973 è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, a prescindere dai termini e modalità della dichiarazione integrativa. Il contribuente, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° Lazio, Sez. XI, 15/01/2025, Sentenza n. 296
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Agevolazione per prevenire, ridurre e ripianare “danni causati all’ambiente” – Tremonti ambiente – Applicabilità.
Nel definire gli investimenti cui si applica l’agevolazione, come quelli necessari per prevenire, ridurre e ripianare “danni causati all’ambiente”, il legislatore intende fare riferimento ai danni all’ambiente inerenti all’attività dell’impresa investitrice, cioè ai danni causati da tale sua attività.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1° Ascoli Piceno, Sez. II, 14/01/2025, Sentenza n. 3
DIRITTO TRIBUTARIO – Imposte sui redditi – Investimenti ambientali -Tremonti Ambiente – DIRITTO DELL’ENERGIA – Tariffe incentivanti del Conto Energia – Detassazione – Interpretazione restrittiva.
La corretta applicazione del limite del 20% del costo dell’investimento, previsto dall’articolo 9 del D.M. 19 febbraio 2007 e dall’articolo 19 del D.M. 5 luglio 2012, in relazione alla cumulabilità della detassazione fiscale prevista dalla Tremonti Ambiente con le tariffe incentivanti del Conto Energia, comporta che il 20% deve essere calcolato sul valore complessivo della detassazione (ossia alla variazione in diminuzione del reddito imponibile) e non sul risparmio fiscale effettivamente generato dalla detassazione stessa (ossia alla minore imposta risultante).
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1° ROMA, Sez. VII, 09/01/2025 Sentenza n. 429
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Immobili strumentali d’impresa – Enti Locali – Tributi – IMU – Deducibilità dalla base imponibile IRES – Artt. 75, 79 TUIR.
La quota di IMU riferibile agli immobili strumentali d’impresa è integralmente deducibile dalla base imponibile IRES quale costo inerente (art. 75 TUIR). Nella specie, la Corte ha ritenuto illegittimo il mancato riconoscimento, ai fini della determinazione dell’imponibile Ires del costo relativo all’IMU versata dalla società contribuente per gli immobili posseduti nell’esercizio della propria attività d’impresa. Secondo il Collegio, infatti, l’IMU versata dalla contribuente aveva rappresentato un costo senz’altro inerente per la stessa, oltre che certo e determinato, necessario alla produzione dei proventi imponibili, sicché la regola di generale deducibilità degli oneri fiscali dettata dall’art. 99 TUIR doveva trovare applicazione anche con riferimento all’imposizione locale sugli immobili.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° Lombardia, Sez. XVI, 9/01/2025 Sentenza n.353
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – IRES – Agevolazioni volta a incentivare le piccole e medie imprese – Investimenti ambientali – Legge n.388/2000 – Tremonti ambiente – Interpretazione autentica.
L’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge n.388 del 2000 ha introdotto una agevolazione volta ad incentivare le piccole e medie imprese che realizzano investimenti ambientali, per cui la quota di reddito destinata a tali investimenti non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Il dubbio interpretativo, sciolto con una interpretazione autentica, da una successiva norma secondaria emanata dall’amministrazione consente di cumulare le agevolazioni previste dalla Tremonti ambiente con quelle previste dal c.d. conto energia.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1° di Pesaro, Sez.II, 09/01/2025 sentenza n. 429
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Deducibilità Imu – Esercizio dell’attività d’impresa IRES (Imposta sul Reddito delle Società) – Tributi erariale.
In tema di IRES il mancato riconoscimento della deducibilità, ai fini IRES, in sede di computo del reddito complessivo netto, dell’Imu versata dalla società in relazione agli immobili posseduti dalla medesima nell’esercizio della propria attività d’impresa, rappresenta una violazione delle regole fondanti il sistema dell’imposizione sui redditi e, ancor più in generale, dei principi sottesi all’ordinamento tributario nel suo complesso.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° Lazio, Sez. XIII, 08/01/2025, Sentenza n. 99
RIFIUTI – Applicazione della TARI – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Enti Locali – Accertamento – Determinazione.
Il principio fondamentale per l’applicazione della TARI è quello di derivazione comunitaria in base al quale “chi inquina paga”, sebbene i Comuni possono e usano determinare la propria tariffa secondo i criteri già previsti per la TARSU, ossia commisurando la tassa al costo del servizio e alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1° Venezia, Sez. I, 08/01/2025, Sentenza n. 12
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Tributi Enti locali – Accertamento – Notificazione – Dirigente dell’ufficio – Competenza.
Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali, il dirigente dell’ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori e non è prevista tra i requisiti formali dell’avviso di accertamento l’indicazione del funzionario dell’ente locale che ha nominato il messo.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° Campania, Sez. VIII, 08/01/2025, Sentenza n. 243
RIFIUTI – Sospensione Tarsu – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Enti Locali – Accertamento – Termini di prescrizione e decadenza.
Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi comportano la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1° Venezia, Sez. I, 08/01/2025 Sentenza n. 11
RIFIUTI – Tari – Impugnazione – Vizi (omessa impugnazione dell’atto presupposto a quello opposto) – Nuovo e autonomo atto impositivo.
Nel caso di omessa impugnazione dell’atto presupposto a quello opposto, quest’ultimo non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto da cui è sorto il debito.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1° Firenze, Sez. I, 08/01/2025, Sentenza n. 17
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Formazione 4.0 – Agevolazione alle attività di formazione ordinaria o periodica – Ambito di applicazione – SICUREZZA SUL LAVORO – Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Non può riconoscersi l’agevolazione alle attività di formazione ordinaria o periodica che l’impresa organizza per conformarsi alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1° Roma, Sez. XXIX, 08/01/2025, Sentenza n. 319
DIRITTO URBANISTICO – IMU – Catasto – Atto di classamento conseguente a procedura Docfa – Motivazione.
L’atto di classamento conseguente a procedura Docfa, quando è fondato sui medesimi fatti indicati dal contribuente nella proposta di attribuzione della rendita, deve ritenersi sufficientemente motivato con la sola precisazione di unità immobiliare, canone censuario, foglio, particella, subalterno, zona censuaria, categoria, classe, consistenza, rendita.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1° ROMA, Sez. XXV, 07/01/2025 Sentenza n. 271
RIFIUTI – Dichiarazione TARI – Denuncia di variazione – Obbligo – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Esonero – Presupposti – Accertamento Ente Locale.
La dichiarazione Tari è obbligatoria. È onere del contribuente presentare denuncia di variazione in tutti quei casi in cui siano intervenute modifiche nella tassazione. In assenza di siffatta prova non può essere riconosciuto nessun esonero anche alla presenza dei presupposti.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1° ROMA, Sez. VIII, 07/01/2025 Sentenza n. 226
RIFIUTI – Detenzione di locali e aree scoperte – Locatore, conduttore o possessore – Individuazione dell’effettivo obbligato – TARI – Eccezione locazione di durata non superiore ai sei mesi – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Accertamento.
La TARI è dovuta solo dal conduttore dei locali, in quanto, il presupposto, è dato dal possesso o detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti. Il riferimento al concetto di detenzione pone sicure indicazioni sull’effettivo obbligato in caso di locazione dell’immobile, dovendosi individuare nel conduttore, e non nel locatore, il soggetto passivo d’imposta, tranne per che per la sola ipotesi di locazione di durata non superiore ai sei mesi dove obbligato al pagamento del tributo resta il proprietario.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° Lazio, Sez. XV, 07/01/2025, Sentenza n. 35
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Enti del terzo settore – Esenzione IMU e TASI – Utilizzo dell’immobile per lo svolgimento della propria attività di interesse generale – Esenzioni.
L’esenzione IMU e TASI per gli enti del terzo settore opera solo se l’ente utilizza l’immobile per lo svolgimento della propria attività di interesse generale. L’esenzione è esclusa allorquando l’attività svolta, venendo a incidere su un settore produttivo operante alle condizioni di mercato, finisca con l’alterare le regole della libera concorrenza, configurandosi in un vero e proprio aiuto di Stato.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1° ROMA, Sez. XXVII, 07/01/2025, Sentenza n. 117
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Processo tributario – Efficacia sentenza – ICI.
In materia di ICI, la sentenza che ha deciso con efficacia di giudicato relativamente ad alcune annualità, fa stato con riferimento anche ad annualità diverse in relazione a quei fatti che appaiano elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, ma non con riferimento ad elementi variabili.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° CAMPANIA, Sez. I, 03/01/2025 Sentenza n. 65
RIFIUTI – TARI – Gestione di un parcheggio in concessione comunale – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Ente Locale fase sinallagmatica del rapporto con il Comune – Accertamento.
In materia di TARI si è ormai consolidato un orientamento interpretativo secondo cui, premesso che i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti, tale tassa è dovuta anche dal soggetto che occupi o detenga un’area per la gestione di un parcheggio affidatagli dal Comune in concessione, restando del tutto irrilevante l’eventuale attinenza della gestione stessa alla fase sinallagmatica del rapporto con il Comune.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° LAZIO, Sez. IV, 03/01/2025 Sentenza n. 10
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Tributi locali – IMU – Secondo provvedimento in diminuzione – Emanazione di un atto impositivo integralmente sostitutivo del precedente.
In tema di IMU, la modificazione in diminuzione dell’accertamento originario non integra una pretesa tributaria “nuova” e, perciò, non richiede necessariamente l’emanazione di un atto impositivo integralmente sostitutivo del precedente (C. Cass. 14 luglio 2017, n. 17516).
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1° ROMA, Sez. XIX, 03/01/2025 Sentenza n. 71
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Rendita catastale – Classamento di immobili – Attribuzione con procedura DOCFA – Accertamento – Avviso – Obbligo della motivazione.
In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura denominata DOCFA, ed in base ad una stima diretta eseguita dall’ufficio, l’obbligo della motivazione dell’avviso di classamento dell’immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio e della classe conseguentemente attribuita all’immobile, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortemente partecipativa dell’avviso stesso, sono conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente, il quale, quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° SICILIA, Sez. XV, 02/01/2025 Sentenza n. 8.
RIFIUTI – Rifiuti speciali – Imballaggi terziari – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Accertamento – Esenzione dalla Tarsu – Esclusione – Applicazione della disciplina stabilita per i rifiuti speciali.
In tema di imballaggi terziari si applica la disciplina stabilita per i rifiuti speciali e la tassa è esclusa per la sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali. Ciò non comporta, quindi, che tali categorie di rifiuti siano, di per sé, esenti dalla Tarsu, ma che ad esse si applichi la disciplina stabilita per i rifiuti speciali, che è quella dettata dal D.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l’esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° VENETO, Sez. V, 02/01/2025, Sentenza n. 5.
DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti fotovoltaici di grande potenza (parchi fotovoltaici) – DIRITTO TRIBUTARIO – Imposte di registro, ipotecarie e catastali – Accertamento.
Gli impianti fotovoltaici di grande potenza (parchi fotovoltaici), realizzati allo scopo di produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita, vanno considerati, a tutti gli effetti, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, quali beni immobili in quanto la connessione strutturale e funzionale tra il terreno e gli impianti è tale da poterli ritenere sostanzialmente inscindibili, a nulla rilevando che astrattamente sono rimovibili ed installabili in altro luogo.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° LIGURIA, Sez. II, 17/12/2024, Sentenza n. 984
DIRITTO TRIBUTARIO EUROPEO – Grandi impianti di combustione – Ecotassa – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Emissioni inquinanti di anidride solforosa (SO2) e ossidi di azoto (NOx) – Direttiva europea – Principio “chi inquina paga” – Costi dei danni ambientali e riparazione.
Il presupposto di imposta della cd. ecotassa (art. 17, comma 29, l. n 449/2007) sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e ossidi di azoto (NOx) dei grandi impianti di combustione (come definiti dalla direttiva 88/609/CEE e dalla direttiva 2001/80/CE) è l’esercizio di attività industriale che incide sull’ambiente, al fine di proteggere il livello socialmente ottimale o accettabile di inquinamento. Applicando la portata precettiva del principio “chi inquina paga” all’imposta in esame, ne deriva che il gestore dell’impianto, potenzialmente inquinante, sostiene i costi necessari a mettere in atto le misure di controllo dell’inquinamento stabilite dalle autorità. La tassa in oggetto è ragguagliata in parte ai costi dei danni ambientali e relativa riparazione, direttamente nel prezzo di beni, servizi o delle attività che ne sono causa, al fine di accollare gli effetti negativi al soggetto economico che esercita l’attività inquinante, il cui costo, in assenza di compensazioni, ricadrebbe sull’intera collettività.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1° Cuneo, Sez. II, 19/11/2024, Sentenza n. 297
PROCESSO TRIBUTARIO – Avviso di accertamento fondato sugli gli stessi fatti contestati in un procedimento penale – Autotutela facoltativa – Efficacia giudicato penale – Atto definitivo.
Un avviso di accertamento fondato sugli gli stessi fatti contestati in un procedimento penale, definito con sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, pur non rientrando tra i casi tassativi di autotutela obbligatoria (art. 10-quater, l. n. 212/2000), integra un’ipotesi di autotutela facoltativa (art. 10-quinquies, l. n. 212/2000), che deve essere esercitata anche in presenza di un atto definitivo, poiché ricorrono evidenti ragioni di infondatezza, superiori all’interesse pubblico di far prevalere la certezza che un atto tributario diventi definitivo se non impugnato.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° TOSCANA, Sez.II, 06/03/2024 Sentenza n. 307
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Tributi locali – IMU – Contratto leasing – Soggetto passivo – Possessore di diritto dell’immobile.
L’Imu è dovuta dal “possessore di diritto dell’immobile” e, pertanto, tale imposta è sempre a carico del soggetto che risulti titolare dell’immobile al catasto o, meglio, presso la Conservatoria dei registri immobiliari. Di conseguenza, anche se gli accordi che pongono il carico tributario su un soggetto diverso dal proprietario, o titolare di altro diritto reale, non possono essere contra legem, le imposte locali sugli immobili devono essere pagate dal proprietario ove non sia possibile ottenere il pagamento da parte del diverso soggetto individuato contrattualmente. Nel caso di specie, relativo a un contratto di leasing, in seguito alla risoluzione del contratto è il locatore, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore, a dover versare l’imposta.
N.B: PER LE SENTENZE PER ESTESO E ALTRE SENTENZE CONSULTARE LA BANCA DATI DI GIURISPRUDENZA
____________
* Prof.ssa Claudia Fava, Aggregato di Diritto tributario presso l’Università della Calabria
** Prof. Michele Mauro, Associato di Diritto tributario presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro
*** Dott. Giuseppe Farcomeni, Dottorando di ricerca in Diritto tributario presso l’Università degli Studi di Messina
Note sull’osservatorio:
LA FISCALITA’ DEGLI ENTI LOCALI
Obiettivo della sezione dedicata alla “fiscalità degli enti minori”, nell’ambito dell’osservatorio, è quello di monitorare la giurisprudenza relativa ai tributi di pertinenza degli Enti locali.
Come è noto, la legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n.3, ha riformato il titolo V della Costituzione definendo, anche in materia tributaria, il riparto di competenze tra Stato, Regioni, Province, Comuni e città metropolitane.
In particolare, l’art. 117 della Costituzione attribuisce potere legislativo allo Stato e alle Regioni e potere regolamentare a Comuni, Province e Città metropolitane; il successivo art. 119 prevede che Regioni ed Enti locali abbiano autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci e dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.
Dal punto di vista fiscale, è previsto che Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane abbiano risorse autonome e stabiliscano ed applichino tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, partecipando anche al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio.
La responsabilizzazione delle autonomie locali, per quanto concerne le entrate fiscali, risale alla L. n. 142 del 1990 (Ordinamento delle autonomie locali), che ha dato inizio al processo di riduzione dei trasferimenti statali agli Enti locali.
In conformità ai principi introdotti dalla legge n. 142/1990, con il D.lgs. n. 504 del 1992 il Governo, ridisegnando l’assetto istituzionale delle autonomie locali, ha previsto l’introduzione dell’imposta comunale sugli immobili, l’imposta provinciale sull’erogazione del gas e dell’energia elettrica, il tributo provinciale per l’esercizio di tutela, protezione e igiene ambientale, l’imposta provinciale per l’iscrizione dei veicoli al pubblico registro automobilistico. Inoltre, è stata modificata l’imposta comunale sulla pubblicità, i diritti comunali sulle pubbliche affissioni, la tassa comunale e provinciale per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (quest’ultima oggetto di numerose successive modifiche).
L’art. 54 della legge 142/1990, ha stabilito, altresì, che ai Comuni e alle Province fosse riconosciuta autonomia finanziaria sulle risorse trasferite e su quelle proprie, riconoscendo la necessaria potestà impositiva nell’ambito di imposte, tasse e tariffe.
Successivamente, il D.lgs. n. 446/ 1997, con il primo comma dell’art. 52, è intervenuto stabilendo che gli Enti locali minori “possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi …”. La previsione riguardante la finanza locale è stata poi trasfusa nell’art. 149 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL).
Il processo di autonomia finanziaria ha trovato il suo culmine nella richiamata modifica del Titolo V della Costituzione e nella scelta di decentramento secondo cui ciascun livello di governo deve disporre di risorse finanziarie sufficienti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di competenza.
La riforma costituzionale è rimasta, come noto, incompleta. La Corte Costituzionale (sentenza 37/2004), in assenza della legge statale di coordinamento della finanza pubblica, ha giudicato inammissibile la potestà normativa regionale in materia tributaria.
A distanza di otto anni dalla riforma costituzionale, il Parlamento, con la legge n.42/2009, ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi recanti la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Alla legge delega hanno fatto seguito i decreti delegati per le Regioni a statuto ordinario e per le province (d.lgs. n. 68/2011) e per i Comuni (d.lgs. n. 23/2011).
Per quanto riguarda le Regioni, esse potranno finanziare le proprie spese attraverso: tributi propri istituiti e regolati con legge regionale, relativamente a presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello stato; tributi propri derivati, istituiti e regolati da legge statale e il cui gettito è attribuito alle Regioni; addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali.
Per quanto riguarda Comuni e Province, le entrate tributaria consistono in: tributi propri istituiti dallo Stato, che ne stabilisce gli elementi fondamentali; tributi propri derivati, istituiti dalle Regioni, relativamente ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dallo Stato; tributi propri di scopo; compartecipazioni al gettito di altri tributi; imposizione immobiliare; fondi perequativi.
Per quanto riguarda la disciplina attuativa, il d.lgs. n. 23/2011 ha confermato la potestà regolamentare degli enti locali. Il decreto denominato “Decreto in materia di federalismo fiscale municipale”, ha introdotto nuovi tributi locali, modificando quelli esistenti, e contemplando i seguenti tributi derivati: l’IMU, la cedolare secca sugli affitti, l’imposta di scopo, l’imposta di soggiorno, ecc.
OSSERVATORIO DIRITTO TRIBUTARIO
AGEVOLAZIONI E ESENZIONI
Le esenzioni sono riconducibili a disposizioni che sottraggono, dall’applicazione di un tributo, parzialmente o totalmente, fattispecie che vi rientrerebbero in base alla nozione generale del presupposto.
Le esenzioni possono essere temporanee o permanenti; possono avere carattere soggettivo ovvero oggettivo. Per esempio una esenzione soggettiva è l’esenzione dall’IMU degli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, ecc; una esenzione oggettiva, sempre ai fini IMU, riguarda i terreni agricoli ricadenti in determinate aree (montane).
L’agevolazione, invece, riduce il quantum dell’imposta, in deroga a quanto disposto dalla norma ordinaria. Per individuare un’agevolazione occorre, prima di tutto, rintracciare il regime fiscale di riferimento e, successivamente, distinguere, tra le disposizioni di favore, quelle che hanno natura agevolativa.
Gli strumenti tecnici con cui può essere attuata una agevolazione sono diversi: tassazione parziale della base imponibile, deduzioni dalla base imponibile, detrazioni dall’imposta, riduzioni di aliquote, regimi di differimento o sospensione dell’imposta, regimi sostitutivi, crediti d’imposta, ecc.
Le esenzioni e le agevolazioni possono costituire “Aiuti di Stato”, ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’UE. Occorre pertanto, anche a questo fine, distinguere fra trattamenti fiscali ordinari e trattamenti di favore. A volte il legislatore esenta una fattispecie da un’imposta perché prevede l’applicazione di un’altra imposta. Ad esempio vi sono alcuni proventi che sono esenti dalle ordinarie imposte sul reddito, ma sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’imposta. Le esenzioni, pertanto, possono consistere sia nell’esonero da qualsivoglia imposta, quanto nell’applicazione di un’imposta diversa; solo se l’imposta sostitutiva comporta un minore onere economico per il contribuente se ne può affermare la natura agevolativa.
Per individuare le fattispecie esenti si possono utilizzare due criteri; quello logico, in base al quale sono da considerare esenzioni tutti i casi che sono in “deroga” rispetto alla norma che definisce il presupposto (indipendentemente dalla terminologia usata); quello nominalistico, in base al quale sono considerate esenzioni quelle che il legislatore qualifica come tali, anche se non sono in rapporto di deroga o di eccezione rispetto alla fattispecie generale.
Infine, non bisogna confondere le esenzioni e le agevolazioni dalle esclusioni che, invece, sono disposizioni con cui il legislatore chiarisce i limiti di applicabilità del tributo, senza derogare a quanto disposto dagli enunciati generali.
OSSERVATORIO DIRITTO TRIBUTARIO
TRIBUTI ERARIALI STATALI
Le entrate tributarie erariali sono indicate nel bilancio dello Stato al titolo I e sono così suddivise: Imposte sul patrimonio e sul reddito; Tasse e imposte sugli affari; Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane; Monopoli; Lotto, lotterie e altre attività di gioco.
Per le imposte sul reddito, il quadro normativo di riferimento è costituito dal T.U. delle imposte sui redditi approvato con d.p.r. 22 dic. 1986 nr. 917, che è stato oggetto di varie modifiche e comprende la disciplina dell’IRPEF e dell’IRES
Le imposte indirette si suddividono in Imposte sui consumi (Monopoli fiscali del tabacco, Lotto e giochi, Imposte di fabbricazione, Dazi doganali, Imposte automobilistiche e, più importante di tutte, l’Imposta sul valore aggiunto) e in Imposte sui trasferimenti, le quali a loro volta si suddividono in Imposte sui trasferimenti a titolo oneroso (Imposta di registro, Imposte di bollo, Imposte ipotecarie e catastali) e in Imposte sui trasferimenti a titolo gratuito (donazioni e successioni).
Una menzione a parte meritano l’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) e l’IMU, il cui gettito è devoluto, rispettivamente, alle Regioni e agli Enti locali.
OSSERVATORIO SULLA FISCALITÀ AMBIENTALE
DIRITTO EUROPEO
Durante il Consiglio Europeo di Parigi del 1972, i partecipanti hanno per la prima volta affermato la volontà di realizzare una politica ambientale comunitaria da affiancare all’espansione economica, richiedendo contestualmente un programma d’azione. “L’Atto unico europeo del 1987 ha introdotto il nuovo titolo “Ambiente”, che ha costituito la prima base giuridica per una politica ambientale comune finalizzata a salvaguardare la qualità dell’ambiente, proteggere la salute umana e garantire un uso razionale delle risorse naturali.
L’impegno dell’Unione europea verso il perseguimento di una politica ambientale è stato ulteriormente rafforzato durante successive revisioni dei Trattati. L’ambiente, infatti, è entrato nei settori ufficiali dell’Unione Europea con il Trattato di Maastricht del 1993 e dal 1999 (Trattato di Amsterdam); con il Trattato di Lisbona, assieme al raggiungimento di uno sviluppo sostenibile, “combattere i cambiamenti climatici” è diventato un obiettivo specifico.
La politica ambientale è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”. Questi appena elencati sono principi, non regole: si è posto quindi il problema di come renderli cogenti. In Italia l’art.191 è stato recepito dall’art.3-ter del Codice dell’ambiente (d.lgs.152/2006) che annovera i quattro principi de quibus e richiama l’art.174 del Trattato dell’Unione Europea come riferimento normativo.
Lo scopo del principio di prevenzione è quello di evitare i danni ambientali. Il principio di precauzione è quello foriero di maggiori dinamiche applicative; esso si inserisce, prima ancora che tra gli strumenti del diritto dell’ambiente, tra gli strumenti di controllo del rischio in diritto amministrativo. Il problema del controllo giuridico del rischio generato dalle attività umane è infatti trasversale a tutte le discipline giuridiche (si pensi al diritto amministrativo, al diritto penale, ma anche al diritto civile nell’ambito della responsabilità civile); Il principio di precauzione riguarda sempre situazioni di danno potenziali e si pone quale strumento per colmare le informazioni scientifiche incerte e la responsabilità politica. Il principio “chi inquina paga” è l’unico che apparentemente si sgancia da una logica meramente preventiva (che comunque mantiene, quanto meno in termini di dissuasione), perché presenta un contenuto ripristinatorio, in quanto si riferisce a misure economiche che hanno come scopo quello di individuare preventivamente i soggetti su cui graverà successivamente l’onere economico del contrasto all’inquinamento ambientale. Secondo alcuni è anche il fondamento delle tasse di scopo (e cioè di misure tributarie che introducono tributi volti a disincentivare determinati comportamenti ritenuti inquinanti). Tale principio impone a chi inquina di sostenere il costo ambientale e sociale delle proprie azioni ed è quindi un tentativo di rimediare ai costi esternalizzati sostenuti, in assenza di questo principio, dalla comunità invece che dai soggetti inquinanti. Infatti, Il principio “chi inquina paga” mira a superare tali problemi richiedendo agli inquinatori di “internalizzare” il costo del potenziale inquinamento nel processo di produzione (costi incorporati), di modo da evitare alla società di sostenere i costi successivi. Questo principio è usato in diverse direttive, quali: rifiuti, discariche, acque e responsabilità ambientale.
Infine, il principio dello sviluppo sostenibile, pur non essendo elencato nella norma del Trattato, rappresenta, in realtà, il fondamento del diritto ambientale dell’Unione Europea, perché esprime la doverosità e il vincolo posto in capo alle generazioni attuali a garanzia di quelle future. È un principio che è stato affermato (anche se formalizzato come obiettivo politico dal Trattato di Lisbona) da convenzioni e trattati internazionali addirittura anteriori rispetto al Trattato Europeo.
La definizione di imposta ambientale, condivisa da tutti gli stati membri Ue, è data dalla “Guida statistica alle tasse ambientali” della Commissione Europea. Quest’ultima afferma che un’imposta ambientale è “un’imposta la cui base imponibile sia un’unità fisica (o una approssimazione della stessa) di qualcosa che abbia un impatto negativo, specifico e provato scientificamente, sull’ambiente. Lo scopo di queste imposte è quello di impattare, tramite la distorsione, “sui costi di produzione e i prezzi d’acquisto dei prodotti inquinanti”; mira ad “internalizzare” le esternalità negative generate dalle attività inquinanti.
Ciò può avvenire in diversi modi.
In primo luogo incidendo sulle scelte dei consumatori attraverso l’incremento del prezzo finale, nel caso in cui i produttori scarichino il peso dell’imposta sui consumatori, il che potrebbe verificarsi in presenza di bassa elasticità della domanda al prezzo o di prodotti perfetti sostituti, in perfetta concorrenza realizzati e con tecnologie simili. In secondo luogo incidendo sulle scelte di produzione degli inquinatori, ove la loro struttura di costo si modifichi a seguito dell’imposta (qualora non venisse scaricato l’onere dell’imposta sui prezzi). Ciò potrebbe verificarsi in presenza di domanda fortemente elastica al prezzo, o di produttori che, seppur in concorrenza perfetta e perfetti sostituti tra loro, presentino tecnologie produttive diverse che comportano diversi livelli di compensazione dell’inquinamento prodotto, come ad esempio due produttori di acqua minerale di cui uno produce bottigliette in plastica riciclata e l’altro no. Questo strumento è dunque applicazione diretta del principio “chi inquina paga”. Sotto il profilo teorico, in particolare, si è applicato al problema delle esternalità ambientali un celebre tipo di imposta: l’imposta à la Pigou (o imposta pigouviana, dal noto economista inglese Arthur C. Pigou). Si tratta di un’imposta che grava su ogni unità di output prodotta da chi inquina, per un (l’aliquota è determinata dall’) ammontare pari al danno marginale inflitto in corrispondenza del livello socialmente efficiente di output. Il risultato è una traslazione della curva del beneficio marginale dell’inquinatore verso il basso, fino al punto in cui il costo marginale è pari al beneficio marginale (punto d’efficienza). Il valore di questa imposta è costituito dal prezzo del danno marginale in corrispondenza di quest’ultimo. Il gettito creato può essere distribuito in somma fissa all’intera popolazione o agli individui che subiscono l’esternalità, o ancora può consentire di ridurre il carico fiscale in altri settori. La distorsione avviene quindi grazie al fatto che l’obiettivo dell’inquinatore è la sola massimizzazione della propria utilità marginale. Nonostante questo tipo di tassazione non fosse all’inizio particolarmente popolare, con gli anni ha acquisito il favore degli economisti e dei governi (si veda la carbon tax o la plastic tax, classificabili come imposte pigouviane). La tassazione ambientale è in generale divisibile (almeno a livello europeo) in quattro ambiti di intervento: l’energia, i trasporti, l’inquinamento e le risorse. Il primo riguarda i materiali energetici (tra cui emissioni di anidride carbonica) usati per carburazione e combustione ed è l’ambito che di solito pesa maggiormente sul gettito della maggior parte degli stati, per lo meno di quelli europei. La categoria dei trasporti comprende non i carburanti (rientranti invece nel primo ambito), bensì la registrazione e l’utilizzo dei mezzi di trasporto privato e pubblico. Il terzo ambito, quello dell’inquinamento, esclude l’emissione dei materiali energetici (non include ad esempio emissioni di anidride carbonica), ma riguarda le altre emissioni che inquinino aria e acqua, oltre che rumore e rifiuti solidi. L’ultimo ambito concerne i permessi per l’estrazione di beni naturali.
N.B: PER LE SENTENZE PER ESTESO E ALTRE SENTENZE CONSULTARE LA BANCA DATI DI GIURISPRUDENZA





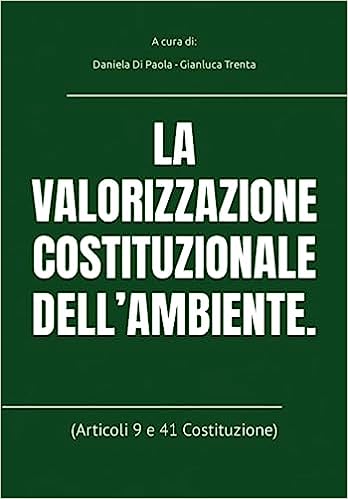
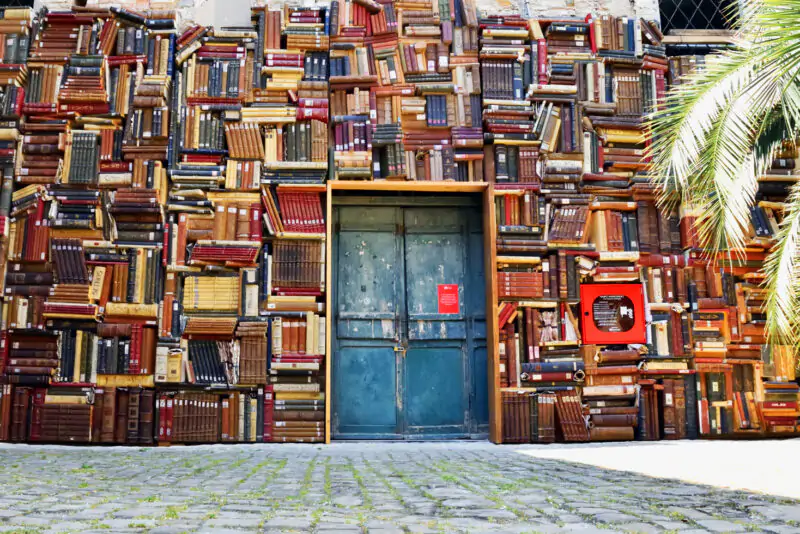 AMBIENTEDIRITTO.IT Casa Editrice
AMBIENTEDIRITTO.IT Casa Editrice