Pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata in Italia: all’alba della nuova politica comune della pesca le “ferrettare” sono state finalmente regolarizzate?
ENRICO MURTULA*
La politica italiana in materia di pesca marina è generalmente censurata per la sua illegalità diffusa e i suoi impatti sugli ecosistemi. Si citano al riguardo la condanna ricevuta dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nell’ottobre 2009 (causa C-294/08), l’inserimento nella lista nera che gli Stati Uniti redigono sulla base del Magnuson-Stevens Fishery Conservation and Management Act (confermato nel gennaio 2011), nonché i numerosi dossier di denuncia delle associazioni ambientaliste (LAV, Legambiente, Marevivo; WWF; Oceana).
Uno dei pomi della discordia è rappresentato dall’utilizzo delle reti derivanti. Tali reti sono composte da una linea superficiale sorretta da galleggianti e da una linea inferiore zavorrata; non sono ancorate, ma vengono affidate alle correnti marine. Tali strumenti, poco selettivi, comportano un grandissimo numero di morti “accidentali” tra specie ittiche non commerciabili, cetacei, tartarughe e squali (sul tema si cita S. Nespor, Patrimonio ittico naturale, sulla decisione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sez. III, 5 marzo 2009, causa C-556/07, relativa al caso delle “thonaille” francesi, in Rivista Giuridica dell’Ambiente, 5/2009, pag. 686).
Le disposizioni comunitarie in materia ne hanno fortemente limitato l’utilizzo sin dal 1992, imponendo una lunghezza massima di 2,5 chilometri e il loro divieto nella pesca di alcune specie, quali il tonno rosso e il pesce spada (Regolamenti CEE 345/1992 e CE 1239/98).
In Italia sono tutt’oggi utilizzate le reti derivanti denominate “ferrettare”, che, a seguito dell’entrata in vigore della regolamentazione comunitaria (per la situazione antecedente si veda T. Scovazzi, La pesca con reti derivanti nel Mediterraneo, in Rivista Giuridica dell’Ambiente, 1992, pag. 523), hanno formato dei decreti ministeriali del 14 ottobre 1998 (che ne ha limitato l’uso a 3 miglia dalla costa), del 24 maggio 2006 (che ne aveva ripristinato l’uso fino a 10 miglia) e 8 maggio 2008 (che aveva ampliato l’uso a 18 miglia limitatamente all’Isola di Ponza, ma che è stato revocato sin dal 2009 oltre ad essere stato censurato dal T.A.R. Lazio con la sentenza n. 12549/2009). Il tema della distanza ha una rilevanza diretta ai fini del controllo sulle specie che sono effettivamente pescate: maggiore è la distanza dalla costa e più complicati sono i controlli.
Molte le voci (già citate all’inizio di questa nota) che hanno criticato il mancato rispetto della normativa comunitaria nella gestione delle ferrettare, a causa di norme inadeguate in materia di controlli (solo con il decreto legge n. 59 dell’8 aprile 2008 sono state introdotte sanzioni per la detenzione degli strumenti di pesca illegali), sanzioni economiche irrisorie rispetto al valore del pescato e la mancanza di verifiche sull’utilizzo dei contributi comunitari elargiti per riconversioni spesso non avvenute (E. Murtula, Contributi per la riconversione, detenzione di reti derivanti (ir)responsabilità erariale e perdurante illegalità della pesca italiana, in Rivista Giuridica dell’Ambiente, 2/2011, pag. 309).
Taluni, peraltro, hanno segnalato che tra le perduranti carenze regolamentari nazionali vi è quella che consente di attribuire ai pescherecci – anche nel caso di previe violazioni delle norme – contestuali licenze per l’uso di più strumenti di pesca, rendendo di fatto impossibile la verifica su quale degli strumenti sia stato effettivamente utilizzato.
All’inizio di quest’anno la Commissione Europea ha dichiarato di voler agire contro l’Italia per l’adempimento della sentenza della Corte di Giustizia del 2009, in forza dell’articolo 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. A tale annuncio ha fatto seguito il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf) in data 1° luglio 2011, con il quale “i titolari delle unità di pesca abilitate in licenza all’utilizzo dei sistemi “ferrettara” e “palangari” sono obbligati, nello svolgimento dell’attività di pesca, ad utilizzare uno solo dei suddetti attrezzi”.
Nei confronti di tale decreto hanno proposto ricorso al T.A.R. Lazio il Comune di Ponza e numerose associazioni di pescatori, che hanno dapprima ottenuto un decreto cautelare e quindi un’ordinanza di sospensione (r.g. n. 6843/2011; decreto n. 2957 in data 3 agosto; ordinanza n. 3247 in data 7 settembre 2011).
Il Ministero, tuttavia, ha deciso di operare in modo anche più radicale, abrogando il precedente decreto in data 24 maggio 2006. Con il decreto ministeriale in data 21 settembre 2011 è stato posto a 3 miglia dalla costa il limite per l’uso delle ferrettare e le maglie delle reti sono state ridotte da 18 a 10 centimetri.
Tale intervento in extremis non ha fermato la Commissione Europea, che il 29 settembre 2011 ha dato all’Italia un termine di 60 giorni per dimostrare il proprio adempimento, sotto pena di un nuovo giudizio per stabilire una penalità economica nei confronti del nostro Paese.
Nel frattempo è lo stesso quadro di riferimento comunitario che sta mutando.
Da un lato, ci si appresta alla piena entrata in vigore della nuova normativa comunitaria di controllo (Regolamento CE n. 1224/2009; Regolamento di Esecuzione UE n. 404/2011), a regime dal 1° gennaio 2012. Tali norme, tra l’altro, prevedono un sistema “a punti” per sanzionare le irregolarità degli operatori della pesca e un sistema più chiaro di tracciabilità dei prodotti ittici.
D’altro lato, il 13 luglio 2011 la Commissione Europea ha presentato la propria proposta di Direttiva sulla nuova Politica Comune della Pesca (COM 2011 425 def.), il cui articolo 2 (Obiettivi generali) afferma che tale politica applica applica alla gestione della pesca “l’approccio precauzionale ed è volta a garantire, entro il 2015, che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile”, nonché “l’approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che le attività di pesca abbiano un impatto limitato sugli ecosistemi marini“. E’ previsto che la Direttiva sia adottata entro la fine del 2011.
Per un’analisi delle prospettive nazionali di questo settore, si segnala la dettagliata analisi di impatto che accompagna la proposta di Direttiva (rinvenibile sul sito http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_en.htm), in quanto una delle quattro zone geografiche considerate è la Sicilia. Rispetto ad essa, l’analisi stima gli impatti ambientali, economici ed occupazionali dello status quo e delle ipotesi politiche in considerazione, rilevando in tutti gli scenari un calo dell’occupazione, pur accompagnato da un incremento nel valore economico del lavoro residuo.
* Avvocato in Milano
Sulla procedura di valutazione di impatto ambientale: la rilevanza della fase di informazione e partecipazione pubblica in una recente sentenza della Corte Costituzionale
MATTEO CERUTI*
1. Con la sentenza n. 227 depositata lo scorso 22 luglio 2011 la Corte Costituzionale, nel decidere il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri contro alcune disposizioni della “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2010” della Regione Friuli Venezia Giulia, ha affrontato, tra gli altri, il tema della disciplina della fase dell’informazione e partecipazione pubblica alla valutazione di impatto ambientale (si vedano i paragrafi 6, 6.1. e 6.2 della parte in diritto).
La norma censurata dal Governo1 disponeva che il proponente del progetto e dello studio di impatto ambientale, entro cinque giorni dal ricevimento di una comunicazione (da parte della struttura regionale competente per la VIA della richiesta di parere sul progetto e sullo studio di impatto ambientale alle autorità interessate), era tenuto a far pubblicare sul quotidiano locale maggiormente diffuso nell’ambito provinciale interessato, l’annuncio della presentazione del progetto ai fini della VIA, e quindi doveva dar notizia dell’avvenuta pubblicazione alla struttura regionale competente e alle autorità interessate; e contestualmente alla pubblicazione dell’avviso, la documentazione presentata veniva messa a disposizione del pubblico, anche mediante pubblicazione nel sito web della Regione, per un periodo di sessanta giorni, affinché chiunque ne possa prendere visione.
Per l’Alta Corte una simile disciplina risulta difforme da quella stabilita dall’art. 23, comma 1, del Codice dell’ambiente di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, il quale impone, invece, che all’istanza presentata sia già allegata copia dell’avviso a mezzo stampa, che dev’essere pubblicato a cura del proponente contestualmente alla presentazione del progetto.
2. La sentenza risulta espressiva di una giurisprudenza del Giudice costituzionale particolarmente attenta nel riconoscere al legislatore statale la competenza esclusiva nella materia della valutazione di impatto ambientale.
Invero, con la stessa decisione (al precedente paragrafo 5 della parte in diritto), nel dichiarare incostituzionale una previsione recante un ulteriore difformità della disciplina regionale del Friuli V.G. rispetto alla normativa statale relativamente ai contenuti della domanda di compatibilità ambientale2, la Corte ribadisce quanto affermato nelle precedenti sentenze n. 186 del 2010 e n. 234 del 2009, ossia che la normativa sulla valutazione d’impatto ambientale attiene alle procedure che accertano la sostenibilità ambientale degli interventi e che rientrano quindi nella materia della “tutela dell’ambiente” di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Per cui, pur in presenza di ambiti materiali di spettanza regionale, deve ritenersi prevalente il titolo di legittimazione dello Stato, proprio in ragione della precipua funzione cui assolve il procedimento in esame.
In tale contesto le Regioni – anche quelle ad autonomia speciale laddove, come nel caso del Friuli V.G., lo statuto non contempli la tutela dell’ambiente tra le materie specificatamente attribuite alla competenza regionale – sono dunque tenute a mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal Codice dell’ambiente e a rispettare i “livelli uniformi di tutela” apprestati in materia dallo stesso d.lgs. 152/2006.
3. Quel che preme maggiormente evidenziare è però l’estrema attenzione dedicata dai Giudici costituzionali alla fase dell’informazione/partecipazione pubblica alla procedura di VIA, e quindi il particolare rigore con cui è stata valutata una deviazione anche minima della legislazione regionale rispetto al paradigma procedimentale statale.
Per pervenire alla declaratoria di illegittimità costituzionale è stata infatti ritenuta sufficiente la mera ritardata pubblicazione dell’avviso sulla stampa rispetto alla presentazione della domanda di VIA, senza che da ciò conseguisse una compressione dei termini – di sessanta giorni- per consultare la documentazione e per presentare osservazioni, (termini infatti che comunque, secondo la norma caducata, scattavano solo dal momento del predetto annuncio pubblico).
Una difformità quest’ultima che – secondo la Corte – andava comunque censurata in quanto “non determinando una miglior tutela ambientale, ed anzi ritardando la pubblica conoscenza del procedimento iniziato, è suscettibile di ritardare per ciò stesso la possibilità di partecipazione e decisione informata del procedimento medesimo e, quindi, di tutelare con minore efficacia il bene dell’ecosistema, a presidio del quale il legislatore statale, nell’ambito della propria competenza, ha dettato la menzionata disciplina”.
4. Le conclusioni cui è pervenuto in questo caso il Giudice costituzionale non possono non avere conseguenze su quell’orientamento della giurisprudenza amministrativa che ha sinora giudicato con tolleranza (talvolta estrema) le carenze ed omissioni nelle misure di pubblicità preliminare e di partecipazione dei cittadini alle procedure di VIA, anche in conseguenza di difformità delle legislazioni regionali rispetto alla disciplina statale.
A tale ultimo proposito non si può omettere di menzionare la sentenza3 del TAR Friuli V.G. n. 112 del 12 marzo 2009 con cui il Giudice amministrativo ebbe occasione di dichiarare manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale relativi al testo originario della legge regionale 43/1990 disciplinante un complesso sub-procedimento di informazione e partecipazione pubblica recante più di una significativa deviazione dalla normativa statale:
– sia in relazione alla pubblicità preventiva, giacché la pubblicazione dell’annuncio sulla stampa non forniva informazioni in ordine agli uffici pubblici in cui era disponibile per la consultazione lo studio di impatto, né alle modalità ed ai termini per la visione degli atti e a quelli per la presentazione di osservazioni, che erano invece contenute in un provvedimento regionale di cui era prevista esclusivamente la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale (e non sui giornali);
– sia in ordine alla consultazione dello studio di impatto, per la quale veniva previsto un termine di 15 giorni (dalla predetta pubblicazione sul BUR);
– sia con riferimento alla fase della presentazione delle osservazioni, limitata temporalmente a 20 giorni, e circoscritta al “pubblico interessato” individuato dal direttore del servizio regionale sulla VIA con apposito provvedimento, emesso su espressa istanza da presentare entro termini perentori di 10 giorni dall’annuncio sulla stampa, e dal quale risultavano esclusi i cittadini che non fossero residenti nei comuni interessati e non avessero “un interesse inerente alla realizzazione dell’opera”.
Dunque, con la sentenza n. 227/2011 la scure dell’Alta Corte è (in qualche modo, paradossalmente) calata su una legge regionale con cui s’era tentato, in fondo, di porre rimedio alla testè ricordata normativa giuliana sulla VIA recante evidenti compressioni alle facoltà informative e partecipative dei cittadini.
E tuttavia – val la pena di ricordare che – nell’occasione il TAR ritenne che la previsione delle suddette difformità rispetto alla disciplina statale risultavano consentite dallo Statuto di autonomia del Friuli V.G. e, comunque, non potevano ritenersi una diminuzione delle garanzie partecipative; aggiungendo altresì come la circostanza che la materia “ambiente” ormai rientri nella competenza legislativa esclusiva dello Stato “non è incompatibile con un intervento di dettaglio della Regione negli ambiti che le sono propri”; precisando infine che in ogni caso le questioni poste in ordine alla procedura di VIA attenevano più propriamente all’accesso alle informazioni ambientali e dunque non “alla materia ambiente, bensì a quella dell’accesso ai documenti, le cui disposizioni non risultano violate”.
Tutte conclusioni che meritano una rimeditazione alla luce dei principi posti ora dal Giudice delle leggi.
* Avvocato in Rovigo
1 Si tratta dell’art. 115, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 17 del 2010, sostitutivo dell’art. 14 della leg. reg. n. 43 del 1990, relativo alla pubblicità del progetto e dello studio di impatto ambientale.
2 Si trattava della previsione contenuta anch’essa nella richiamata “legge di manutenzione dell’ordinamento regionale” modificativa della leg. reg. 43/1990 la quale disponeva che il soggetto proponente presentasse alla struttura regionale competente in materia di VIA il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale senza tuttavia prevedere, che all’istanza fosse «altresì allegato l’elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’opera o intervento», come invece imposto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006.
3 Citata anche nel commento all’art. 24 del d.lgs. 152/2006 contenuto nel “Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia” (a cura di R. Ferrara e G. F. Ferrari).
4 La legge regionale 43/1990 prevedeva in particolare che:
– contestualmente alla presentazione della domanda di VIA con l’allegato studio di impatto ambientale, il proponente provveda a pubblicare un annuncio su un quotidiano locale (art. 10);
– quindi associazioni, comitati e cittadini che siano però residenti nei comuni interessati ed “abbiano un interesse inerente alla realizzazione dell’opera” sono tenuti a presentare istanza all’Amministrazione regionale entro 10 giorni dalla pubblicazione del predetto annuncio di inclusione nel “pubblico interessato” (art. 13, comma 2);
– a questo punto con provvedimento del direttore del Servizio regionale VIA, pubblicato sul BUR, viene individuato il “pubblico interessato” all’opera proposta tra i gruppi associativi ed i singoli cittadini che ne abbiano presentato istanza (oltre che le autorità interessate) (art. 13);
– contestualmente alla pubblicazione sul BUR del predetto provvedimento di individuazione del pubblico interessato l’Amministrazione provvede a depositare presso i competenti uffici regionali e comunali copia dello studio di impatto “per la durata di 15 giorni consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione” e di inviare ad associazioni e comitati (non ai singoli cittadini) inclusi tra il “pubblico interessato” copia dello studio medesimo (art. 14, comma 1);
– e quindi “fino alla scadenza del termine perentorio di 20 giorni dalla pubblicazione” sul BUR del provvedimento di individuazione del pubblico interessato “possono essere presentate al Servizio per la valutazione dell’impatto ambientale osservazioni, istanze, pareri da parte del pubblico interessato” (art. 16, comma 1).
La Cassazione torna sulla legittimazione delle associazioni ambientaliste al risarcimento dei danni non patrimoniali per i reati ambientali
LUCA PRATI*
La Cassazione è recentemente tornata sulla legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste per il risarcimento del danno ambientale.
Come noto, la riforma del danno ambientale operata dal D.Lgs. 152/2006 ha riservato allo Stato l’azione per il risarcimento del danno ambientale, abrogando anche le previsioni che autorizzavano le associazioni ambientaliste a proporre, in caso di inerzia degli Enti territoriali, le azioni risarcitorie per danno ambientale (art. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, abrogato dall’art. 318 del D.Lgs. n. 152/2006).
Con la sentenza Cass. Pen. Sez. III, 26/09/2011 (Ud. 21/06/2011) n. 34761, il Supremo collegio ha affermato come il danno risarcibile secondo la disciplina civilistica possa sempre configurarsi anche “sub specie del pregiudizio arrecato all’attività concretamente svolta dall’associazione ambientalista per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo”.
Ha riaffermato la Corte, come già fatto in passato, che la normativa speciale del “danno ambientale” ex articoli 311 e 313, 7° comma, del D.Lgs. n. 152/2006 si affianchi alla disciplina generale del danno posta dal codice civile, sicché le associazioni ambientaliste – pure dopo l’abrogazione delle previsioni di legge che le autorizzavano a proporre le azioni risarcitorie per danno ambientale sostituendosi all’Ente – sono legittimate alla costituzione di parte civile “iure proprio”, nel processo per reati che abbiano cagionato pregiudizi all’ambiente. Ciò tuttavia non per ottenere il risarcimento del danno all’ambiente come interesse pubblico (riservato al Ministero dell’Ambiente), bensì dei danni direttamente subiti, specifici, ulteriori e diversi rispetto a quello, generico di natura pubblica, della lesione dell’ambiente come bene pubblico.
Un tale danno sussisterebbe, ad esempio, nel caso in cui l’associazione ambientalista, radicata in un ben preciso contesto storico e territoriale, abbia sostenuto delle spese per l’attività di tutela ambientale resasi necessaria in connessione al compimento di fatti causativi di danno ambientale.
Ritiene però la Cassazione nella sentenza che si commenta che la possibilità di risarcimento in favore dell’associazione ambientalista non sia limitata all’ambito patrimoniale di cui all’art. 2043 c.c., posto che ogni reato, che abbia cagionato un danno anche non patrimoniale, obbliga il colpevole al risarcimento nei confronti del soggetto passivo del reato stesso e di chiunque possa ritenersi “danneggiato” per avere riportato un pregiudizio (patrimoniale o non patrimoniale) causalmente riconducibile all’azione od omissione del colpevole.
Sebbene condivisibile sul piano teorico, la legittimazione degli enti associativi al risarcimento di danni non patrimoniali connessi a reati ambientali, distinti ed ulteriori dal danno ambientale, lascia aperte numerose perplessità circa il rischio concreto che si verifichino duplicazioni delle voci risarcitorie, non necessariamente connesse alla plurioffensività delle condotte pregiudizievoli dell’ambiente.
Si tratta, forse, di un nuovo adombramento del “danno esistenziale da illecito ambientale” già più di una volta prospettato, più o meno implicitamente, dalla giurisprudenza, materia che costituisce un terreno scivolosissimo.
* Avvocato in Milano
I nuovi ecoreati
GIULIA GAVAGNIN*
Il D. Lgs. n. 121/2011 “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni” costituisce un piccolo passo verso l’armonizzazione della tutela penale nazionale dell’ambiente con i principi stabiliti dalla normativa comunitaria in questa materia.
L’ostacolo a una piena e completa armonizzazione è, di fatto, costituito dalla tecnica di incriminazione adottata dal legislatore italiano, che ha attribuito natura contravvenzionale alle violazioni ambientali ritenute di penale rilevanza, con l’eccezione della fattispecie delittuosa di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, prevista e punita dall’art. 260 del D. Lgs. n. 152/06.
I reati ambientali del nostro ordinamento, fatta salva la menzionata eccezione dell’art. 260 D. Lgs. n. 152/06, si presentano infatti come reati di pericolo astratto puniti indifferentemente a titolo di dolo o di colpa. Hanno queste caratteristiche anche i due nuovi “ecoreati” introdotti dal D. Lgs. n. 121/2011 nel codice penale, rispettivamente, agli articoli 727 bis e 733 bis.
Il primo è volto a tutelare le specie animali e vegetali protette.
Al primo comma, punisce chiunque, fuori dai casi consentiti e salvo che il fatto costituisca più grave reato, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo che l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Al secondo comma punisce, alle stesse condizioni del primo ma con la sola ammenda fino a 4.000 euro, chiunque distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale protetta.
L’inserimento di questa contravvenzione all’interno del codice penale realizza soltanto in parte gli obiettivi della Direttiva 2008/99/CE, che impone di punire solo le condotte intenzionali o gravemente negligenti (art. 3 della Direttiva) e “con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive” (art. 5 della Direttiva). La punibilità a indifferente titolo di dolo o di colpa e la facile oblazionabilità della contravvenzione diminuiscono il disvalore della condotta e non contribuiscono a disincentivarla in misura sufficiente.
La seconda fattispecie contravvenzionale, prevista dal nuovo articolo 733 bis c.p. punisce con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.
Il legislatore italiano ha qui probabilmente colto la vaghezza del dettato comunitario, che richiedeva un “deterioramento significativo”: nel rapportare, invece, il deterioramento allo stato di conservazione dell’habitat, ha evitato le più ovvie censure di legittimità costituzionale.
Tuttavia, una scelta più coerente con il dettato della Direttiva 2008/99/CE avrebbe dovuto comportare una revisione della tecnica di incriminazione, sanzionando condotte produttive di evento (il danno all’ambiente). In questo caso però sarebbe stata necessaria la dimostrazione dell’esistenza del nesso di causalità tra condotta e evento, certamente tenuto conto della natura “trasversale” del bene giuridico ambiente: l’aggressione dei beni ambientali è spesso cumulativa, cioè determinata da condotte imputabili a diversi soggetti con difficoltà di individuazione della condotta effettivamente lesiva.
Va detto, a questo proposito, che anche nel diritto ambientale tedesco, che presenta astrattamente diversi gradi di offesa al bene giuridico (reati di danno, di pericolo concreto, e di pericolo astratto), vista la difficoltà di accertare concretamente il nesso di causalità in materia ambientale, la giurisprudenza è intervenuta applicando le fattispecie di danno indipendentemente dall’accertamento dello stesso ed accogliendo così il modello di pericolo astratto.
I due nuovi “ecoreati”, pertanto, si inseriscono coerentemente nel contesto del diritto penale ambientale nazionale, ma lasciano immutati i forti dubbi da tempo espressi in dottrina sull’opportunità di mantenere fattispecie contravvenzionali, la cui effettività è minata essenzialmente dalla possibilità di richiedere l’oblazione e dalla patologica lentezza del processo penale italiano che favorisce grandemente il maturare dei termini di prescrizione.
* Avvocato in Venezia
Accordi tra comuni ed università per la redazione di uno strumento urbanistico e tutela della concorrenza
RUGGERO TUMBIOLO*
Il Consiglio di Stato1 ha recentemente sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione interpretativa pregiudiziale: «Se la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 31.3.2004, n. 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed in particolare l’articolo 1, n. 2 lettere a) e d), l’articolo 2, l’articolo 28 e l’allegato II categorie n. 8 e n. 12 ostino ad una disciplina nazionale che consente la stipulazione di accordi in forma scritta tra due amministrazioni aggiudicatrici per lo studio e la consulenza tecnico scientifica finalizzata alla redazione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio comunale così come individuati dalla normativa nazionale e regionale di settore verso un corrispettivo la cui non remuneratività non è manifesta, ove l’amministrazione esecutrice possa rivestire la qualità di operatore economico».
Il punto dirimente della controversia ruota intorno alla conformità all’ordinamento comunitario di un incarico di studio e consulenza tecnico-scientifica finalizzata alla redazione di uno strumento urbanistico generale, affidato in via diretta da un Comune ad un istituto universitario.
Occorre premettere che avanti alla Corte di Giustizia pende un’altra domanda di pronuncia pregiudiziale, che concerne questione se non simile quantomeno connessa: «Se la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 31.3.2004, n. 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed in particolare l’articolo 1, n. 2 lettere a) e d), l’articolo 2, l’articolo 28 e l’allegato II categorie n. 8 e n. 12 ostino ad una disciplina nazionale che consente la stipulazione di accordi in forma scritta tra due amministrazioni aggiudicatrici per lo studio e la valutazione della vulnerabilità sismica di strutture ospedaliere da eseguirsi alla luce delle normative nazionali in materia di sicurezza delle strutture ed in particolare degli edifici strategici, verso un corrispettivo non superiore ai costi sostenuti per l’esecuzione della prestazione, ove l’amministrazione esecutrice possa rivestire la qualità di operatore economico»2.
Sul punto controverso si registrano già alcuni precedenti in giurisprudenza.
Il TAR Lombardia si è già pronunciato in due occasioni3, ritenendo che l’affidamento da parte di un Comune in favore di un istituto universitario di un incarico di studio e consulenza tecnico-scientifica per la redazione di uno strumento urbanistico sia legittimo, in quanto riconducibile ad un accordo tra enti pubblici espressamente ammesso dall’art. 15 della legge n. 241 del 1990 e comunque rispettoso del diritto comunitario, che consente alle amministrazioni aggiudicatrici, in alternativa allo svolgimento di una procedura di evidenza pubblica di scelta del contraente, di stipulare un accordo a titolo oneroso con altra amministrazione pubblica cui affidare il servizio.
Entrambe le decisione del TAR lombardo sono state appellate avanti al Consiglio di Stato, il quale si è inizialmente pronunciato a favore della conformità dell’accordo all’ordinamento comunitario4 e successivamente, con l’ordinanza richiamata all’inizio di questo commento5, ha sollevato la questione pregiudiziale avanti alla Corte di Giustizia UE.
L’altra domanda di pronuncia pregiudiziale attualmente pendente avanti alla Corte di Giustizia è stata proposta dal Consiglio di Stato6 nel giudizio di appello di alcune decisioni del TAR Puglia7, che avevano, viceversa, ritenuto illegittimo l’affidamento da parte di un’azienda sanitaria locale ad una università dell’incarico per lo studio e la valutazione di vulnerabilità sismica delle strutture ospedaliere ricadenti nel territorio provinciale, omettendo il ricorso a procedure di evidenza pubblica.
Esaminando le ragioni del rinvio alla Corte di Giustizia, secondo il Consiglio di Stato il ricorso al partenariato pubblico-pubblico può profilare il pericolo di contrasto con i principi di concorrenza quando l’amministrazione con cui sia concluso un accordo di collaborazione possa rivestire al tempo stesso la qualità di operatore economico, qualità che dalla Corte di Giustizia è riconosciuta ad ogni ente pubblico che offra servizi sul mercato, indipendentemente dal perseguimento di uno scopo di lucro, dalla dotazione di una organizzazione di impresa o dalla presenza continua sul mercato.
Sembrerebbe, poi, non decisiva, per i giudici di Palazzo Spada, la circostanza che il corrispettivo previsto per l’esecuzione della prestazione non abbia, in ipotesi, carattere remunerativo, servendo essenzialmente a ripianare i costi sostenuti dall’università: la fissazione di un corrispettivo, pur nell’assenza di un sostanziale profitto, non vale a conferire gratuità all’accordo che rimane a titolo oneroso e che, sotto tale profilo, potrebbe rientrare nel campo di applicazione della disciplina comunitaria degli appalti.
Entrambi i profili di dubbio di contrasto con il diritto comunitario si prestano, tuttavia, ad alcuni rilievi.
L’accezione amplificata della nozione di «operatore economico», in modo da ricomprendervi anche gli istituti universitari, è volta a consentire a detti organismi di diritto pubblico di concorrere, al pari delle imprese private, nelle pubbliche gare, ma non sembra diretta ad escludere che gli stessi possano concludere con altre pubbliche amministrazioni accordi diretti per il perseguimento di fini di interesse comune.
Del resto, un’autorità pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti senza essere obbligata a far ricorso ad enti esterni non appartenenti ai propri servizi e può farlo altresì in collaborazione con altre autorità pubbliche8, come nel nostro ordinamento è espressamente consentito dall’art. 15 della legge n. 241 del 1990.
E giova rammentare che la norma appena citata non prevede l’identità delle competenze, ma solamente lo svolgimento di attività di interesse comune; non avrebbe, infatti, senso richiedere una perfetta sovrapposizione di competenze per potere concludere un accordo ex art. 15 della legge n. 241 del 1990, ma pare sufficiente che una attività sia complementare e sinergica ad un’altra di competenza di altra amministrazione9.
Nella fattispecie che ha dato luogo al rinvio alla Corte di Giustizia questa complementarietà e sinergia tra le funzioni delle pubbliche amministrazioni sembra non contestabile, posto che l’ente universitario espleta i propri compiti istituzionali di ricerca e consulenza (specificatamente indicati negli artt. 66 del d.P.R. n. 382 del 1980 e 6 della legge n. 168 del 1989) propedeutici all’espletamento da parte dell’ente locale della funzione di pianificazione territoriale.
Né può richiamarsi il timore che un’interpretazione restrittiva della nozione di «operatore economico» possa sottrarre alle regole della concorrenza i contratti conclusi tra amministrazioni aggiudicatrici ed organismi che non agiscono in base a preminente scopo di lucro, posto che nella fattispecie si tratta di un accordo che coinvolge unicamente amministrazioni aggiudicatrici.
Non senza dimenticare che, da una parte, il diritto comunitario non impone alle autorità pubbliche di ricorrere ad una particolare forma giuridica per assicurare in comune le loro funzioni di servizio pubblico, dall’altra, una cooperazione del genere tra autorità pubbliche non può rimettere in questione la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza, poiché viene salvaguardato il principio della parità di trattamento degli interessati, cosicché nessuna impresa privata viene posta in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti10.
Quanto all’aspetto della remunerazione, non pare decisa la circostanza della onerosità della prestazione ai fini della riconducibilità della fattispecie al campo di applicazione della disciplina comunitaria degli appalti.
La Corte di Giustizia ha osservato che la semplice esistenza, fra due enti pubblici, di un meccanismo di finanziamento riguardante servizi di tal genere non implica che le prestazioni di servizi in questione rappresentino un’aggiudicazione di appalti pubblici che debba essere esaminata alla luce delle norme fondamentali del Trattato11.
Del resto, la possibilità per le università di ottenere una remunerazione e non un semplice rimborso spese, è espressamente prevista dall’articolo 7, comma 1, lett. c), della legge 168 del 1989, che include, tra le entrate degli atenei, anche i corrispettivi di contratti e convenzioni, nonché dall’articolo 66 del d.P.R. n. 382 del 1980, che prevede una rigorosa ripartizione dei proventi derivanti dall’attività di ricerca e consulenza espletata in favore di enti pubblici e privati.
Ciò che rileva è la compatibilità delle suddette attività con lo svolgimento della funzione scientifica e didattica, perché si deve pur sempre trattare di contratti/convenzioni consoni ai fini istituzionali dell’Ente; l’attività di ricerca e consulenza, anche se in favore di enti pubblici, deve infatti essere strumentale alle finalità istituzionali dell’Ente, che sono la ricerca e l’insegnamento, nel senso che giova al progresso della ricerca e dell’insegnamento o procaccia risorse economiche da destinare a ricerca e insegnamento12.
* Avvocato in Como
———————–
Note:
1 Ordinanza della V Sezione n. 5207 del 16 settembre 2011.
2 Procedimento n. C-159/11 proposto dal Consiglio di Stato, con ordinanza della V Sezione n. 966 del 15 febbraio 2011.
3 TAR Lombardia, Milano, I Sezione, 10 gennaio 2010, n. 74 e 22 aprile 2010, n. 1123.
4 Consiglio di Stato, V Sezione, 10 settembre 2010, n. 6548, che ha confermato TAR Lombardia, Milano, I Sezione, n. 74 del 2010.
5 Vedi nota 1.
6 Vedi nota 2.
7 TAR Puglia, Lecce, II Sezione, 2 febbraio 2010, nn. 416-417 e 27 aprile 2010, n. 1028.
8 Corte di Giustizia, III Sezione, 22 dicembre 2010, causa n. C-215/09.
9 TAR Liguria, II Sezione, 30 ottobre 2008, n. 1925, in Foro amm. TAR, 2008, 10, 2710.
10 In tal senso: Corte di Giustizia, Grande Sezione, 9 giugno 2009, causa n. C-480/06.
11 Corte di Giustizia, Grande Sezione, 18 dicembre 2007, causa n. C-532/03.
12 Per il principio: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 3 giugno 2011, n. 10, con riferimento alla possibilità da parte di un istituto universitario di costituire una società di engineering.





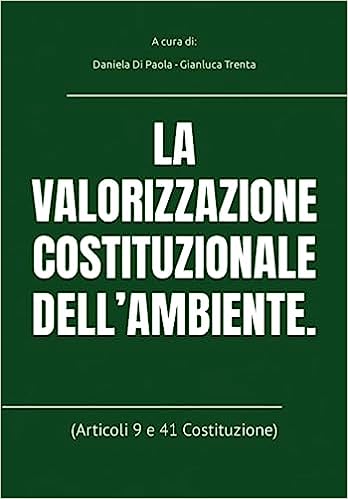
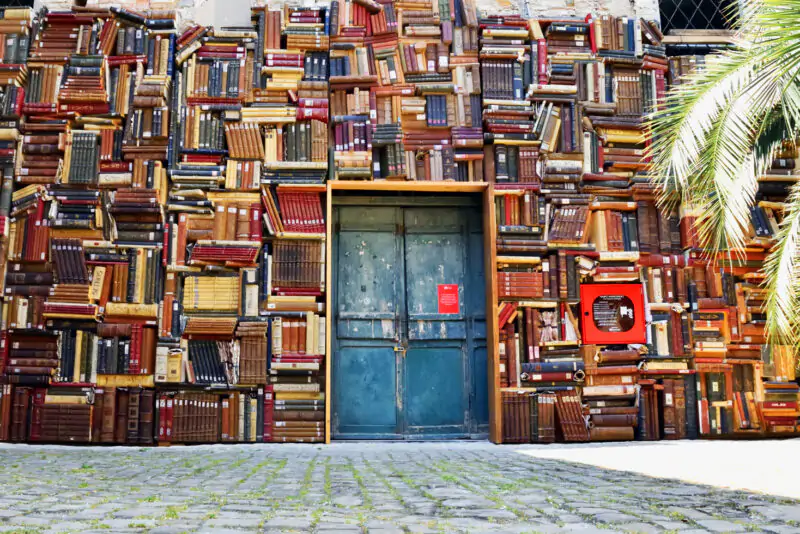 AMBIENTEDIRITTO.IT Casa Editrice
AMBIENTEDIRITTO.IT Casa Editrice