Corte di Giustizia e valutazioni ambientali: la considerazione degli “effetti cumulativi” nella valutazione di impatto ambientale di un progetto non è un optional e la valutazione di incidenza deve sempre assicurare l’assenza di pregiudizio al sito protetto oltre ogni “ragionevole dubbio” (anche laddove l’intervento sia giustificato da un motivo di rilevante interesse pubblico).
MATTEO CERUTI*
La sentenza della Quarta Sezione della Corte di Giustizia 24 novembre 2011, procedimento C 404/09, emessa nel ricorso per inadempimento della Commissione europea contro il Regno di Spagna, reca importanti precisazioni in materia di valutazioni ambientali, con riferimento alle autorizzazioni rilasciate dalle autorità di quel Paese per alcune miniere di carbone a cielo aperto.
Il primo significativo chiarimento riguarda la questione della considerazione degli “effetti cumulativi” nella valutazione di impatto ambientale (la questione è affrontata ai §§ 76 e ss. della sentenza).
Si tratta di tematica molto sviluppata in sede tecnica, ma sinora poco esplorata sul piano giuridico .
Il fondamento normativo di questo contenuto della VIA è rinvenibile in una nota apposta in calce al punto 4, dell’allegato IV della direttiva 85/337/CEE nella versione modificata dalla direttiva 97/11, ove si precisa che la “descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull’ambiente” – che costituisce l’oggetto fondamentale delle informazioni che il committente è tenuto a fornire (ossia quello che per noi è il “cuore” dello studio di impatto ambientale) – “dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto”.
Viene respinta l’interpretazione riduttiva della previsione, sostenuta dal Regno di Spagna, fondata sul dato letterale dell’impiego del verbo al condizionale (per cui questa descrizione “dovrebbe riguardare …”) da cui si evincerebbe che tale analisi degli effetti cumulativi dei progetti sull’ambiente sarebbe non obbligatoria ma soltanto “auspicabile”, ed invece valorizzata dalla Corte un’interpretazione teleologica della direttiva, tenendo conto dell’ambito di applicazione “esteso” e dell’obiettivo “molto ampio” della direttiva 85/337 modificata (quali emergono dagli artt. 1 e 3 di quest’ultima).
Di qui la conclusione del Giudice europeo secondo cui la suddetta disposizione dev’essere intesa nel senso che la valutazione degli effetti di un progetto in sede di VIA deve obbligatoriamente “anche includere un’analisi degli effetti cumulativi sull’ambiente che tale progetto può produrre se viene considerato congiuntamente ad altri progetti” giacché una tale analisi “è necessaria per garantire che la valutazione comprenda l’esame di tutti gli effetti notevoli sull’ambiente”.
Nel caso concreto si conclude che la valutazione dell’impatto ambientale di due progetti minerari autorizzati era risultata carente dell’analisi degli effetti cumulativi da ritenersi indispensabile in quanto le miniere interessate (denominate «Nueva Julia» e «Ladrones») sono situate in prossimità tra loro e le relative procedure di autorizzazione si erano svolte parallelamente.
Infine la Corte respinge anche l’ultimo argomento difensivo dello Stato membro secondo cui un’analisi cumulativa degli impatti delle due miniere era stata comunque condotta, ancorché dopo il rilascio delle autorizzazioni: sul punto la decisione precisa che non è possibile “rimediare” alla mancanza di tale analisi nell’ambito della valutazione iniziale, poiché la VIA dev’essere necessariamente “preliminare” all’autorizzazione del progetto (ex art. 2, n. 1, della direttiva 85/337 modificata).
Il medesimo principio della necessaria anteriorità della valutazione rispetto all’autorizzazione di un progetto (e della conseguente irrilevanza di studi eseguiti ex post nel tentativo di pervenire ad improbabili sanatorie) viene quindi espresso dalla sentenza anche in materia di valutazione degli effetti sui siti protetti dalla direttiva habitat 92/43/CEE (vds. i §§ 97 ss.).
Nella pronuncia si perviene dunque alla conclusione che le valutazioni di incidenza ambientale dei progetti relativi a due degli impianti minerari a cielo aperto considerati non potevano essere ritenute appropriate poiché risultavano caratterizzate dall’assenza di rilievi e di conclusioni “completi, precisi e definitivi” sugli effetti delle attività sulle zone protette, tali perciò da dissipare “qualsiasi ragionevole dubbio scientifico” in ordine agli effetti di detti progetti, in particolare, sulla popolazione del gallo cedrone cantabrico, la cui conservazione costituisce uno degli obiettivi della tutela (§ 105).
Inoltre a fronte dell’obiezione del Regno di Spagna circa l’importanza delle attività minerarie per l’economia locale, la Corte ricorda che tale considerazione può effettivamente costituire un “motivo imperativo di rilevante interesse pubblico” da considerare ai fini dell’eventuale autorizzazione in deroga sensi dell’art. 6, n. 4, della direttiva habitat, ma da valutare soltanto dopo che gli effetti di un piano o di un progetto siano stati analizzati in quanto la conoscenza degli stessi costituisce un “presupposto imprescindibile” ai fini della stessa applicazione della predetta disposizione derogatoria. E ciò per due ordini di ragioni: sia in quanto l’esame di eventuali motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (e della connessa questione se sussistano alternative meno dannose) richiede comunque una ponderazione del pregiudizio che deriverebbe al sito dal piano o dal progetto; sia perché il pregiudizio del sito dev’essere identificato con precisione allo scopo di stabilire la tipologia delle eventuali misure compensative (§ 109).
Trattasi di affermazioni di principio per la verità già contenute in diversi precedenti della giurisprudenza europea sulla direttiva 92/43/CEE, ma che vale comunque la pena di rammentare. Anche perché, francamente, negli ultimi tempi non pare che la Commissione UE risulti sempre averli perfettamente presenti allorché decide di archiviare procedure di infrazione aventi ad oggetto interventi in zone tutelate dalla direttiva habitat solo perché il Paese membro ha esaltato le ragioni di rilevanza per l’economia – locale o nazionale – di un progetto (sovente una “grande opera”), ovvero poiché le autorità nazionali hanno comunque avviato ex post procedure per sanare carenze nell’analisi degli effetti dell’intervento già autorizzato.
* Avvocato in Rovigo
Pubblicato su Osservatorio AD il 2 gennaio 2012





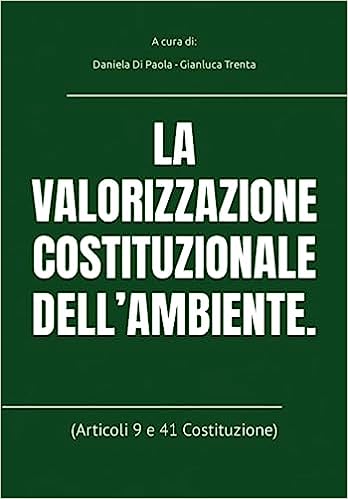
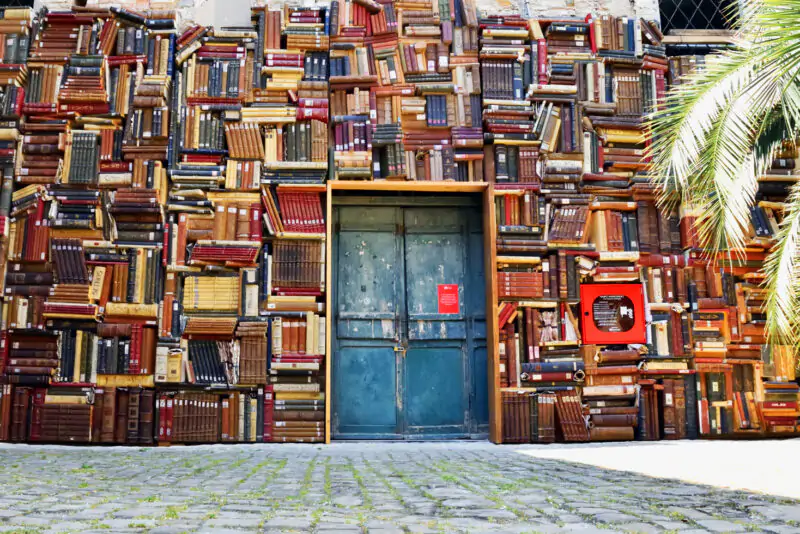 AMBIENTEDIRITTO.IT Casa Editrice
AMBIENTEDIRITTO.IT Casa Editrice