DIRITTO DELL’ENERGIA – Obiettivo della neutralità climatica dell’Unione – Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica – Normativa nazionale che pone a carico dei produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili il pagamento di un’imposta sui redditi – Esenzione a favore dei produttori di energia elettrica da combustibili fossili e da biomassa – Politica dell’Unione in materia ambientale – Direttiva (UE) 2019/944 – Regolamento (UE) 2021/1119 – Art.191, par.2, TFUE.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 9^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Ottobre 2025
Numero: C‑391/23
Data di udienza:
Presidente: Condinanzi
Estensore: Jarukaitis
Premassima
DIRITTO DELL’ENERGIA – Obiettivo della neutralità climatica dell’Unione – Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica – Normativa nazionale che pone a carico dei produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili il pagamento di un’imposta sui redditi – Esenzione a favore dei produttori di energia elettrica da combustibili fossili e da biomassa – Politica dell’Unione in materia ambientale – Direttiva (UE) 2019/944 – Regolamento (UE) 2021/1119 – Art.191, par.2, TFUE.
Massima
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 9^, 16 ottobre 2025, Sentenza n. C‑391/23
DIRITTO DELL’ENERGIA – Obiettivo della neutralità climatica dell’Unione – Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica – Normativa nazionale che pone a carico dei produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili il pagamento di un’imposta sui redditi – Esenzione a favore dei produttori di energia elettrica da combustibili fossili e da biomassa – Politica dell’Unione in materia ambientale – Direttiva (UE) 2019/944 – Regolamento (UE) 2021/1119 – Art.191, par.2, TFUE.
La direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE deve essere interpretata nel senso che: essa non osta a una normativa nazionale che assoggetta i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili a un’imposta sui redditi derivanti dalla vendita della loro energia elettrica al di sopra di un determinato prezzo fissato da tale normativa. Inoltre, il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»), deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che assoggetta i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili a un’imposta sui redditi derivanti dalla vendita della loro energia elettrica al di sopra di un determinato prezzo fissato da tale normativa, ma che esenta da detta imposta i produttori di energia elettrica da combustibili fossili.
Pres. Condinanzi, Rel. Jarukaitis, Ric. Brăila Winds SRL c. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București ed altri
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 9^, 16 ottobre 2025, Sentenza C‑391/23SENTENZA
SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
16 ottobre 2025
« Rinvio pregiudiziale – Articolo 191, paragrafo 2, TFUE – Politica dell’Unione in materia ambientale – Regolamento (UE) 2021/1119 – Obiettivo della neutralità climatica dell’Unione – Direttiva (UE) 2019/944 – Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica – Normativa nazionale che pone a carico dei produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili il pagamento di un’imposta sui redditi – Esenzione a favore dei produttori di energia elettrica da combustibili fossili e da biomassa »
Nella causa C‑391/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania), con decisione del 7 febbraio 2023, pervenuta in cancelleria il 27 giugno 2023, nel procedimento
Brăila Winds SRL
contro
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii București,
Ministerul Finanţelor,
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da M. Condinanzi, presidente di sezione, I. Jarukaitis (relatore), presidente della Quarta Sezione, e N. Jääskinen, giudice,
avvocato generale: A. Rantos
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Brăila Winds SRL, da C.-A. Bîrsan, E.-D. Gramaticescu e A.‑C. Lăcureanu, avocați;
– per la Commissione europea, da I. Georgiopoulos, L. Nicolae e K. Talabér-Ritz, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 49, 56, 107 e 108 nonché dell’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU 2019, L 158, pag. 125), nonché del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU 2021, L 243, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Brăila Winds SRL, una società produttrice di energia elettrica da fonti eoliche, e, dall’altro, la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii București (direzione generale regionale delle finanze pubbliche di Bucarest – amministrazione finanziaria per i contribuenti medi di Bucarest, Romania), il Ministerul Finanțelor (Ministero delle Finanze, Romania), il Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (presidente dell’Agenzia nazionale dell’amministrazione finanziaria, Romania) e l’Agenția Națională de Administrare Fiscală (Agenzia nazionale dell’amministrazione finanziaria, Romania) (in prosieguo: l’«ANAF»), relativamente a un’imposta reclamata alla Brăila Winds nella misura dell’80% dei suoi redditi derivanti dalla differenza tra il prezzo di vendita medio mensile della sua energia elettrica e il prezzo fissato dal legislatore nazionale.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Trattato FUE
3 L’articolo 191, paragrafo 2, TFUE è formulato nel modo seguente:
«La politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione [europea]. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”.
In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell’ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell’Unione».
Direttiva 2019/944
4 Ai sensi dell’articolo 1, primo e secondo comma, della direttiva 2019/944, intitolato «Oggetto»:
«La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione, lo stoccaggio e la fornitura dell’energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori, al fine di creare nell’Unione europea mercati dell’energia elettrica effettivamente integrati, competitivi, incentrati sui consumatori, flessibili, equi e trasparenti.
La presente direttiva intende avvalersi dei vantaggi di un mercato integrato per assicurare ai consumatori energia a prezzi e costi accessibili e trasparenti, un alto grado di sicurezza dell’approvvigionamento e una transizione agevole verso un sistema energetico sostenibile a basse emissioni di carbonio. (…)».
5 L’articolo 9 di tale direttiva, intitolato «Obblighi di servizio pubblico», ai paragrafi 1 e 2 così dispone:
«1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche operino secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dell’energia elettrica concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.
2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del TFUE, in particolare dell’articolo 106, gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresi la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell’ambiente, compresa l’efficienza energetica, l’energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle imprese dell’Unione che operano nel settore dell’energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. Gli obblighi di servizio pubblico relativi alla fissazione dei prezzi di fornitura dell’energia elettrica si conformano ai requisiti di cui all’articolo 5 della presente direttiva».
6 L’articolo 58 di detta direttiva, intitolato «Obiettivi generali dell’autorità di regolazione», così dispone:
«Nell’esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla presente direttiva, l’autorità di regolazione adotta tutte le misure ragionevoli idonee al perseguimento dei seguenti obiettivi, nel quadro dei compiti e delle competenze di cui all’articolo 59, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti, incluse le autorità garanti della concorrenza, nonché le autorità, comprese le autorità di regolazione, degli Stati membri limitrofi e dei paesi terzi limitrofi, se del caso, fatte salve le rispettive competenze:
a) promuovere, in stretta cooperazione con le autorità di regolazione degli altri Stati membri, con la Commissione [europea] e con l’[Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia], un mercato interno dell’energia elettrica concorrenziale, flessibile, sicuro ed ecologicamente sostenibile nell’Unione, nonché l’effettiva apertura del mercato per tutti i clienti e i fornitori dell’Unione, e garantire condizioni appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti elettriche, tenendo conto di obiettivi a lungo termine;
(…)
c) eliminare le restrizioni agli scambi di energia elettrica tra gli Stati membri e sviluppare adeguate capacità di trasmissione transfrontaliere per soddisfare la domanda e migliorare l’integrazione dei mercati nazionali che potrebbe agevolare la circolazione dell’energia elettrica attraverso l’Unione;
(…)».
Regolamento 2021/1119
7 L’articolo 1 del regolamento 2021/1119, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», stabilisce quanto segue:
«Il presente regolamento istituisce un quadro per la riduzione irreversibile e graduale delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra dalle fonti e l’aumento degli assorbimenti dai pozzi regolamentati nel diritto dell’Unione.
Il presente regolamento stabilisce l’obiettivo vincolante della neutralità climatica nell’Unione entro il 2050, in vista dell’obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell’[accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, ratificato dall’Unione con decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU 2016, L 282, pag. 1)], e istituisce un quadro per progredire nel perseguimento dell’obiettivo globale di adattamento di cui all’articolo 7 dell’accordo di Parigi. Il presente regolamento stabilisce anche l’obiettivo vincolante per l’Unione per una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra da conseguire entro il 2030.
(…)».
8 Ai sensi dell’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Obiettivo della neutralità climatica»:
«1. L’equilibrio tra le emissioni e gli assorbimenti di tutta l’Unione dei gas a effetto serra disciplinati dalla normativa unionale è raggiunto nell’Unione al più tardi nel 2050, così da realizzare l’azzeramento delle emissioni nette entro tale data, e successivamente l’Unione mira a conseguire emissioni negative.
2. Le istituzioni competenti dell’Unione e gli Stati membri adottano le misure necessarie, rispettivamente, a livello unionale e nazionale, per consentire il conseguimento collettivo dell’obiettivo della neutralità climatica di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell’importanza di promuovere sia l’equità che la solidarietà tra gli Stati membri nonché l’efficienza in termini di costi nel conseguimento di tale obiettivo».
9 L’articolo 5 di detto regolamento, intitolato «Adattamento ai cambiamenti climatici» al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Le istituzioni competenti dell’Unione e gli Stati membri assicurano il costante progresso nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici in conformità dell’articolo 7 dell’accordo di Parigi».
10 L’articolo 7 del medesimo regolamento, intitolato «Valutazione delle misure nazionali», è così formulato:
«1. Entro il 30 settembre 2023, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta:
a) la coerenza delle misure nazionali considerate, sulla base dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima, delle strategie nazionali a lungo termine e delle relazioni intermedie biennali presentate a norma del regolamento (UE) 2018/1999 [del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2018, L 328, pag. 1)], pertinenti per il conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento;
b) la coerenza delle pertinenti misure nazionali nell’assicurare i progressi in materia di adattamento di cui all’articolo 5, tenendo conto delle strategie di adattamento nazionali di cui all’articolo 5, paragrafo 4.
(…)
2. La Commissione, se dopo aver debitamente considerato i progressi collettivi valutati conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, constata che le misure di uno Stato membro non sono coerenti con il conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, o non sono coerenti nell’assicurare i progressi in materia di adattamento di cui all’articolo 5, può formulare raccomandazioni rivolte a tale Stato membro. La Commissione rende tali raccomandazioni disponibili al pubblico.
3. Se conformemente al paragrafo 2 sono formulate raccomandazioni, si applicano i principi seguenti:
a) lo Stato membro interessato, entro sei mesi dal ricevimento delle raccomandazioni, notifica alla Commissione in che modo intende tenere in debita considerazione le raccomandazioni, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri e Unione e tra gli Stati membri;
b) in seguito alla presentazione della notifica di cui alla lettera a) del presente paragrafo, nella relazione intermedia nazionale integrata sull’energia e il clima successiva trasmessa conformemente all’articolo 17 del regolamento [2018/1999] nell’anno successivo a quello in cui sono state formulate le raccomandazioni, lo Stato membro precisa in che modo ha tenuto in debita considerazione le raccomandazioni; se lo Stato membro interessato decide di non dare seguito alle raccomandazioni o a una parte considerevole delle stesse, fornisce le sue motivazioni alla Commissione;
(…)».
Direttiva 2008/118/CE
11 L’articolo 1 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L 9, pag. 12), così disponeva:
«1. La presente direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti (“prodotti sottoposti ad accisa”):
a) prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE [del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU 2003, L 283, pag. 51)];
(…)
2. Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l’imposta sul valore aggiunto [(IVA)] in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell’imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni.
(…)».
Direttiva 2003/96
12 L’articolo 1 della direttiva 2003/96 è così formulato:
«Gli Stati membri tassano i prodotti energetici e l’elettricità conformemente alla presente direttiva».
13 L’articolo 4 di tale direttiva prevede quanto segue:
«1. I livelli di tassazione applicati dagli Stati membri ai prodotti energetici e all’elettricità di cui all’articolo 2 non possono essere inferiori ai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva.
2. Ai fini della presente direttiva si intende per “livello di tassazione” l’onere fiscale complessivo derivante dal cumulo di tutte le imposte indirette (eccetto l’IVA), calcolate direttamente o indirettamente sulla quantità di prodotti energetici e di elettricità, all’atto dell’immissione in consumo».
Diritto rumeno
14 L’articolo II della Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei «Delta Dunării» (legge n. 259/2021 di conversione del decreto-legge n. 118/2021 sull’istituzione di un regime di compensazione per il consumo di energia elettrica e gas naturale per la stagione fredda 2021/2022 e che integra il decreto-legge n. 27/1996 sulla concessione di agevolazioni alle persone che risiedono o lavorano in determinate località dei Monti Apuseni e nella riserva della biosfera «Delta del Danubio»), del 29 ottobre 2021 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 1036 del 29 ottobre 2021), come modificata dall’ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 259/2021 (decreto-legge n. 11/2022, di modifica e integrazione della legge n. 259/2021), del 16 febbraio 2022 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 163 del 17 febbraio 2022) (in prosieguo: la «legge n. 259/2021», dispone quanto segue:
«1. Durante il periodo di applicazione delle disposizioni del [decreto-legge n. 118/2021], come modificato e integrato dalla presente legge, il reddito aggiuntivo realizzato dai produttori di energia elettrica derivante dalla differenza tra il prezzo medio mensile di vendita dell’energia elettrica e il prezzo di [450 lei rumeni (RON) (circa EUR 89) per megawattora (MWh)] è tassato all’80%.
2. I produttori di energia elettrica da combustibili fossili, compresa la cogenerazione, sono esenti dalle previsioni del paragrafo 1.
21. L’imposta di cui al paragrafo 1 è dichiarata e pagata su base mensile dai produttori di energia elettrica, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 2, fino al giorno 25 incluso del mese successivo a quello per cui detta imposta è dovuta. Tale imposta è versata al bilancio dello Stato, su un conto separato delle entrate del bilancio.
22. In deroga al paragrafo 21, l’imposta di cui al paragrafo 1 dovuta per il periodo dal 1º novembre al 31 dicembre 2021 è dichiarata e pagata entro il 25 gennaio 2022».
15 L’articolo III, paragrafo 3, del decreto-legge n. 11/2022 di modifica e integrazione della legge n. 259/2021 così prevede:
«Sono esenti dalle previsioni dell’articolo II, paragrafo 1, della legge n. 259/2021 (…) i produttori di energia elettrica da biomassa, a partire dai redditi aggiuntivi realizzati dopo il 1º gennaio 2022».
16 L’articolo I de l’ordinul președintelui ANAF nr. 64/2022 privind aplicarea prevederilor articolului II din [Legea nr. 259/2021], precum și privind modificarea și completarea Ordinului președintelui [ANAF] nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (decreto del presidente dell’ANAF n. 64/2022, sull’applicazione delle previsioni dell’articolo II della legge n. 259/2021 e che modifica e integra il decreto del presidente dell’ANAF n. 587/2016 recante approvazione del modello e del contenuto dei formulari utilizzati per la dichiarazione d’imposta e dei tributi oggetto del regime di autoliquidazione o di ritenuta alla fonte), del 18 gennaio 2022 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 55 del 19 gennaio 2022) (in prosieguo: il «decreto n. 64/2022»), è così formulato:
«L’imposta sul reddito aggiuntivo realizzato dai produttori di energia elettrica si calcola per il periodo dal 1º novembre 2021 al 31 marzo 2022».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
17 La ricorrente nel procedimento principale, vale a dire la Brăila Winds, è una società figlia del gruppo Engie in Romania. Essa produce energia elettrica mediante un impianto eolico situato nel distretto di Brăila (Romania).
18 L’articolo II della legge n. 259/2021 ha introdotto, a decorrere dal 1º novembre 2021, un’imposta dell’80% sul reddito ottenuto dai produttori di energia elettrica derivante dalla differenza tra il prezzo di vendita medio mensile dell’energia elettrica e il prezzo di RON 450 per MWh, di cui al paragrafo 1 di tale articolo II. Tuttavia, i produttori di energia elettrica da combustibili fossili, compresa la cogenerazione, e, a partire dal 1º gennaio 2022, i produttori di energia elettrica da biomassa sono esenti da detta imposta.
19 La legge n. 259/2021, nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, è il risultato di una serie di modifiche, intervenute nel corso del 2021 e del 2022, introdotte da decreti-legge che riguardavano le modalità di pagamento di tale imposta. Inoltre, il 19 gennaio 2022 è entrato in vigore il decreto n. 64/2022, che fornisce precisazioni sulla dichiarazione e sul pagamento di detta imposta, nonché sul formulario da utilizzare a tal fine.
20 In applicazione di detta legge e di detto decreto, la ricorrente nel procedimento principale, in qualità di produttore di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha presentato dichiarazioni fiscali nonché dichiarazioni rettificative e ha pagato, conformemente a queste ultime, un importo d’imposta complessivo pari a RON 11 643 217 (circa EUR 2 356 926,52) per il periodo compreso tra il novembre 2021 e il marzo 2022.
21 La ricorrente nel procedimento principale ha poi presentato, dinanzi all’ANAF, da un lato, un reclamo con il quale chiedeva l’annullamento del decreto n. 64/2022 e, dall’altro, un reclamo contro le dichiarazioni fiscali sulla base delle quali essa aveva pagato l’imposta di cui trattasi. Detti due reclami sono stati respinti con due decisioni di tale agenzia, rispettivamente, del 16 marzo e del 23 marzo 2022. Per quanto riguarda l’annullamento del decreto n. 64/2022, l’ANAF ha ritenuto, in sostanza, che quest’ultimo attuasse l’imposta istituita dalla legge n. 259/2021 e che, pertanto, dette disposizioni normative non potessero essere messe in discussione mediante un reclamo amministrativo.
22 Il 27 aprile 2022 la ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso dinanzi alla Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest, Romania), giudice del rinvio, con il quale essa contesta la legittimità del decreto n. 64/2022, nonché delle dichiarazioni fiscali redatte sulla base di quest’ultimo, affermando che l’imposta istituita dall’articolo II della legge n. 259/2021 è essa stessa illegittima. A tale riguardo, essa sostiene, dinanzi a detto giudice, che tale imposta instaura una discriminazione nei confronti dei produttori di energia da fonti rinnovabili e viola il principio della giusta ripartizione dell’onere fiscale, il principio di prevenzione della doppia imposizione nonché il principio di irretroattività e di prevedibilità dell’imposta, che hanno come corollario i principi di neutralità fiscale, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. Essa afferma altresì che tale imposta costituisce un aiuto di Stato illegale concesso ai produttori di energia elettrica da combustibili fossili, compresa la cogenerazione, e ai produttori di energia elettrica da biomassa, in violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, che l’imposta medesima crea ostacoli alla libera prestazione di servizi in violazione degli articoli 49 e 56 TFUE e che è contraria agli obiettivi dell’Unione relativi alla neutralità climatica entro il 2050, nonché alla politica europea di tassazione dell’energia e alla direttiva 2019/944. L’ANAF conclude per il rigetto di tale ricorso sostenendo che gli atti nazionali contestati sono conformi alle disposizioni legislative sulla base delle quali sono stati adottati e che erano in vigore in quel momento.
23 Il giudice del rinvio ritiene che la risposta a diverse questioni gli sia necessaria per dirimere la controversia di cui è investito. In tal senso, con la sua prima questione, tale giudice chiede se la legge n. 259/2021, che ha per effetto la sovrimposizione dei redditi di taluni produttori di energia elettrica, possa essere qualificata come «aiuto di Stato» a favore dei produttori di energia elettrica non soggetti a imposta, il quale, in virtù dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, avrebbe dovuto quindi essere notificato alla Commissione, come sostenuto dalla ricorrente dinanzi ad esso. Tale giudice si interroga, in particolare, sull’applicabilità del criterio del vantaggio selettivo, tenuto conto del fatto che tale legge non era applicabile a tutte le categorie di produttori di energia elettrica.
24 La seconda questione sollevata dal giudice del rinvio riguarda gli eventuali effetti della legge n. 259/2021 sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi, nella misura in cui essa potrebbe dissuadere il gruppo Engie dal continuare ad esercitare attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Romania a causa dell’importo elevato dell’imposta istituita da tale legge. L’elemento transfrontaliero consisterebbe, nel caso di specie, nel fatto che la Brăila Winds fa parte di tale gruppo, la cui sede si trova a Parigi (Francia). Sebbene tale questione verta sull’interpretazione tanto dell’articolo 49 TFUE quanto dell’articolo 56 TFUE, il giudice del rinvio ammette che la libera prestazione di servizi ha carattere sussidiario rispetto alla libertà di stabilimento, ma la ricorrente nel procedimento principale invoca entrambe le libertà in parola. Inoltre, quand’anche l’imposta di cui trattasi nel procedimento principale fosse applicabile in modo non discriminatorio nei confronti dei produttori residenti e non residenti, dalla giurisprudenza della Corte risulterebbe tuttavia che una siffatta circostanza non consentirebbe, di per sé, di ritenere che la legge n. 259/2021 non sia contraria a tali disposizioni del Trattato FUE. In particolare, si porrebbe, nel caso di specie, la questione se una tale normativa possa essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale e se essa sia proporzionata.
25 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede se l’imposta stabilita dalla legge n. 259/2021 possa essere qualificata come misura equivalente a una fissazione del prezzo di vendita o come restrizione alla libertà di fissazione del prezzo di vendita di energia elettrica, contraria alle disposizioni della direttiva 2019/944 e, in particolare, al suo articolo 58, lettera c), relativo all’obbligo dell’autorità nazionale di regolazione di eliminare le restrizioni agli scambi di energia elettrica tra gli Stati membri, in combinato disposto con l’articolo 9 di tale direttiva, nella misura in cui quest’ultimo avrebbe effetto diretto. A tale riguardo, il giudice del rinvio precisa che la ricorrente nel procedimento principale afferma che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale falsa la libera concorrenza sul mercato dell’energia elettrica, comportando costi supplementari per taluni produttori, riducendo la sicurezza dell’approvvigionamento e impedendo la formazione dei prezzi in funzione dell’interazione tra l’offerta e la domanda. Occorrerebbe, pertanto, stabilire se tale normativa sia compatibile con detto articolo 9, nella misura in cui si sostiene, dinanzi al giudice del rinvio, che essa non è né appropriata rispetto allo scopo perseguito né proporzionata.
26 Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se i principi della precauzione, dell’azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente nonché il principio «chi inquina paga», sanciti dall’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, invocati dalla ricorrente nel procedimento principale dinanzi ad esso, abbiano un effetto diretto e se siano violati dall’istituzione di un’imposta che si applica ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, ad esclusione dei produttori di energia elettrica da combustibili fossili. Esso precisa, inoltre, che la ricorrente nel procedimento principale afferma altresì che tale imposta è contraria alla direttiva 2003/96 e agli obiettivi dell’Unione in materia di neutralità climatica.
27 È in tale contesto che la Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se le disposizioni degli articoli 107 e 108 TFUE debbano essere interpretate nel senso che una normativa nazionale come quella introdotta dalla [legge n. 259/2021], che impone un’imposta soltanto a determinati produttori di energia elettrica, costituisce un aiuto di Stato concesso ai soggetti esentati, assoggettato agli obblighi di notifica. Se tale normativa sia discriminatoria se si applica solo a determinati produttori di energia elettrica, compresi quelli da fonti rinnovabili.
2) Se le disposizioni degli articoli 49 e 56 TFUE e, rispettivamente, quelle dell’articolo 17 della [Carta] debbano essere interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella introdotta dalla legge n. 259/2021, che impone un’imposta di importo elevato soltanto a determinati produttori di energia elettrica (compresi quelli da fonti rinnovabili), escludendo altre categorie di produttori.
3) Se (…) la direttiva [2019/944], osti a una normativa nazionale che potrebbe tradursi in una fissazione del prezzo di vendita/una limitazione della libertà di fissare il prezzo di vendita, [normativa] come quella introdotta dalla legge n. 259/2021.
4) Se le disposizioni dell’articolo 191, paragrafo 2, TFUE riguardanti i principi della precauzione, dell’azione preventiva e della correzione dell’inquinamento alla fonte, nonché il principio “chi inquina paga” ostino a una normativa nazionale come quella introdotta dalla legge n. 259/2021. Se ciò comprometta gli obiettivi europei relativi al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 e la politica dell’Unione europea in materia di tassazione dell’energia».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla competenza della Corte e sulla ricevibilità
28 Occorre ricordare, in via preliminare, che, secondo costante giurisprudenza, il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che son loro necessari per la soluzione delle controversie che sono chiamati a decidere (v. ordinanza del 26 gennaio 1990, Falciola, C‑286/88, EU:C:1990:33, punto 7). La ratio del rinvio pregiudiziale non risiede nell’esprimere pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia (v. sentenze del 16 dicembre 1981, Foglia, 244/80, EU:C:1981:302, punto 18, e del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 44 e giurisprudenza citata).
29 Nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, deve quindi esistere tra la suddetta controversia e le disposizioni del diritto dell’Unione di cui è chiesta l’interpretazione un collegamento tale per cui detta interpretazione risponde ad una necessità oggettiva ai fini della decisione che dev’essere adottata dal giudice del rinvio (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 48 e giurisprudenza citata).
30 L’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca l’ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni da esso sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v. sentenza del 26 gennaio 1993, Telemarsicabruzzo e a., da C‑320/90 a C‑322/90, EU:C:1993:26, punto 6). In tal senso, la Corte ha dichiarato che è indispensabile che il giudice nazionale fornisca un minimo di spiegazioni sui motivi della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione e sul nesso che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia (v. ordinanza del 28 giugno 2000, Laguillaumie, C‑116/00, EU:C:2000:350, punto 16, e sentenza del 12 settembre 2024, Syndyk Masy Upadłości A, C‑709/22, EU:C:2024:741, punto 70).
31 A tal proposito, occorre sottolineare che le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio devono, da un lato, permettere alla Corte di fornire risposte utili alle questioni sollevate dal giudice nazionale e, dall’altro, consentire ai governi degli Stati membri e agli altri interessati di esercitare il diritto a presentare osservazioni conferito loro dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Spetta alla Corte provvedere affinché tale diritto sia garantito, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, soltanto le decisioni di rinvio vengono notificate agli interessati (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, Irish Ferries, C‑570/19, EU:C:2021:664, punto 134 e giurisprudenza citata).
32 Tali requisiti cumulativi relativi al contenuto di una decisione di rinvio sono esplicitamente indicati all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, che il giudice del rinvio, nell’ambito della cooperazione istituita dall’articolo 267 TFUE, è tenuto a conoscere e deve rispettare scrupolosamente. Essi sono inoltre richiamati ai punti 13, 15 e 16 delle raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU C, C/2024/6008) [v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2024, Presidenza del Consiglio dei ministri e a. (Retribuzione dei magistrati onorari), C‑548/22, EU:C:2024:730, punto 29].
33 A tal proposito, per quanto riguarda, in primo luogo, la prima questione, con la quale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 107 e 108 TFUE debbano essere interpretati nel senso che una normativa nazionale in virtù della quale solo taluni produttori di energia elettrica sono assoggettati a un’imposta sui redditi eccedenti una determinata somma costituisce un aiuto di Stato concesso ai produttori che ne sono esentati, aiuto soggetto all’obbligo di notifica, occorre rilevare che, secondo costante giurisprudenza, la qualificazione di una misura nazionale come «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, richiede che siano soddisfatti tutti i requisiti seguenti. Sotto un primo profilo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o attraverso risorse statali. Sotto un secondo profilo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Sotto un terzo profilo, esso deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario. Sotto un quarto profilo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (sentenza del 26 aprile 2018, ANGED, C‑233/16, EU:C:2018:280, punto 37 e giurisprudenza citata).
34 Al fine di valutare, in particolare, se la misura nazionale di cui trattasi conceda un vantaggio selettivo ai suoi beneficiari, occorre stabilire se, nell’ambito di un determinato regime giuridico, la misura in parola sia idonea a favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre che si trovano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito da detto regime, in situazioni di fatto e di diritto paragonabili e che sono quindi oggetto di un trattamento differenziato qualificabile, in sostanza, come discriminatorio (sentenze del 16 marzo 2017, Identi, C‑493/15, EU:C:2017:219, punto 26, e del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./Commissione, C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 106, nonché giurisprudenza citata). Inoltre, la determinazione dell’ambito di riferimento assume un’importanza maggiore nel caso di misure fiscali, dal momento che l’esistenza di un vantaggio economico, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, può essere accertata solo con riferimento a un livello di tassazione definito «normale» (sentenza del 7 novembre 2019, UNESA e a., da C‑105/18 a C‑113/18, EU:C:2019:935, punto 62).
35 Orbene, nel caso di specie, il giudice del rinvio non ha fornito alcuna spiegazione quanto alle ragioni per le quali ritiene che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale possa essere incompatibile con le disposizioni dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Per di più, la domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene gli elementi necessari per stabilire se il regime fiscale istituito da tale normativa possa costituire un «aiuto di Stato», ai sensi di tali disposizioni. In particolare, non è possibile individuare il sistema di riferimento di cui trattasi nel procedimento principale, vale a dire quali siano il livello di tassazione «normale» dei produttori di energia elettrica, l’obiettivo, la natura e la struttura di tale sistema, la comparabilità tra i produttori di energia elettrica assoggettati all’imposta di cui trattasi e i produttori di energia elettrica esenti da quest’ultima né, se del caso, l’eventuale giustificazione del loro trattamento differenziato.
36 Pertanto, poiché la Corte non dispone degli elementi necessari per rispondere in modo utile alla prima questione, si deve ritenere che essa sia irricevibile.
37 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la seconda questione, che concerne l’interpretazione degli articoli 49 e 56 TFUE nonché dell’articolo 17 della Carta, dalla decisione di rinvio risulta che, nell’ambito di tale questione, il giudice del rinvio chiede se la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale stabilisca una discriminazione indiretta, contraria agli articoli 49 e 56 TFUE, nella misura in cui riguarda soggetti, come la ricorrente nel procedimento principale, facenti parte di un gruppo la cui società madre ha sede in un altro Stato membro. In particolare, il giudice del rinvio indica che tale normativa potrebbe avere l’effetto di dissuadere tale gruppo dal continuare ad esercitare attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Romania.
38 Orbene, occorre rilevare, sotto un primo profilo, che, nel caso di specie, la società madre di detto gruppo, stabilita in un altro Stato membro, non è parte della controversia di cui al procedimento principale e che il giudice del rinvio non spiega in che modo, nell’ambito della controversia di cui è investito e vertente sulla legittimità dell’imposizione di cui solo la ricorrente nel procedimento principale, società figlia di detta società madre, è stata oggetto, esso potrebbe essere indotto a valutare l’impatto di tale imposizione su detta società madre e, se del caso, a trarne eventuali conseguenze.
39 Di conseguenza, nella misura in cui la seconda questione potrebbe essere intesa come vertente su un’ipotesi che non corrisponde alla situazione di fatto della controversia di cui al procedimento principale, vale a dire l’esistenza di eventuali restrizioni alle libertà contemplate dagli articoli 49 e 56 TFUE di cui la società madre della ricorrente nel procedimento principale potrebbe essere oggetto, occorre constatare che tale questione è ipotetica e quindi irricevibile a tale titolo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2025, Elektrorazpredelitelni mrezhi Zapad, C‑310/24, EU:C:2025:406, punto 44).
40 Per quanto riguarda, sotto un secondo profilo, l’esistenza di un’eventuale restrizione alle libertà summenzionate di cui la stessa ricorrente nel procedimento principale potrebbe essere oggetto, occorre ricordare che la missione della Corte, nell’ambito di un procedimento in via pregiudiziale, è di assistere il giudice del rinvio nella soluzione della controversia concreta dinanzi ad esso pendente, il che presuppone che sia dimostrato che le libertà invocate da detto giudice siano applicabili alla controversia in parola. Orbene, le disposizioni del Trattato FUE in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi non sono applicabili a una fattispecie i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro (v., in tal senso, sentenze del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, punti 47 e 49, nonché del 2 marzo 2023, Bursa Română de Mărfuri, C‑394/21, EU:C:2023:146, punto 48).
41 Inoltre, quando la Corte è adita da un giudice nazionale nel contesto di una controversia vertente su una situazione del genere, essa non può, senza indicazioni da parte di tale giudice diverse dal fatto che la normativa nazionale in discussione dinanzi ad esso è applicabile indistintamente ai cittadini dello Stato membro interessato e ai cittadini di altri Stati membri, considerare che la domanda di interpretazione in via pregiudiziale vertente sulle disposizioni del trattato FUE relative alle libertà fondamentali sia a tale giudice necessaria ai fini della soluzione della controversia dinanzi al medesimo pendente. Gli elementi concreti che consentono di stabilire un collegamento fra l’oggetto o le circostanze di una controversia i cui elementi sono tutti collocati all’interno dello Stato membro interessato e gli articoli 49 e 56 TFUE devono infatti risultare dalla decisione di rinvio, al fine di consentire alla Corte di individuare un elemento di collegamento di tale controversia con dette disposizioni del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, punti 54 e 55).
42 Nel caso di specie, siffatti elementi concreti non risultano dalla decisione di rinvio, atteso che il giudice del rinvio si limita ad indicare che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale è indistintamente applicabile tanto ai cittadini nazionali quanto a quelli degli altri Stati membri. Il solo fatto che la ricorrente nel procedimento principale sia la società figlia di una società madre stabilita in uno Stato membro diverso dalla Romania è un’indicazione insufficiente quanto all’eventuale esistenza del collegamento di cui al punto precedente della presente sentenza.
43 Infine, sotto un terzo profilo, per quanto riguarda l’articolo 17 della Carta, il quale sancisce il diritto di proprietà, occorre ricordare che, in virtù dell’articolo 51, paragrafo 1, della stessa, le sue disposizioni si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Al fine di stabilire se una misura nazionale rientri nell’«attuazione del diritto dell’Unione» ai sensi di tale articolo 51, paragrafo 1, occorre verificare, inter alia, se la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale abbia lo scopo di attuare una disposizione del diritto dell’Unione, quale sia il suo carattere e se essa persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto dell’Unione, anche se è in grado di incidere indirettamente su quest’ultimo, nonché se esista una normativa di diritto dell’Unione che disciplini specificamente la materia o che possa incidere sulla stessa (v., in tal senso, sentenza del 5 maggio 2022, BPC Lux 2 e a., C‑83/20, EU:C:2022:346, punti da 25 a 27 e giurisprudenza citata).
44 Tuttavia, nel caso di specie, la decisione di rinvio non contiene alcun elemento che consenta di ritenere che il procedimento principale verta su una normativa nazionale che attua il diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta. Ne consegue che la Corte non è competente a statuire sull’interpretazione dell’articolo 17 della Carta.
45 Alla luce delle considerazioni che precedono, la seconda questione è irricevibile nella sua interezza.
Nel merito
Sulla terza questione
46 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2019/944 debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che assoggetta taluni produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili a un’imposta sui redditi derivanti dalla vendita della loro energia elettrica al di sopra di un determinato prezzo fissato da tale normativa.
47 A tale riguardo, la direttiva 2019/944 stabilisce, ai sensi del suo articolo 1, norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione, lo stoccaggio e la fornitura dell’energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori, al fine di creare nell’Unione mercati dell’energia elettrica effettivamente integrati, competitivi, incentrati sui consumatori, flessibili, equi e trasparenti. Essa mira inoltre, in particolare, ad assicurare ai consumatori energia a prezzi e costi accessibili e trasparenti.
48 L’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva dispone che gli Stati membri devono far sì che le imprese elettriche operino secondo i principi da essa enunciati, al fine di realizzare un mercato dell’energia elettrica concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, e devono astenersi da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi. L’articolo 58 di detta direttiva, che elenca gli obiettivi generali posti a carico dell’autorità di regolazione, stabilisce, alla lettera c), che spetta a tale autorità adottare tutte le misure ragionevoli idonee a eliminare le restrizioni agli scambi di energia elettrica tra gli Stati membri e sviluppare adeguate capacità di trasmissione transfrontaliere per soddisfare la domanda e migliorare l’integrazione dei mercati nazionali.
49 A tale riguardo, il giudice del rinvio chiede se una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale assoggetta taluni produttori di energia elettrica a un’imposta sui redditi derivanti dalla vendita della loro energia elettrica al di sopra di un determinato prezzo fissato da tale normativa, sia contraria alla direttiva 2019/944, in quanto misura equivalente a una fissazione del prezzo di vendita dell’energia elettrica o a una restrizione della libertà di fissare tale prezzo, nella misura in cui è tale da avere un’eventuale incidenza sulla determinazione di detto prezzo.
50 La ricorrente nel procedimento principale afferma, dal canto suo, dinanzi al giudice del rinvio, che il regime fiscale di cui trattasi nel procedimento principale falsa la libera concorrenza sul mercato dell’energia elettrica, comportando costi supplementari per taluni produttori, riducendo la sicurezza dell’approvvigionamento e impedendo la formazione dei prezzi in funzione dell’interazione tra l’offerta e la domanda.
51 Orbene, occorre rilevare che dalla giurisprudenza della Corte in relazione alla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55), sostituita dalla direttiva 2019/944, risulta che tale prima direttiva non mirava al ravvicinamento dei regimi fiscali degli Stati membri in materia e che il principio di non discriminazione da essa previsto non si applicava a una normativa di uno Stato membro che istituiva un’imposta gravante sulla produzione e sull’immissione di energia elettrica nel sistema elettrico nel territorio di tale Stato (v., in tal senso, sentenza del 3 marzo 2021, Promociones Oliva Park, C‑220/19, EU:C:2021:163, punto 78 e giurisprudenza citata).
52 Nel caso di specie, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, risulta che le disposizioni di cui trattasi della legge n. 259/2021 istituiscono un’imposta che persegue, almeno in parte, un obiettivo di bilancio e non mirano a regolamentare la fornitura di energia elettrica né a garantire la protezione dei consumatori o quella della libera concorrenza.
53 Inoltre, e in ogni caso, le disposizioni di cui trattasi della legge n. 259/2021 non sembrano costituire una misura equivalente a una «misura di fissazione del prezzo di vendita» dell’energia elettrica o a una limitazione alla libertà dei produttori di energia elettrica di fissare i loro prezzi di vendita, essendo l’eventuale effetto dell’imposta di cui trattasi nel procedimento principale sui prezzi di vendita quanto meno lontano e aleatorio, dato che detta imposta si limita, in sostanza, a ridurre gli utili che tali produttori possono trarre dalle loro vendite.
54 Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che la direttiva 2019/944 deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che assoggetta taluni produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili a un’imposta sui redditi derivanti dalla vendita della loro energia elettrica al di sopra di un determinato prezzo fissato da tale normativa.
Sulla quarta questione
55 In via preliminare, occorre ricordare che, come risulta altresì dal punto 28 della presente sentenza, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare la questione che le è sottoposta (sentenza del 30 aprile 2025, Inspektorat kam Visshia sadeben savet, C‑313/23, C‑316/23 e C‑332/23, EU:C:2025:303, punto 65 e giurisprudenza citata).
56 Nel caso di specie, il giudice del rinvio fa riferimento, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, per quanto riguarda la quarta questione, alla compatibilità di una normativa nazionale come la legge n. 259/2021 alla luce, in particolare, degli «obiettivi della neutralità climatica entro il 2050» e della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell’11 dicembre 2019, intitolata «Il Green Deal europeo [(Patto verde europeo)]» [COM(2019) 640 final]. Orbene, tale patto costituisce solo una comunicazione adottata dalla Commissione, priva di effetto vincolante [v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, Lituania e a./Parlamento e Consiglio (Pacchetto mobilità), da C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818, punto 432].
57 Tuttavia, l’obiettivo della neutralità climatica è assegnato collettivamente all’Unione e agli Stati membri dal regolamento 2021/1119, atteso che l’articolo 2, paragrafo 1, di quest’ultimo stabilisce che la neutralità climatica deve essere raggiunta nell’Unione al più tardi nel 2050.
58 Occorre dunque ritenere che, con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE e il regolamento 2021/1119 ostino a una normativa nazionale che assoggetta i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili a un’imposta sui redditi derivanti dalla vendita della loro energia elettrica al di sopra di un determinato prezzo fissato da tale normativa, ma che esenta da detta imposta i produttori di energia elettrica da combustibili fossili.
59 Va ricordato, per quanto riguarda, in primo luogo, l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, che tale disposizione stabilisce che la politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Tale politica è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga». In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell’ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell’Unione.
60 Il giudice del rinvio chiede, in particolare, se i principi stabiliti da detta disposizione abbiano effetto diretto e, in caso affermativo, se un’imposta come quella di cui trattasi nel procedimento principale sia contraria a tali principi.
61 Al riguardo, la Corte ha dichiarato che l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE si limita a definire gli obiettivi generali dell’Unione in materia ambientale, nella misura in cui l’articolo 192 TFUE affida al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria, il compito di decidere le azioni da intraprendere per raggiungere detti obiettivi. Di conseguenza, dal momento che l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, che enuncia, tra l’altro, il principio «chi inquina paga», è rivolto al legislatore dell’Unione, non può essere invocato in quanto tale dai privati, a sostegno di una domanda diretta ad escludere l’applicazione di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in un’ipotesi che non è disciplinata da alcuna normativa dell’Unione adottata sul fondamento dell’articolo 192 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 4 marzo 2015, Fipa Group e a., C‑534/13, EU:C:2015:140, punti 39 e 40, nonché del 13 luglio 2017, Túrkevei Tejtermelő Kft., C‑129/16, EU:C:2017:547, punti 36 e 37).
62 Atteso che il legislatore dell’Unione non ha adottato, sulla base dell’articolo 192 TFUE, alcun atto idoneo a disciplinare l’adozione, da parte degli Stati membri, di un’imposta come quella stabilita dalla legge n. 259/2021, occorre constatare che l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE non è applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, cosicché non occorre esaminare la quarta questione alla luce di quest’ultima disposizione.
63 Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli obiettivi della neutralità climatica che l’Unione si è prefissata e, in particolare, il regolamento 2021/1119, che definisce tali obiettivi da raggiungere entro il 2050, occorre rilevare che tale regolamento mira, conformemente al suo articolo 1, segnatamente, a istituire un quadro per la riduzione irreversibile e graduale delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra e stabilire l’obiettivo vincolante della neutralità climatica nell’Unione.
64 L’articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento dispone, inoltre, che gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie a livello nazionale per consentire il conseguimento collettivo dell’obiettivo della neutralità climatica. In virtù dell’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento, le istituzioni competenti dell’Unione e gli Stati membri devono assicurare il costante progresso nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento 2021/1119, la Commissione deve valutare periodicamente la coerenza delle misure nazionali considerate, sulla base dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima, delle strategie nazionali a lungo termine e delle relazioni intermedie biennali. Se tale istituzione constata che le misure adottate da uno Stato membro non sono coerenti con il conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica o non sono coerenti nell’assicurare i progressi in materia di adattamento di cui all’articolo 5, essa può formulare raccomandazioni rivolte a tale Stato membro, in seguito alle quali quest’ultimo è tenuto a notificare alla Commissione in che modo intende tenerle in debita considerazione e, nell’anno successivo, in che modo ha tenuto in debita considerazione le medesime o, se decide di non dare seguito alle raccomandazioni o a una parte considerevole delle stesse, a fornire le sue motivazioni a detta istituzione.
65 Risulta quindi tanto dal tenore letterale delle disposizioni del regolamento 2021/1119, in particolare dai suoi articoli 2, 5 e 7, quanto dall’obiettivo della neutralità climatica da esso perseguito che detto regolamento si limita ad obbligare gli Stati membri a stabilire una strategia globale al fine di conseguire tale obiettivo.
66 Infatti, come sottolineato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, una misura concreta adottata da uno Stato membro deve essere valutata, a tal fine, alla luce di tutte le circostanze della situazione in cui essa si inserisce e di tutte le misure adottate dallo Stato membro interessato al fine di contribuire al conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica a livello dell’Unione. Orbene, una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale non risulta tale da avere di per sé un’influenza determinante sul conseguimento di un siffatto obiettivo o da produrre l’effetto che lo Stato membro che l’ha adottata venga meno all’obbligo di adottare le misure necessarie per consentire il conseguimento di tale obiettivo comune, tenuto conto, in particolare, del fatto che l’applicazione di tale normativa è limitata nel tempo e non sembra poter incidere in modo significativo sull’emissione di gas a effetto serra.
67 Di conseguenza, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che il regolamento 2021/1119 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che assoggetta i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili a un’imposta sui redditi derivanti dalla vendita della loro energia elettrica al di sopra di un determinato prezzo fissato da tale normativa, ma che esenta da detta imposta i produttori di energia elettrica da combustibili fossili.
Sulle spese
68 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:
1) La direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE
deve essere interpretata nel senso che:
essa non osta a una normativa nazionale che assoggetta i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili a un’imposta sui redditi derivanti dalla vendita della loro energia elettrica al di sopra di un determinato prezzo fissato da tale normativa.
2) Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»),
deve essere interpretato nel senso che:
esso non osta a una normativa nazionale che assoggetta i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili a un’imposta sui redditi derivanti dalla vendita della loro energia elettrica al di sopra di un determinato prezzo fissato da tale normativa, ma che esenta da detta imposta i produttori di energia elettrica da combustibili fossili.
Firme





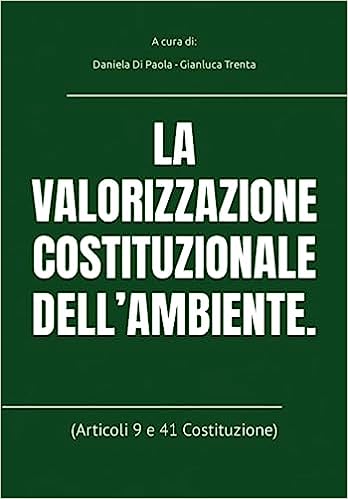
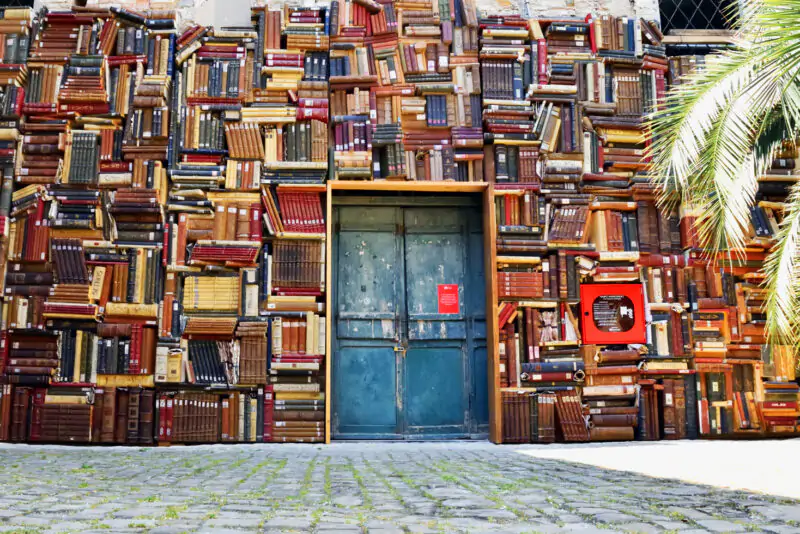 AMBIENTEDIRITTO.IT Casa Editrice
AMBIENTEDIRITTO.IT Casa Editrice