L’invalidità del titolo edilizio nel giudizio penale
L’esame delle problematiche relative alla rilevanza dell’atto amministrativo invalido nella fattispecie penale ha dato luogo ad un articolato dibattito dottrinale
1 e giurisprudenziale.
La maggior parte delle riflessioni giurisprudenziali sono sorte in materia edilizia ed il punto centrale del dibattito ha avuto ad oggetto la possibilità per il giudice penale di contestare un abuso edilizio in presenza di opere edilizie realizzate conformemente ad un titolo abilitativo (ritenuto) illegittimo.
A seguito di alcuni contrasti nella giurisprudenza, nel 1987 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione vennero investite della problematica giuridica relativa all’equiparazione tra “mancanza di concessione edilizia” e “concessione edilizia rilasciata illegittimamente”.
In quella occasione
2, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione esclusero che, con riferimento al reato di cui all’art. 17, lett. b), della legge n. 10 del 1977 (che sanzionava l’esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia), potesse essere accolta la tesi dell’equiparazione tra costruzione edilizia effettuata senza titolo e costruzione edilizia effettuata sulla base di un titolo illegittimo, che traeva fondamento dall’istituto della disapplicazione del provvedimento amministrativo illegittimo, disciplinato dagli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E.
Secondo la Suprema Corte, le norme della legge n. 2248 del 1865 non introducono un principio generalizzato di disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi da parte del giudice ordinario per esigenze di diritto oggettivo, ma, al contrario, sono rivolte a limitare il controllo (sempre in via incidentale) da parte del giudice ordinario sulla legittimità dell’atto amministrativo ai soli atti incidenti negativamente sui diritti soggettivi; conseguentemente, l’istituto della disapplicazione non può trovare applicazione nei confronti di quegli atti amministrativi che rimuovono, invece, un ostacolo al libero esercizio di un diritto soggettivo o addirittura costituiscono un diritto.
Ciò, per la Corte, non significa che al giudice penale sia impedito in assoluto di conoscere della legittimità dell’atto amministrativo: tale possibilità può trovare fondamento o in una previsione legislativa esplicita ovvero qualora l’illegittimità dell’atto amministrativo si presenti essa stessa come elemento essenziale della fattispecie criminosa.
Le Sezioni Unite intervennero nuovamente sulla questione nel 1993
3 e, con riferimento alla fattispecie di cui alla lettera a) dell’art. 20 della legge n. 47 del 1985, sostennero che al giudice penale non è affidato alcun sindacato sull’atto amministrativo, ma nell’esercizio della potestà penale è tenuto ad accertare la conformità tra ipotesi di fatto e fattispecie legale, in vista dell’interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela.
In nome, quindi, dell’interesse sostanziale tutelato, il reato di cui alla lettera a) della legge n. 47 del 1985 è, secondo la Corte, configurabile in caso di realizzazione di opere in contrasto con l’ordinamento urbanistico-edilizio anche in presenza di una concessione edilizia, la quale non è idonea a definire esaurientemente lo statuto urbanistico ed edilizio dell’opera realizzanda e che, pertanto, non necessita di disapplicazione.
Va subito messo in luce che il precetto di cui alla lettera a) dell’art. 20 della legge n. 47 del 1985 (oggi lettera a) dell’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001) ha per oggetto anche la violazione di disposizioni contenute in norme di legge in materia urbanistica-edilizia nonché nel regolamento edilizio e nello strumento urbanistico.
L’accertamento attribuito al giudice penale si estende, quindi, anche alla verifica della conformità della condotta posta in essere con la realizzazione dell’opera ai parametri di legalità fissati dall’ordinamento urbanistico-edilizio.
Si può, quindi, ragionevolmente ritenere che, con riferimento alle fattispecie di reato di inosservanza delle regole edilizie (descritta oggi nella lettera a) dell’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001), l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la conformità della costruzione e del titolo edilizio all’ordinamento giuridico di settore è elemento costitutivo dei reati urbanistici trovi sostegno nell’esegesi testuale della norma incriminatrice.
In questa ipotesi è la descrizione normativa del reato che impone al giudice un riscontro diretto di tutti gli elementi che concorrono a determinare la condotta criminosa che, nella fattispecie sopra riferita, è (anche) quella contrastante con le prescrizioni legislative e regolamentari ivi richiamate, pur in presenza di un titolo abilitativo e prescindendo da un giudizio su tale atto finalizzato alla sua disapplicazione.
A conclusioni difformi deve pervenirsi con riferimento alla fattispecie di reato di esecuzione di lavori in assenza del permesso di costruire, descritta nella lettera b) del cit. art. 44, rispetto alla quale il richiamo alla legalità urbanistica ed edilizia quale interesse protetto dalla norma incriminatrice si scontra con il dato letterale della disposizione legislativa.
In questa ipotesi, la descrizione legale della fattispecie di reato impone al giudice il mero riscontro della presenza o meno del titolo edilizio: la conformità della costruzione e del permesso di costruire all’ordinamento edilizio-urbanistico non è, in questo caso, elemento costitutivo del reato.
Al riguardo, non può, quindi, essere condiviso l’orientamento giurisprudenziale
4 che ha esteso all’ipotesi illustrata nella lettera b) del cit. art. 44 le riflessioni che avevano indotto nel 1993 le Sezioni Unite ad individuare nel parametro della legalità urbanistica ed edilizia un elemento costitutivo del diverso reato descritto nella lettera a) dell’art. 20 della legge n. 47 del 1985.
L’art. 44, lett. b), del TU in materia edilizia, nel sanzionare l’esecuzione di lavori in assenza del permesso di costruire, non appare neanche funzionale alla tutela dell’interesse all’osservanza delle norme dell’ordinamento urbanistico-edilizio.
La disposizione in esame risponde all’interesse pubblico, avvertito dal legislatore sin dall’emanazione della legge urbanistica del 1942, di sottoporre l’attività edilizia al controllo preventivo della P.A., con conseguente imposizione dell’obbligo di richiedere l’apposito provvedimento abilitativo all’edificazione.
Rispetto a tale esigenza di controllo preventivo della P.A. appare indifferente la circostanza che la costruzione corrisponda o meno al complesso delle norme che regolano l’attività edilizia
5.
Si aggiunga che il potere di sindacato a tutto campo del giudice penale discendente dall’art. 101 della Costituzione deve in ogni caso essere bilanciato con gli altri valori costituzionali coinvolti; nella valutazione comparativa tra i principi costituzionali il principio di legalità nella giurisdizione non può che recedere di fronte al principio di legalità-tassatività in materia penale, di cui all’art. 25 Cost. ed oggi codificato anche nell’art. 7 della CEDU
6, e della personalità della responsabilità penale sancito dall’art. 27 Cost..
Si può, quindi, ragionevolmente sostenere che per la configurazione del reato di esecuzione di lavori in assenza del permesso di costruire, di cui alla lettera b) dell’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, occorre che manchi il titolo edilizio.
L’assenza del permesso di costruire non va intesa, tuttavia, solo come inesistenza materiale, ma anche come inesistenza giuridica, con la conseguenza che il reato di costruzione in difetto di titolo edilizio dovrebbe ritenersi integrato anche quando: a) il vizio che inficia l’atto è tale da determinare la sua giuridica inesistenza, come nel caso dell’atto amministrativo nullo
7; b) l’atto amministrativo abilitativo non è riconducibile alla sfera del lecito giuridico e, quindi, appare frutto di un comportamento collusivo tra il soggetto che ha rilasciato il provvedimento abilitativo ed il beneficiario dello stesso oppure sia frutto di un’attività antigiuridica del soggetto richiedente il provvedimento abilitativo che abbia indotto in errore la pubblica amministrazione.
Sotto altro profilo, deve rammentarsi che in tutti i casi in cui appaia contestabile, in presenza di un titolo edilizio in ipotesi illegittimo, una delle fattispecie penali sopra esaminate, si pone il problema dell’effettiva riconoscibilità del dovere giuridico e quindi della consapevolezza dell’agente in ordine all’antigiuridicità del comportamento.
Al riguardo, si consideri che recentemente la Corte di Cassazione
8 ha affermato che: a) il rilascio di una concessione edilizia illegittima di poi annullata d’ufficio o su ricorso integra gli estremi di un atto illecito per violazione del principio del neminen laedere per avere tale atto con la sua apparente legittimità ingenerato nel suo destinatario l’incolpevole convincimento di poter legittimamente procedere all’edificazione del fondo; b) il titolare di un permesso di costruire ha il diritto di fare affidamento sulla legittimità dell’atto amministrativo e, quindi, sulla correttezza dell’azione amministrativa e può invocare la tutela risarcitoria avanti al giudice ordinario
9.
Ora, se il permesso di costruire con la sua “apparente legittimità” (leggasi: presunzione di legittimità) ingenera l’incolpevole convincimento di poter legittimamente procedere all’edificazione del fondo e se il titolare del permesso di costruire ha il diritto di fare affidamento sulla legittimità dell’atto amministrativo e sulla correttezza dell’azione amministrativa, può ragionevolmente ritenersi che la presenza di un titolo abilitativo debba di per sé escludere la sussistenza dell’elemento psicologico della contravvenzione edilizia, che pone a proprio fondamento l’illegittimità del titolo stesso, quantomeno quando la violazione della norma urbanistica non sia grossolana o macroscopica.
__________________
Note:
[1] Si confronti, anche per ulteriori riferimenti bibliografici: Cocco, L’atto amministrativo invalido elemento delle fattispecie penali, Cagliari, 1996; Durante, Il titolo edilizio al cospetto del giudice penale, in Rivista giuridica dell’edilizia, 2009, 4, 119; Gambardella, Il controllo del giudice penale sulla legalità amministrativa, Milano, 2002; Petrone, Attività amministrativa e controllo penale. Scritti, Milano, 2000; Pontis, I limiti del sindacato del giudice penale sulla autorizzazione amministrativa, in Responsabilità civile e previdenza, 2009, fasc. 2; Tanda, Attività amministrativa e sindacato del giudice civile e penale, Torino, 1999; Tripodi, La disapplicazione degli atti amministrativi da parte del giudice penale. Profili costituzionali, in Foro Amm., CdS, 2010, 2017.
[2] Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, 31 gennaio 1987, in Rivista giuridica dell’edilizia 1987, I, 328.
[3] Corte di Cassazione, Sezione Unite penali, 12 novembre 1993, in Rivista giuridica dell’edilizia, 1994, 405.
[4] Corte di Cassazione, III Sezione penale, 3 dicembre 2010, in Rivista giuridica dell’edilizia, 2011, I, 764.
[5] In questo senso si esprimeva la Corte Costituzionale nella sentenza n. 47 del 1979 in sede di scrutinio dell’art. 41, lett. b), della legge n. 1150 del 1942, con riferimento alla contravvenzione di inizio dei lavori senza licenza edilizia.
[6] A partire dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 la giurisprudenza costituzionale è costante nel ritenere che le norme della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) – nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo – integrano, quali norme interposte, il parametro costituzionale espresso dall’art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (cfr., da ultimo, la sentenza n. 236 del 19 luglio 2011).
[7] Vedi ora l’art. 21 septies della legge n. 241 del 1990, che ha codificato le ipotesi di nullità dell’atto amministrativo.
[8] Corte di Cassazione, Sezioni Uniti civili, 23 marzo 2011.
[9] La decisione appena esaminata della Corte di Cassazione ci riporta alla memoria le fondamentali argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 364 del 1988 sull’art. 5 c.p. e, segnatamente, quelle sull’errore inevitabile che può essere determinato, fra l’altro, da particolari, positive, circostanze di fatto in cui s’è formata la deliberazione criminosa, come, ad esempio, le “assicurazioni erronee” di persone istituzionalmente destinate a giudicare sui fatti da realizzare.
Pubblicato su Osservatorio AD il 16/11/2011





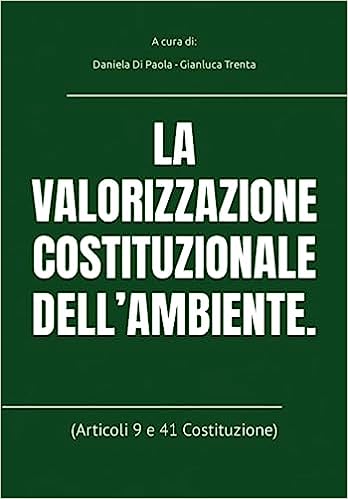
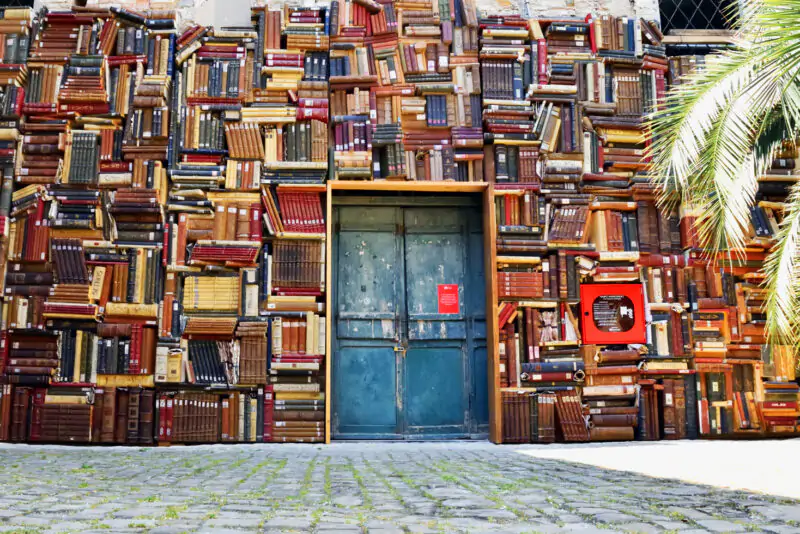 AMBIENTEDIRITTO.IT Casa Editrice
AMBIENTEDIRITTO.IT Casa Editrice